di Alfredo MONTAGNA - Sost. Proc. Gen. Corte di Cassazione
Il codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede, all’art. 176, relativo alle sanzioni penali previste per la violazione della parte seconda dello stesso decreto, relativo ai beni culturali, un‘ipotesi di delitto per chiunque si impossessi dei beni culturali appartenenti allo Stato[1].
La configurabilità di tale reato, molto spesso integrato (o ritenuto come integrato) in relazione a casistiche marginali quali il possesso ingiustificato di “cocci antichi”, ha diviso da sempre la giurisprudenza e la dottrina, sia sul versante dalle modalità di acquisizione della “culturalità” del bene che sotto quello del regime probatorio dell’esonero da responsabilità[2].
L’ultima decisione in materia della corte di cassazione consente oggi di fare il punto sulla questione, in quanto la terza sezione, nella pubblica udienza del 24 ottobre 2006 e depositata il 28 novembre 2006, n. 39109, Palombo, ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, di cui all'art. 176 del d. lgs 22 gennaio 2004 n. 42, non è necessario la preesistenza di un provvedimento che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico delle cose delle quali il privato sia trovato in possesso.
Una pronuncia che si pone in apparente contrasto con il più recente precedente della stessa sezione, che con decisione del 27 maggio 2004, dep. 2 luglio 2004, n. 28929, Mugnaini, in Rivista di polizia, 2005, v, 329, aveva ritenuto che per la configurabilità del reato di impossessamento di beni culturali, attualmente previsto dall'art. 176 del D.Lgs. n. 42 del 2004, a differenza delle disposizioni previgenti di cui all'art. 67 della legge n. 1089 del 1939 e all'art. 125 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, sarebbe necessario che i beni oggetto materiale del reato siano qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, in quanto rivestano un oggettivo interesse, che risulti eccezionale o particolarmente importante.
La conseguenza era che allorché si trattava di un bene mai denunziato all'autorità competente, doveva avere inizio, secondo la Corte, il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'art. 13 del citato D. Lgs. n. 42 del 2004.
La decisione Palombo riprende un precedente, e maggioritario orientamento, che, prima dell’entrata in vigore del cd codice Urbani, aveva più volte affermato che per la configurabilità del reato di cui all'art. 125 del decreto 490, non fosse necessario che i beni fossero stati qualificati come culturali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, e ciò in quanto era ritenuta sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto un particolare pregio per i beni culturali di cui all'art. 1, comma primo, del citato decreto n. 490. (in tal senso Cass. Sez. III 25 novembre 2003, dep. 16 dicembre 2003, n. 47922, Petroni [3]).
Un interesse culturale oggettivo che, secondo Cass. sez. III 14 novembre 2001, dep. 24 dicembre 2001, n. 45814, Cricelli [4], poteva essere desunto dalle caratteristiche della "res" non solo per il valore comunicativo spirituale, ma anche per requisiti peculiari attinenti alla “tipologia, alla localizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri”[5], e che inoltre, secondo Cass. Sez. III 6 novembre 2001, dep. 26 novembre 2001, n. 42291, Licciardello[6], non necessitava di una indagine tecnico-peritale, potendo risultare anche sulla base di quanto accertato e dichiarato dai competenti organi della pubblica amministrazione.
La individuazione della scelta interpretativa migliore non può che partire dal dettato normativo, come modificato dal richiamato codice Urbani; infatti l’art. 10 del d. lgs n. 42 qualifica quali “beni culturali”, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato (ed ad altri enti territoriali, persone giuridiche pubbliche e private) che “presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. I successivi commi 2 e 3 individuano poi gli altri beni qualificati culturali senza la dichiarazione prevista dal successivo art. 13, o a seguito di questa, ovvero della dichiarazione che “accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto”. Infine ai sensi dell’art. 91 le cose indicate nell’art. 10 appartengono allo Stato da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini [7].
Pur tuttavia la presunzione di culturalità che si ricava dal complesso normativo in questione può essere definita quale provvisoria, in quanto le cose ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, che appartengono allo Stato, sono sottoposte alle disposizioni in tema di beni culturali sino a quando non sia effettuata la verifica di culturalità prevista dall’art. 12 dello stesso decreto, al comma 2, soltanto all’esito della quale, se positiva, vi è la definitiva sottoposizione alle disposizioni in esame.
Da quanto sopra si ricava che, dopo la entrata in vigore del decreto n. 42 del 2004, il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato si verifica, in attesa della verifica di culturalità di cui all’art. 12, sin dal momento del loro fortuito ritrovamento, ma a condizione che presentino un almeno potenziale interesse culturale. La decisione Palombo appare così pienamente giustificata dal nuovo assetto normativo, che non richiede per la configurabilità del cd. furto d’arte la dichiarazione di culturalità (come erroneamente ritenuto nella decisione Mugnaini), ma semplicemente un “fumus di culturalità” che ne giustifica la tutela provvisoria in attesa della sua conferma, con l’accertamento di culturalità, o la sua definitiva liberalizzazione in caso opposto.
La riflessione si sposta pertanto sulle modalità di accertamento di tale potenziale interesse, ove appare rischioso affidare la giudice, caso per caso, anche se con l’ausilio di periti, la valutazione della rilevanza di oggetti che occorre sapere “contestualizzare” per non affidarsi al solo valore oggettivo; ma su tale punto non si è giunti, da parte del legislatore, ad un approdo definitivo, per si attende il decisivo contributo giurisprudenziale in merito.
Un contributo che si è già acquisito sul diverso versante del regime della prova della legittimità del possesso; infatti già nella citata decisione Mugnaini la prova della illegittima provenienza dei beni di interesse archeologico, al fine della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, anche nella formulazione dell'art. 176 del D. Lgs. n. 42 del 2004, non è a carico dell'imputato, ma della pubblica accusa.
Sul punto secondo Cass. Sez. III 16 marzo 2000, dep. 18 maggio 2000, n. 5714, Dulcimascolo [8], dal fatto che la legge 1089 del 1939 configurasse un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico, non poteva desumersi che i privati proprietari dovessero fornire la prova della legittimità della loro proprietà o del possesso; e ciò in quanto anche in materia di possesso di beni archeologici vigono le normali regole processuali secondo le quali l'onere della prova incombe sulla pubblica accusa ed il detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità della provenienza degli oggetti detenuti.
In tali situazioni concrete già fortemente indizianti, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato Cass. Sez. III 4 maggio 1999, dep. 7 giugno 1999, n. 7131, Cilia [9], che la omissione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può avere rilievo nel convincimento del giudice per la chiusura del costrutto probatorio. La stessa sentenza ha avuto modo di affermare altresì che se dal fatto che le disposizioni in materia, che accanto alla appartenenza allo Stato delle cose d'antichità e d'arte ritrovate prevedono un possesso privato di tali cose, si dovesse ricavare la clausola implicita che per i beni archeologici la proprietà privata è riconosciuta come tale solo se provata (e nella generalità dei casi di proprietà diffusa occorrerebbe provare che essa risale ad epoca anteriore al 1909), il sistema violerebbe sia l'art. 42 Cost., in quanto ablativo delle cose mobili di proprietà privata per la cui legittimazione richiederebbe una prova impossibile, sia l'art. 24 Cost. perchè, quando il possesso costituisce un addebito, la gravità dell'onere probatorio imposto renderebbe impossibile il diritto di difesa.
Il sistema, concludeva la Corte, non consente, se letto in aderenza ai precetti costituzionali, che venga posta a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di oggetti archeologici, ma è l'accusa che deve dare la prova della illegittimità del possesso, e su questo non può che esservi convinta adesione.
[1] Il testo prevede la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 31 a euro 516,50.
[2] In dottrina per un’ampia trattazione in merito G. Pioletti, Commento all’art. 176, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M. Cammelli, Bologna, 2004, Il Mulino, pag. 592.
[3] In Ced Cass. rv. 226870
[5] In applicazione di tale principio,la Corte ha nell’occasione ritenuto la sussistenza del reato con riferimento a giare create tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento e ritenute di interesse storico-etnologico sulla base di valutazione di merito congrua e come tale, insindacabile in sede di legittimità.
[7] Con la loro inclusione nel demanio o nel patrimonio indisponibile a seconda che si tratti di beni immobili o mobili
[8] In Ced Cass. rv. 216567, in fattispecie nella quale la Corte ha affermato che la illegittimità del possesso può essere desunta da altri elementi, quali la tipologia, la correlazione con riferimenti noti, la condizione delle cose che denunci il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso, ritenendo nel caso specifico la responsabilità dell'imputato per il numero degli oggetti, risalenti a prima di cristo, e per il loro pregio.
[9] In Ced Cass. rv. 213740, in una fattispecie relativa a furto archeologico in cui il ricorrente era stato trovato in possesso di monete e di oggetti metallici, in numero rilevante ed indifferenziato e con esclusione di oggetti fittili, già indizianti del rinvenimento mediante metal-detector, e la cui responsabilità è stata ritenuta legittimamente fondata sul comportamento tenuto nel corso della perquisizione e nella omissione di qualsiasi allegazione circa la legittimità del possesso, in presenza dei detti elementi indizianti.



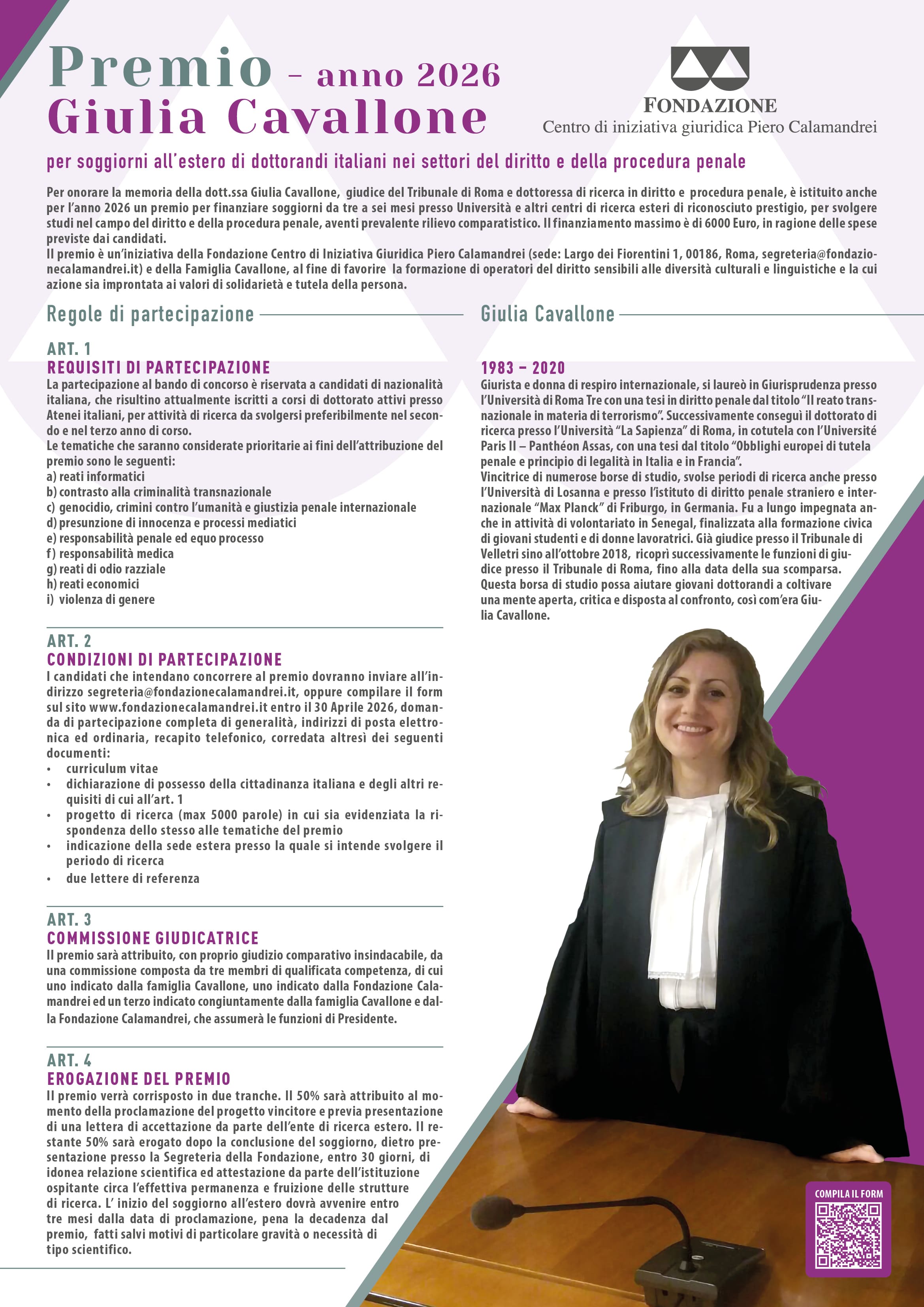 Scarica la locandina
Scarica la locandina

