 Cass. Sez. III n. 29230 del 7 agosto 2025 (UP 10 lug 2025)
Cass. Sez. III n. 29230 del 7 agosto 2025 (UP 10 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Colombara
Ecodelitti.Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e abusività della condotta
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ai fini della valutazione dell’abusività della condotta, in disparte l’ipotesi di attività svolta senza autorizzazione, ossia «clandestina», cui va equiparata l’ipotesi di «illiceità» o «illegittimità» del provvedimento autorizzativo, va considerata «abusiva» anche la condotta contra legem, ossia che si svolga in violazione della normativa di rango primario o secondario, ovvero di attività contra jus, ossia svolta in violazione della normativa tecnica di settore (come nel caso delle c.d. «BAT» o best available techniques e delle loro relative Conclusioni), ovvero ancora quella che si svolga in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito ad una valutazione unitaria della condotta che consideri l’aspetto temporale (continuatività dell’inosservanza), quantitativo (parte di attività svolta abusivamente rispetto a quella oggetto di autorizzazione) e qualitativo (natura sostanziale delle violazioni riscontrate).
PREMESSO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16/05/2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia del 20/07/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Colombara Gianpietro in relazione al capo c), essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta per il capo a) alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Colombara.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge meritatamente agli artt. 188, comma uno bis e 266, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 (TUA).
Ritiene fuori discussione che la società Colombara s.r.l. abbia svolto la sua attività sotto la vigenza dell’autorizzazione provinciale 4072/2013, che non è stata mai sospesa o revocata, la quale assentiva la facoltà di acquisire rifiuti provenienti da civili abitazioni e conferiti da privati, tra cui anche quelli contraddistinti dal codice CER 20 01 40, destinati a recupero.
Vigeva quindi la deroga di cui all’articolo 266, comma 5, d. lgs. 152/2006, relativa al commercio in forma ambulante dei rifiuti, non potendo certo una norma primaria essere contraddetta da una nota di chiarimenti della provincia, quale quella citata in sentenza. Pertanto censura la motivazione laddove, al fine di determinare la disciplina applicabile, ritiene prevalente la nota di chiarimento della Provincia di Venezia, la quale avvisava i gestori che il trasporto dei rifiuti verso i loro impianti non rientra nell’alveo della fattispecie ex art. 266, comma cinque, d.lgs. 152/2006, rispetto alla norma contenuta all’interno dello stesso decreto legislativo. In secondo luogo, il ricorrente ritiene che l’introduzione da parte dell’art. 30 della l. 28 dicembre 2015, n. 221 del comma 1-bis all’art. 188 d.lgs. n. 152/2006, corrobori la prevalenza della norma statale, e la sua applicabilità al fatto in questione in quanto nell’ultimo periodo si prevede che «[…] Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’art. 266, comma 5».
L’entrata in vigore del comma 1-bis dell’articolo 188 citato, successivamente al fatto per cui si procede, dimostra che la Corte di appello è ricaduta in errore laddove ha ritenuto che non fosse verosimile che la Colombara s.r.l. ignorasse la distinzione tra le autorizzazioni comunali necessarie per l’esercizio del commercio ambulante e quelle per il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione di rifiuti.
La liceità delle condotte della società si evince anche dalla consulenza tecnica del pubblico ministero, la quale ha ricordato che non solo l’art. 266, comma cinque, d.lgs. n. 152/2006 prevede una deroga esplicita, ma anche la comunicazione della Provincia di Venezia prot. 0087970 del 10 ottobre 2013, che consentiva sia ai privati cittadini che ai robivecchi a conferire e trasportare rifiuti in assenza delle specifiche autorizzazioni.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 198 e 208 d.lgs. n. 152/2006.
La difesa ritiene che la motivazione dei giudici di merito si ponga in contrasto con quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5257 del 29 maggio 2023.
Ed infatti, nel dichiarare l’illegittimità della prescrizione del 20/08/2018 emanata dal dirigente del settore ambiente della città metropolitana di Venezia, la sentenza del giudice amministrativo ribadisce che la Colombara s.r.l. fosse, ed è tutt’ora, legittimata a svolgere il recupero di rifiuti metallici, tra i quali rifiuti urbani e assimilati provenienti da utenze domestiche, senza la necessità di F.I.R. e senza che i mezzi di trasporto debbano essere iscritti al relativo Albo nazionale.
Nel caso in esame siamo al di fuori della c.d. «privativa comunale», che non si applica laddove i rifiuti urbani sono avviati a recupero e non a smaltimento (v. sent. Consiglio di Stato n. 5257/2023), per cui non è necessaria la presenza dei formulari di identificazione e l’attività può essere svolta senza iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione apparente rispetto alla determinazione del quantitativo di rifiuti che formano l’oggetto del capo di contestazione sub lett. a).
Il ricorrente lamenta il modo con il quale i giudici di merito hanno quantificato l’ammontare di rifiuti (470 tonnellate) abusivamente gestiti nell’arco temporale tra il 26 giugno 2014 e il 10 luglio 2014.
Nello specifico, la difesa si duole della superficialità con cui le sentenze abbiano stabilito il dato, senza che sulla determinazione sia intervenuta una prova testimoniale o documentale. Inoltre, in relazione alla mancanza di un esame testimoniale, si contestano i dati presenti nella relazione del c.t.p.m. (Dr. Ercoli, 13 giugno 2015) sia con riferimento al pervenimento di cento tonnellate di rifiuti metallici in una settimana provenienti da soggetti privati e ambulanti, sia in relazione alla stima che quantifica nel 76% sul totale dei rifiuti accettati dalla società di rifiuti provenienti dagli stessi soggetti nell’arco temporale oggetto di contestazione.
La difesa ritiene che tale superficialità nell’acquisizione di tali elementi sia inconciliabile su un thema decidendum così rilevanti, avendo contezza che è il quantitativo che determina la fattispecie ex art. 260 TUA, rispetto alla fattispecie contravvenzionale ex art. 256 TUA.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di legge derivante da vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha motivato adeguatamente rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 260 TUA
Nello specifico, si critica l’affermazione secondo cui la società Colombara s.r.l. abbia predisposto una struttura interna tale da integrare in modo sistematico il requisito delle «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti».
La difesa ritiene che la conclusione alla quale sono giunti i giudici di merito sia fallace e si ponga in contrasto con i dati offerti dalla realtà.
Su tutti, ha omesso di confrontarsi con la pronuncia del Tribunale monocratico di Venezia che, con sentenza 2414/2019, ha assolto il ricorrente dalla violazione ex art. 256 TUA perché il fatto non sussiste.
Inoltre, la Procura della Repubblica di Venezia non ha mai richiesto misure cautelari reali nel corso del processo e la Provincia di Venezia non ha mai sospeso o revocato l’autorizzazione ambientale nei confronti della società.
Ancora, dalle verifiche ed ispezioni svolte dagli organi di controllo nell’arco temporale tra il 2010 e il 2014, non sono mai state rilevate violazioni sistematiche della normativa ambientale.
Infine, la difesa rileva la completa assenza di motivazione in ordine al ruolo ricoperto dal ricorrente e all’animus delinquendi rispetto al reato ascrittogli.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa lamenta l’assenza di motivazione rispetto alla sussistenza dell’ingiusto profitto così come previsto dall’art. 260 TUA.
La difesa afferma una completa assenza di motivazione rispetto alle doglianze proposte con i motivi di appello rispetto ai ricavi medi conseguiti e al risparmio di spesa derivante dai costi sul corretto smaltimento dei rifiuti.
Il ricorrente richiede pertanto la derubricazione della fattispecie delittuosa a quella contravvenzionale prevista dall’art. 256 TUA.
2.6. Con il sesto ed ultimo motivo la difesa lamenta la violazione di legge e il conseguente vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione giuridica (operata con motivo nuovo n data 29 aprile 2024) dei fatti contestati sub art. 256 TUA.
Tale richiesta deriva dall’analisi dello svolgimento delle indagini preliminari, le quali si suddividono in tre fasi.
La prima comprende il periodo da fine gennaio a fine marzo 2014, dove vi sono state attività di osservazione controllo e pedinamento.
La seconda comprende il periodo dal 26 giugno al 10 luglio 2014, dove sono state monitorate le attività della società tramite l’installazione di telecamere.
La terza attiene alla giornata del 4 febbraio 2015 in cui è avvenuto un sopralluogo e un contestuale sequestro probatorio di rifiuti.
La difesa, operando un’analogia casistica con il reato di furto, ritiene che la fattispecie in questione si arresti ad uno stadio di tentativo in quanto il ricorrente è stato costantemente monitorato dalla p.g. e perciò non punibile per la consumazione del reato ex art. 260 TUA.
3. In data 23 giugno 2025 l’Avv. Gianluca Rizzardi, per l’imputato, depositava memoria a sostegno dei motivi già depositati in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito.
Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01).
In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).
Onere cui il ricorrente, come si vedrà nei paragrafi che seguono, non si è attenuto.
2. Ciò premesso debitamente, il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili.
3. In primo luogo, la doglianza è inammissibile per genericità in quanto non si confronta criticamente con la motivazione delle due sentenze, difettando così della necessaria specificità estrinseca.
Ed infatti, a sostegno della ritenuta assenza della condotta contestata, il ricorrente deduce la regolarità della fase di conferimento da parte dei sedicenti «ambulanti», mentre, secondo la concorde valutazione delle due pronunce di merito, la complessiva «gestione» dei rifiuti, anche successivamente al conferimento, avveniva con modalità contrarie sia alla disciplina normativa vigente che alle prescrizioni dell’autorizzazione.
3.1. Quanto alla prima sentenza, mentre il profilo oggetto di odierna censura viene trattato solo nel par. 4.3 (pag. 53 ss.), da pagina 10 si evidenzia che, nelle schede in cui erano stati riassunti gli esiti dei controlli visivi e tramite telecamera (che, essendo relativi ad un accertamento in punto di fatto, non sono suscettibili di rivalutazione in questa sede), i rifiuti conferiti (tra il 26 giugno e il 10 luglio 2014, nonché il 5 febbraio 2015), registrati in entrata con il codice CER 200140 (metalli) erano in realtà rifiuti misti contenenti anche plastica, legno, stoffa, RAEE, cavi elettrici, materassi con relative reti a doghe in legno, ruote di gomma, lubrificanti, bombole contenenti gas e così via, per cui si trattava di una attribuzione di codice CER falsa.
Tali rifiuti (v. pag. 38, C.T. Ercoli) venivano documentalmente fatti passare come sottoposti a cernita e trattati, mentre invece, come si evidenziava dai filmati, passavano - così mischiati - direttamente nelle cesoie e venivano poi indirizzati alla destinazione finale su due camion.
Che tale attività costituisse una prassi operativa imposta dalla società si evince dalla deposizione del teste Nalesso Luca (pag. 40 ss.), che la riferisce come operativa dal 2011.
3.1.1. Emerge quindi (così pag. 43-45 della prima sentenza) che l’attività concretamente svolta fosse posta in essere in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione n. 13054 del 15 febbraio 2007 e s.m. con cui si era autorizzato un impianto di selezione, cernita (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi (tra cui rifiuti urbani da avviare a recupero provenienti da civili abitazioni), R12EL (eliminazione delle frazioni estranee di rifiuti in ingresso), R12A (accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche), R12RV (riduzione volumetrica), R12DR (disimballaggio) e D15 (deposito preliminare per i rifiuti prodotti dall’attività di recupero della ditta), fra le quali spiccavano, per ciò che ai presenti fini interessa (pag. 45, con rinvio, contenuto a pag. 48, ai video relativi alle giornate del 26 giugno, 30 giugno e 4 luglio 2014):
- quella che imponeva la c.d. «caratterizzazione di base» del rifiuto;
- quella che vietava in modo assoluto di mischiare frazioni non omogenee di rifiuti diversi;
- quella che imponeva di stoccare, dopo tali operazioni, i rifiuti per frazioni omogenee, con gestione separata (v. anche pag. 48) delle frazioni insuscettibili di recupero;
- quella che vietava di accogliere RAEE.
3.1.2. La sentenza, inoltre, a pagina 50 e seguenti, sottolinea la violazione del regolamento UE n. 333 del 31/03/2011, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti metallici (la pronuncia evidenzia, sul punto, la presenza di emulsioni oleose in molti dei rifiuti metallici conferiti, in violazione della normativa di riferimento), con inottemperanza (v. pagg. 46 e 52) della prescrizione che imponeva la cernita con separazione delle frazioni destinate a recupero da quelle destinate a smaltimento, con attribuzione di separati codici CER appartenenti alla famiglia 19****.
3.1.3. Conclusivamente, a pagina 73, evidenzia in modo tanto chiaro quanto incontestato che la questione dell’applicabilità o meno dell’articolo 266 comma 5 del d. lgs. 152/2006 non afferisce «in alcun modo all’ulteriore profilo di analisi relativo alle procedure di recupero dei rifiuti conferiti, su cui si è del pari concentrata l’attenzione degli organi investigativi, tanto da far emergere, anche su tale versante, significative e pervasive violazioni del regime autorizzatorio in grado di determinare concreti rischi per l’ambiente», mentre a pagina 60, icasticamente, asserisce che le precedenti considerazioni consentono di individuare «una serie di multiformi profili di illiceità» che «rendono configurabile il requisito dell’abusività della condotta».
3.2. La seconda pronuncia, a sua volta, conferma tale impostazione, precisando (pag. 12) che i rifiuti conferiti, della natura più disparata, «non venivano affatto sottoposti a trattamenti diversi dalla pesatura, dal pedissequo deposito in un’unica area promiscua (diversamente da quanto espressamente prescritto circa la necessità di uno stoccaggio in zone distinte per tipologia del rifiuto) e, infine, dal successivo “adeguamento volumetrico”» (ossia la cesoiatura).
A pag. 13, poi, aggiunge che le prolungate osservazioni, «alle quali ha fatto seguito un diuturno monitoraggio video di quanto aveva effettivamente luogo nel piazzale dello stabilimento, non consentono di nutrire perplessità di sorta in ordine alla irregolare gestione dei rifiuti, trattati indiscriminatamente e, come detto, sottoposti alla sola attività di “adeguamento volumetrico”», circostanza confermata in occasione dell’accesso effettuato in data 4 febbraio 2015, cui ha preso parte lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero, il quale, in sede dibattimentale, ha efficacemente rievocato l’accadimento precisando che in tale occasione erano risultati «ammassati indiscriminatamente rifiuti di ogni tipologia» (ivi compresi: un tagliaerba completo di motore e con parti in plastica; un ventilatore completo; una tenda parasole; materiale isolante a base di roccia; pneumatici; un motore marino; un motore con filtro olio ancora montato; una plafoniera al neon; un radiatore in alluminio).
Evidenzia poi la Corte distrettuale il rinvenimento di RAEE, ossia rifiuti di componenti elettriche ed elettroniche (in inglese e-waste o WEEE, acronimo di Waste of Electric and Electronic equipment), che lo stabilimento non era autorizzato a ricevere, la cui presenza in loco costituisce accertamento in fatto insuscettibile di rivalutazione in questa sede.
Alle pagine 14-15, inoltre, a conferma della natura sistematica dell’attività illecita, la Corte territoriale riporta le dichiarazioni di uno dei conferitori ambulanti individuato dagli investigatori, tale Baù Johr, il quale aveva riferito di essersi limitato a firmare documenti già predisposti dalla Colombara srl, precisando che i rifiuti che conferiva, prelevati quali scarti di lavorazione da cantieri edili o idraulici (e quindi, quanto alla «origine», costituenti rifiuti «speciali» e non «urbani», raccolti in modo professionale dal conferitore, ciò che esclude a priori l’esistenza di una «privativa comunale» ex art. 198 d. lgs. 152/2006, come erroneamente dedotto dal ricorrente), non erano mai sottoposti ad alcuna verifica all’atto della accettazione, elemento che confermerebbe l’arbitraria attribuzione del codice CER 200140, sganciata da qualsivoglia concreta verifica della reale natura dei rifiuti conferiti all’impianto.
3.3. Da tali elementi risulta chiaramente che, al di là della questione concernente il conferimento dei rifiuti da parte di soggetti che il ricorrente definisce come «ambulanti», le due sentenze di merito hanno motivato congiuntamente in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato costituito dalla «abusività» della condotta.
L’assenza di tale elemento costitutivo era stata espressamente dedotta nell’atto di appello (par. 4.1, pag. 22, e pag. 32), con motivi non riproposti in sede di ricorso se non nei termini di cui alle premesse in fatto, ossia mediante contestazione dell’inapplicabilità della deroga di cui all’articolo 266 d. lgs. 152/2006.
La motivazione offerta sul punto dalle due sentenze va tuttavia (come meglio si vedrà nei paragrafi che segue) considerata unitariamente a quella relativa alla sussistenza degli altri elementi costitutivi del reato, e non atomisticamente (come se si trattasse di una «monade», avulsa dal contesto del reato).
3.4. In punto di diritto, il Collegio rammenta che, in disparte l’ipotesi di attività svolta senza autorizzazione, ossia «clandestina» (Sez. 3, n. 46029 del 06/11/2008, De Frenza, Rv. 241773 – 01; Sez. 3, n. 358 del 20/11/2007, dep. 2008, Putrone, Rv. 238559 - 01), cui va equiparata l’ipotesi di «illiceità» o «illegittimità» del provvedimento autorizzativo (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 33087 del 15/07/2021, Leo, n.m.; Sez. 3, n. 47959 del 21/07/2016, Rivoli, n.m.), va considerata «abusiva» anche la condotta contra legem, ossia che si svolga in violazione della normativa di rango primario o secondario (Sez. 3, n. 8299 del 25/11/2009, dep. 2010, Del Prete, n.m., secondo cui l’avverbio «abusivamente» si riferisce a tutte le attività, non conformi ai precisi dettati normativi, svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti «pericolosi e non», analiticamente disciplinato dalla normativa), ovvero di attività contra jus, ossia svolta in violazione della normativa tecnica di settore, come nel caso delle c.d. «BAT» o best available techniques (v. Sez. 3, n. 33089 del 15/07/2021, dep. 07/09/2021, Centro Servizi ambientali, Rv. 282101 – 01; Sez. 4, n. 39150 del 27/09/2022, dep. 18/10/2022, Centro Servizi Ambientali, Rv. 283734 – 01), nonché quella che si svolga in contrasto con le prescrizioni dell’autorizzazione.
Quanto a tale ultimo aspetto (espressamente richiamato dalla prima pronuncia a pag. 45, ove si indicano con precisione le prescrizioni disattese; a pag. 60, dove si menzionano sinteticamente i «multiformi profili di illiceità» che rendono configurabile il requisito della «abusività della condotta»; nonché a pag. 61, ove si pone l’accento sull’«elaborazione di vere e proprie regole di comportamento aziendali derogatorie rispetto al modello procedimentale imposto dall’autorizzazione, da adottarsi ogni qualvolta il conferimento venga operato da un soggetto che si dichiari privo dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali»), occorre precisare che, a fronte di isolate pronunce (Sez. 3, 18/11/2019, dep. 2020, n. 15274, Coratti, n.m.) che rimandano a risalenti arresti (v. Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013 - dep. 04/11/2013, Ghidoli, Rv. 25832601), peraltro richiamate dall’odierno ricorrente a pag. 32 dell’atto di appello, che richiedono una gestione «totalmente difforme» dall’attività autorizzata (probabilmente influenzate dalla contigua materia urbanistica, in cui la totale difformità è espressamente equiparata alla mancanza di autorizzazione sotto il profilo sanzionatorio), questa Corte ha in altre occasioni chiarito che il concetto di «abusività» non deve essere considerato isolatamente, bensì in correlazione con gli altri elementi costitutivi del reato (v. Sez. 3, n. 22459 del 20/03/2025, Varesano, n.m.), quali l’abitualità della condotta, l’ingenza dei quantitativi e la natura organizzata dell’attività.
Ciò determina che, sotto il profilo «quantitativo», l’attività svolta in violazione dell’autorizzazione non deve necessariamente essere «esclusiva», ben potendosi accompagnare ad attività lecita ed autorizzata (v. Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348, non massimata sul punto, secondo cui il reato può sussistere anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta; conf. Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Giommi, Rv. 251965; Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Servizi Costieri srl, Rv. 251965 – 01, secondo cui «la natura “abusiva” delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorché l’insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe stata consentita»), in relazione al requisito della natura «organizzata» dell’attività; sotto il profilo «temporale», il carattere abusivo di una attività organizzata di gestione dei rifiuti, tale da integrare il delitto, è configurabile quando si svolga «continuativamente» nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni (Sez. 3, n. 9133 del 13/01/2017, Giani, Rv. 269361 – 01, in cui l’abusività della condotta consisteva, come nel caso in esame, nella gestione dei rifiuti «senza la necessaria preventiva selezione e con attribuzione di codice fittizio»; Sez. 3, n. 47959 del 21/07/2016, Rivoli, n.m.; Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236294 - 01), in relazione al requisito della reiterazione della condotta; sotto il profilo «qualitativo» occorre che le prescrizioni violate non siano meramente «formali», ma «sostanziali» (Sez. 3, n. 358 del 20/11/2007, dep. 2008, cit., secondo cui «con il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 53-bis, il legislatore ha inteso colpire sia la gestione clandestina dell’attività di smaltimento sia quella svolta in difformità sostanziale dall’autorizzazione ricevuta»), anche per distinguere la condotta punibile ai sensi dell’articolo 452-quaterdecies da quella prevista dall’articolo 256, comma 4, d. lgs. 152/2006.
Coglie nel segno, a tal proposito, la relazione del Massimario della Corte sulla l. n. 68 del 2015, relativa ai c.d. «ecodelitti» (n. III/04/2015, p. 12), laddove riconosce il requisito della abusività della condotta «quando il suo esercizio si ponga, in concreto, in contrasto con i fini sostanziali che il titolo (e la norma) si prefigge ovvero con una norma diversa o con gli stessi principi generali dell’ordinamento: nel concetto di “abusivamente” dovrebbero dunque potersi ricomprendere anche le situazioni nelle quali l’attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo, il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzativo, ma anche quando l’attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all’autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i confini dell’esercizio lecito».
3.5. Ai fini della valutazione dell’abusività della condotta per violazione delle prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, occorre pertanto effettuare una valutazione unitaria che consideri l’aspetto «temporale» (continuatività dell’inosservanza), «quantitativo» (parte di attività svolta abusivamente rispetto a quella oggetto di autorizzazione) e «qualitativo» (natura formale o sostanziale delle violazioni riscontrate), valutazione che entrambi i giudici del merito hanno effettuato con motivazione priva di aporie, ritenendo che il conferimento di rifiuti misti anziché ferrosi (in violazione del relativo Regolamento UE), l’attribuzione di codice CER falso, l’omissione delle fasi di cernita e separazione e la triturazione di rifiuti misti successivamente avviati al destino finale senza avere effettuato le operazioni di recupero previste dall’autorizzazione, integrassero quella «abusività» della condotta richiesta dall’articolo 452-quaterdecies cod. pen., sia per violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione (v. supra, par. 3.1.1), che per violazione del Reg. UE n. 333 del 31/03/2011 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti metallici (c.d. End of waste, v. supra, par. 3.1.2.), abusività che il ricorrente – nel formulare le proprie doglianze - omette di contestare, così difettando, queste ultime, della necessaria specificità.
4. In secondo luogo, la doglianza è anche manifestamente infondata.
4.1. La prima sentenza, a pagina 5, chiarisce infatti in modo inequivoco (v. teste Di Candia) che, ad eccezione di due conferitori che erano effettivamente venditori ambulanti (sulla base normativa del commercio ambulante, nella regione Veneto, la prima sentenza si dilunga a pagina 55), tutti gli altri soggetti osservati conferire presso la Colombara s.r.l. erano persone che effettuavano abitualmente e professionalmente attività di raccolta di rifiuti presso officine e opifici vari e che, tuttavia, non risultavano iscritti all’Albo dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 (né lo erano i camion con cui conferivano), come previsto dall’articolo 188, comma 2, d. lgs. 152/2006.
Ciò esclude a priori la possibilità di applicare la deroga prevista dall’articolo 266, comma 5, d. lgs. 152/2006, secondo cui «le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio».
4.2. quanto al profilo intertemporale, contestato dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che, sia con riferimento alle condotte precedenti alla l. n. 221/2015 che successive, «in tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere e, con riguardo a quelli metallici, di condotte anteriori all’introduzione dell’art. 188, comma 1-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte della L. 28 dicembre 2015, n. 221, operando, per quelle successive, l’espressa esclusione dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 266, comma quinto, d.lgs. cit., ai fini dell’esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art. 266, comma quinto, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate» (Sez. 3, n. 35841 del 06/11/2020, Nunnari, n.m.; Sez. 3, n. 19153 del 22/11/2017, dep. 2018, Serio, n.m.; Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017, Tutone, Rv. 270226 – 01; Sez. 3, n. 23908 del 19/04/2016, Butera, Rv. 267019 – 01; Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014, Seferovic, Rv. 261959; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014, Lazzaro, Rv. 260266 Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015, Caccamo, Rv. 264822 – 01, la quale ha escluso l’operatività della deroga in relazione ad elettrodomestici in disuso, parti meccaniche di autovetture, pile ed accumulatori, trattandosi di rifiuti specificamente regolamentati), quali, per restare al caso in esame, i RAEE, disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che recepisce la Direttiva europea 2012/19/UE.
Per restare al caso in esame, dunque, mai i sedicenti «ambulanti» avrebbero potuto conferire rifiuti costituiti da RAEE avvalendosi della deroga prevista dall'art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto tale tipologia di rifiuti costituisce oggetto di autonoma disciplina normativa (Sez. 3, n. 19153 del 22/11/2017, dep. 2018, Serio, cit.).
Dal principio esposto si ricava che già nelle more della disciplina applicabile al momento in cui le condotte si sono svolte e a prescindere dall’intervento della l. 28 dicembre 2015, n. 221, fosse possibile ritenere la deroga espressa all’art. 266, comma 5, del d.lgs. 152/2006 andasse limitata alle ipotesi di conferimento da parte di privati cittadini e di ambulanti di rifiuti propri o connessi alla loro attività commerciale, con l’esclusione dunque – come riconosciuto in fatto nel caso in esame - di quelli raccolti professionalmente in assenza dei requisiti richiesti.
4.3. Ciò determina, di conseguenza, la manifesta infondatezza sia della presente censura che di quella relativa alla nota prot. n. 87970 del 10 ottobre 2013 della provincia di Venezia (che è chiaramente indicata, negli estremi e nei contenuti, a pagina 68 della prima sentenza), la quale, nel proporre un excursus della normativa applicabile, sposa l’indirizzo interpretativo sopra esposto, sottolineando che, anche in presenza di rifiuti domestici conferiti da privati, incombe sul titolare dell’impianto di recupero vigilare sui conferimenti e respingere i carichi che, per quantitativi e/o frequenze, presentino anomalie e si rivelino «non compatibili con il ristretto campo di operatività delle limitate deroghe previste dal testo unico ambientale» (pag. 73).
5. Da ultimo, va ribadita la sedimentata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Sez. 3, n. 5823 del 07/01/2016, Demaria, Rv. 265714 - 01), secondo cui la presenza dei presupposti di applicazione della deroga di cui all’articolo 266, comma 5, d. lgs. 152 del 2006, concretizzando un regime giuridico più favorevole, deve essere provata da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
Tale assunto costituisce espressione di un principio generale secondo cui «l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (Sez. 3, n. 24085 del 30/05/2024, Bonfà, n.m.; Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Burato, Rv. 284735 – 01; Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, Roncada, n.m.; Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, Busè, Rv. 252385 - 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, n.m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 - 01).
Il principio di inversione dell’onere della prova, in principio specificamente riferito al deposito temporaneo, è stato successivamente ritenuto «applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l’applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali» (v. Sez. 3^, n. 20410 del 08/02/2018 Rv. 273221 - 01 Boccaccio).
In tal senso infatti, già Sez. 3, sentenza n. 47262 dell’8/09/2016, Marinelli, n.m., aveva precisato che il principio dell’inversione dell’onere della prova corrisponde ad un «principio generale già applicato in giurisprudenza: in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 152/2006 (cfr. Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall’art. 258 comma 15 del d. lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone)».
Il principio è stato successivamente ribadito anche da Sez. 3, n. 3598 del 23/10/2018, dep. 2019, Fortuna, n.m..
Onere cui il ricorrente non si è attenuto, con conseguente inammissibilità, anche sotto tale profilo, della doglianza contenuta a pagina 15 del ricorso.
6. Va disattesa in quanto manifestamente infondata anche la deduzione difensiva contenuta a pagina 14 del ricorso, secondo cui la liceità della condotta dei conferitori deriverebbe dal combinato disposto degli articoli 266 e 188, comma 1-bis, d. lgs. 152/2006.
Oltre a quanto già evidenziato in relazione all’inapplicabilità della deroga di cui all’articolo 266 comma 5, il Collegio aggiunge che - al caso in esame - non è applicabile neppure il comma 1-bis dell’articolo 188, che nella formulazione vigente all’epoca dei fatti così recitava (il corsivo è del Collegio): «il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5».
Ed infatti, secondo la valutazione in fatto svolta concordemente dai giudici del merito (insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità), gli abusivi conferimenti non erano costituiti (solo) da rame e metalli ferrosi e non ferrosi, ma anche da rifiuti di diverse categorie merceologiche (v. par. 3.2), cui avrebbe dovuto essere assegnato altro codice CER, con conseguente inapplicabilità della disposizione invocata dal ricorrente.
7. La seconda doglianza è del pari inammissibile.
La circostanza che, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5257 del 29 maggio 2023, sia stato annullato il divieto per la Colombara S.r.l. di gestire rifiuti provenienti da utenze domestiche, non potendo le autorità locali applicare una «privativa» sulle attività di recupero oltre che di smaltimento dei rifiuti in mancanza di un’espressa prevista legislativa, correttamente la sentenza impugnata ha sottolineato (pag. 16) che essa non è pertinente ai fini del presente scrutinio.
Nel caso di specie, infatti, ad essere ritenuta illecita ed idonea ad integrare il reato ex art. 260 del d.lgs. 152/2006 (ora 452-quaterdecies cod. pen.) non è la gestione ex se di rifiuti provenienti da privati cittadini o ambulanti in assenza dei formulari di identificazione e trasporto e dell’iscrizione all’albo, ma la circostanza di fatto che i materiali conferiti dai sedicenti ambulanti, secondo gli accertamenti condotti, non fossero di natura «propria», ma costituissero il frutto di una raccolta professionale, in violazione delle disposizioni che la disciplinano, che (come si è visto nel par. 4) non fossero di origine esclusivamente domestica (o urbana) e che poi venissero «trattati» (o meglio «non» venissero trattati) in modo difforme a quanto autorizzato.
Il ricorrente, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, avrebbe in sostanza dissimulato la qualità professionale dei conferenti, equiparando tali conferimenti a quelli episodici provenienti da privati non esercenti attività imprenditoriale, omettendo il tracciamento dei rifiuti prescritto per legge.
La doglianza è quindi inammissibile per genericità in quanto non si confronta con le pronunce di merito.
Del pari inammissibile, per le ragioni già evidenziate al par. 3.2, è la censura relativa alla assenza della c.d. «privativa comunale» di cui all’articolo 198 d.lgs. 152/2006, che non si applicherebbe ai rifiuti urbani (ed assimilati) destinati a «recupero» anziché a «smaltimento» (come affermato dalla sentenza del consiglio di Stato n. 5257/2023), cui conseguirebbe l’assenza dell’obbligo di «tracciabilità» dei rifiuti in ingresso all’impianto, posto che i giudici del fatto hanno accertato il conferimento da parte dei sedicenti ambulanti anche (rectius: prevalentemente) di rifiuti speciali.
8. I motivi da tre a sei, che pertengono più squisitamente agli elementi costitutivi del reato, sono manifestamente infondati o inammissibili in quanto, oltre a quanto si rappresenterà specificamente nei paragrafi che seguono, essi costituiscono pedissequa reiterazione di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale e, prima di lei, dal Tribunale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217)
Se il motivo di ricorso si limita – infatti - a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).
Scendendo in concreto, la doglianza relativa alla dedotta assenza degli elementi costitutivi degli ingenti quantitativi era stata dedotta, nei medesimi termini, alle pagine 18 e 28-29 dell’atto di appello, quella relativa al profitto ingiusto alle pagine 18 e 20, quella sulla attività organizzata a pagina 33 e quella sulla dedotta assenza dell’elemento psicologico del reato a pagina 19.
Tutte tali censure erano state – come si vedrà nei paragrafi che seguono - motivatamente disattese dai giudici del merito.
9. Prima di procedere all’analisi delle singole censure, deve osservarsi che, secondo questa Corte (Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399 – 01, in motivazione), «i requisiti della condotta indicati dalla legge – compimento di più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti, quantitativo ingente di rifiuti e finalità di ingiusto profitto – vanno considerati unitariamente e non singolarmente».
Non è quindi possibile procedere – come vorrebbe il ricorrente - ad una analisi parcellizzata e atomistica dei vari elementi costitutivi, soprattutto per quanto concerne gli elementi oggettivi del reato, circostanza del resto evidenziata dalla prima sentenza a pagina 62 e dallo stesso ricorrente nell’atto di appello alle pagine 27 e 29.
10. Ciò premesso, la censura relativa al requisito degli «ingenti quantitativi», di cui il ricorrente sostiene la mancanza nel caso concreto, è inammissibile.
Va preliminarmente rammentato che questa Corte (Sez. 3, n. 358 del 20/11/2007, dep. 2008, Putrone, Rv. 238558 - 01), ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in relazione all’art. 25 Cost., per contrasto con i principi di determinatezza e tassatività della norma nella parte in cui l’individuazione dell’ingente quantitativo di rifiuti è rimessa al giudice e non è preventivamente individuata dal legislatore, essendo al contrario senz'altro possibile definire l'ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un contesto che consideri anche le finalità della norma, va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta
Di qui l’affermazione secondo cui l’ingente quantitativo non può essere individuato a priori, attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l’ambiente e nell’ambito del quale l’elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento (Sez. 3, n. 47229 del 6/11/2012, n.m.; Sez. 3, n. 46950 del 11/10/2016, Rv. 268667; Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Rv. 278531), e ciò in quanto (Sez. 6, n. 30373 del 18/03/2004, Ostuni, Rv. 229946 - 01) «nel testo della norma non si rinviene alcun dato che autorizzi a relativizzare il concetto, riportandone la determinazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti illecitamente gestiti e l’intero quantitativo di rifiuti trattati nella discarica, per cui l’ingente quantità dev’essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti», con la conseguenza che il rapporto tra i rifiuti lecitamente smaltiti e quelli trattati illecitamente nella discarica può essere valido semmai «(...) per stabilire se l’autorizzazione alla discarica sia un paravento predeterminato per un’attività ontologicamente diversa da quella autorizzata».
In altre occasioni si è affermato:
- che il requisito dell’ingente quantitativo deve essere valutato caso per caso, traendo elementi di comparazione anche dalle previsioni di reati contravvenzionali in tema di rifiuti e, soprattutto, considerando la specificità ed autonomia delle singole figure (Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005, dep. 2006, Samarati, Rv. 233293 - 01);
- che la nozione in esame è valutabile nella sua chiara locuzione come un «“cospicuo accumulo di rifiuti”, indipendentemente dall’effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti (Sez. 3, n. 45598 del 06/10/2005, Saretto, Rv. 232639 - 01)»;
- che l’ingente quantità «non può desumersi automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell’attività di gestione di rifiuti e che deve essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti» (Sez. 3, n. 30373 del 18/03/2004, Ostuni, cit.).
- che «ai fini dell’individuazione dell’ingente quantitativo di rifiuti trattati, la circostanza che si tratti di quantitativo ampiamente ricompreso nei limiti dell’autorizzazione non rileva quando la stessa autorizzazione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni, la mancata realizzazione delle quali non consente, in difetto di parametri di riferimento, proporzioni di sorta tra i rifiuti astrattamente autorizzati e quelli di fatto gestiti» (Sez. 3, n. 23347 del 14/05/2021, Conforti, n.m.).
La citata sentenza n. 47229/2012 ha conclusivamente affermato che la valutazione circa la sussistenza del requisito in parola costituisce un apprezzamento in fatto che è rimesso al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici.
La doglianza, che con tale sedimentato orientamento (peraltro debitamente richiamato dalla prima sentenza a pagina 62, laddove si motiva in ordine alla sussistenza del requisito) non si confronta, limitandosi ad una generica doglianza, è pertanto inammissibile, a fronte di un accertamento in fatto (basato, v. pag. 16 della sentenza di appello, sulla documentazione inerente la «pesatura» dei conferimenti, che ha portato a un calcolo di 470 tonnellate, che precisa che, anche in presenza di una parte di conferimenti «regolare», la natura diuturna e consistente consente di confermare la sussistenza del requisito in parola) intangibile in sede di legittimità.
11. La doglianza relativa all’assenza del requisito della sussistenza dell’«attività continuativa organizzata» è manifestamente infondata.
Il Collegio evidenzia in primis che tale locuzione non è isolata nel sistema penale.
L’articolo 474-ter c.p., infatti, prevede una aggravante quando i delitti di cui agli articoli 473 e 474, relativi alla contraffazione dei marchi, sono commessi «in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate», a riprova di una particolare attenzione del legislatore per quelle ipotesi di reato che per le loro concrete modalità di realizzazione presentano contiguità con il crimine organizzato.
Questa Corte – come già visto al par. 3 - ha, sullo specifico punto in esame, precisato (Sez. 3, n. 43710 del 23/05/2019, Gianino, Rv. 276937 - 01) che «non occorre che tutte le fasi di tale attività vengano svolte in forma organizzata e che in ogni fase vi sia la consapevolezza della partecipazione a una attività illecita e il fine di ingiusto profitto, essendo sufficiente, per poter ritenere configurabile il reato, che nell’ambito di detta complessiva attività, si inserisca la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, costituisca o si avvalga di una organizzazione allo scopo di realizzare un traffico continuativo e illegale di ingenti quantitativi di rifiuti. Non è necessario, dunque, che ogni fase della attività di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata e sia realizzata abusivamente (nel senso anzidetto) e a fine di ingiusto profitto, posto che ciò non è richiesto dalla norma incriminatrice, che, anzi, descrive, chiaramente in forma alternativa, le varie condotte che nell’ambito del ciclo di gestione possono assumere rilievo al fine della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti».
La prima sentenza, in proposito, a pagina 62, precisa che la sistematicità, correlata al profilo organizzativo, coinvolge, oltre alla fase di accettazione, anche le procedure di gestione dei rifiuti, perché dall’analisi dei video prodotti emerge che l’assenza di un’adeguata selezione dei componenti pericolosi o dei materiali inidonei al reimpiego – osservata per un apprezzabile lasso temporale - costituisce elemento qualificante di un ordinario modulo procedimentale che si reitera ad ogni conferimento con identiche modalità, valutazione confermata dai secondi giudici a pagina 16, dove menzionano un «flusso di scarti “irregolari” tanto consistente e continuo», attuato (sin dal 2011) «secondo un modulo procedimentale appositamente predisposto», valutazione sinteticamente confermata a pag. 16 della sentenza di appello, laddove parla di «sistematicità dell’attività di irregolare accettazione e gestione dei rifiuti oggetto di osservazione».
Tale asserto fa buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte, testé evidenziati, con cui il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre la doglianza come motivo di ricorso, con conseguente genericità della censura.
12. Del pari inammissibile è il motivo di ricorso relativo all’assenza dell’animus delinquendi in capo al ricorrente (pag. 25 ricorso), per le ragioni che si illustreranno più compiutamente nel paragrafo che segue, ove si dà atto che la condotta illecita ricostruita costituiva il frutto di una consapevole scelta imprenditoriale partorita dai vertici della Colombara s.r.l..
Va ricordato che, ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen., «non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi» (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 - 03), consapevolezza che l’imputato, in quanto legale rappresentante della società, sicuramente aveva, come esplicitamente conferma a pag. 61 della prima sentenza il teste Nalesso, laddove dichiara di avere ricevuto le istruzioni relative alle modalità di conferimento da parte degli «ambulanti», proprio dal Colombara, circostanza del tutto negletta dal ricorrente, con conseguente genericità della censura.
13. anche il motivo di ricorso relativo all’assenza del requisito dell’«ingiusto profitto» è inammissibile.
Va preliminarmente sottolineato che non è il profitto in sé a costituire elemento costitutivo del reato, bensì il «fine di conseguire un ingiusto profitto»: l’ingiusta locupletazione colora in tal modo l’elemento psicologico del reato; la relativa indagine, pertanto, non deve attestarsi sul conseguimento o meno del profitto, necessario solo al fine dell’eventuale confisca, bensì sulla tensione dell’azione al suo conseguimento.
Tale osservazione preliminare basterebbe a consentire di dichiarare inammissibile la censura proposta per genericità.
Va tuttavia aggiunto che essa è anche manifestamente infondata.
Come efficacemente affermato da questa Sezione (Sez. 3, n. 35118 del 29/05/2024, Chiocchio, n.m.), infatti, «il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato della condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose».
Ciò posto, in termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707 - 01).
Esso può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare, Rv. 212080 - 01; nel senso che il profitto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore, Sez. U. n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01; in quest’ultimo senso, già Sez. U, n. 506 del 12/04/1961, Stanzani, Rv. 098642 - 01).
Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 - 01; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01); può essere di tipo "accrescitivo"(Sez. U, Lucci, cit.; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01) ma può consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117 – 01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 - 01).
Profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia
soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700 - 01).
Applicando questi principi, la giurisprudenza ha affermato che il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 - 02, secondo cui il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi “doverosi”, non sopportati in ragione dell’illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità
logica; nello stesso senso, Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236907 - 01), ovvero in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniale (Sez. 3, Carretta, cit.; Sez. 3, n. 5316 del 28/06/2017, Vacca, Rv. 272097 - 01, la quale ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale; per Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399 - 01, il profitto può consistere anche nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda; nello stesso senso Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845 - 01; Sez. 3, Fradella, cit.).
Il carattere ingiusto del profitto non deriva pertanto dal quomodo dell’esercizio (abusivo) dell’attività (altrimenti la sua previsione sarebbe del tutto pleonastica; in questo senso, vigente l’art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, già Sez. 3, n. 45598 del 06/10/2005, Saretto, Rv. 232639), bensì dal fatto che l’intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi altrimenti non dovuti (cfr. sul punto Sez. 3, n. 45598 del 2005, cit., secondo cui il requisito dell’ingiusto profitto va meglio riconsiderato sotto il profilo che costituisce un ingiusto profitto, non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni – come nel caso in esame - dei codici tipologici).
L’ingiustizia del profitto evoca, in questo caso, un concetto di relazione che gli deriva dal confronto con quello normalmente conseguito a seguito dell’esercizio lecito dell’attività, sì da rendere l’attività illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale e/o maggiormente redditizia non solo per chi la propone, ma anche per chi ne usufruisce (il mercato).
Di tali principi ha fatto buon governo la sentenza impugnata laddove, a pag. 17, nel ribadire quanto affermato dalla sentenza del Tribunale a pagina 63, evidenzia che «in ragione della sistematicità dell’attività di scorretto smaltimento dei rifiuti, sottratti alla doverosa cernita ed al conseguente, corretto trattamento/smaltimento, è giocoforza concludere, sul piano della logica più elementare, nel senso del ricorrere, per effetto di una determinazione operativa da ascriversi ai livelli societari apicali, di un consistente, ancorché non quantificato né quantificabile, risparmio di spesa (Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, Savoia, Rv. 271138 – 01), risparmio conseguente, per l’appunto, all’adozione di una modalità di gestione dei rifiuti sottratta alle impegnative (e quindi inevitabilmente costose) procedure di legge».
Il riferimento è, in tutta evidenza, ai costi che sarebbero stati sostenuti dalla Colombara ove fosse stata correttamente eseguita la cernita dei rifiuti (eterogenei) conferiti, con conseguente sostenimento delle spese di smaltimento di quelli non avviabili a recupero, con conseguente risparmio di spesa, non quantificabile né quantificato.
Del pari, la prima sentenza, a pag. 73, laddove evidenzia che le procedure di recupero concretamente seguite dall’azienda fanno emergere «significative e pervasive violazioni del regime autorizzatorio» (sulla cui rilevanza in termini di abusività della condotta si è già detto) tali da «determinare concreti rischi per l’ambiente», richiama quella giurisprudenza (Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399 – 01) secondo cui il profitto è «ingiusto» qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti.
Il ricorso, anche in questo caso, si limita a reiterare la doglianza sollevata con l’atto di appello senza contestare specificamente le ragioni a fondamento delle due sentenze di merito.
14. La censura relativa alla richiesta di riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all’articolo 256 d. lgs. 152 del 2006 è del pari inammissibile.
Essa costituisce infatti pedissequa reiterazione di analoga censura dedotta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata a pagina 16, ove si evidenzia che la prolungata osservazione dell’attività illecita la decisione di intervenire all’esito di un monitoraggio posto in essere per un congruo lasso di tempo non appare certamente sindacabile.
Inoltre, a pagina 63 della prima sentenza si evidenzia, in aggiunta a quando sopra evidenziato circa la reiterazione di un modulo procedimentale illecito, che il video documenta tale attività per il periodo dal 26 giugno al 10 luglio 2014, ma analoga situazione era stata osservata durante i servizi OCP del febbraio 2014 e in occasione del sopralluogo del 2015; inoltre, il teste Nalesso (v. supra), conferma che la prassi di ricevere dagli «ambulanti» i rifiuti era vigente dal 2011. A pagina 75 aggiunge, poi, che l’attività di osservazione ha permesso di «porre una lente di ingrandimento» su una realtà che si è reiterata per anni seguendo lo stesso modus comportamentale, come si evince dalle dichiarazioni del teste Nalesso.
Ove a ciò si aggiunga quanto in narrativa evidenziato circa i quantitativi di rifiuti e l’organizzazione continuativa di mezzi e attività, emerge con chiarezza la genericità della doglianza, che, proponendo una visione atomistica e parcellizzata dei vari elementi costitutivi del reato (v. supra, par. 9), omette di confrontarsi criticamente con la chiara motivazione delle due sentenze, difettando così della necessaria specificità.
15. L’inammissibilità della precedente doglianza determina anche la manifesta infondatezza della censura relativa alla maturata prescrizione del reato, ove riqualificato ut supra come contravvenzione.
16. Quanto alla ritenuta sussistenza del reato in forma tentata, la doglianza è del pari inammissibile e costituisce anch’essa pedissequa reiterazione di analoga censura dedotta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata a pagina 16.
Come noto, il delitto in parola costituisce reato «abituale» (v., ex multis, Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605 – 01; Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920 – 01; Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395 - 02) che sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale, per cui «alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie» (Sez. 3, n. 2284 del 28/11/2017, dep. 2018, Benedetti, Rv. 272798 - 01; Sez. 3, n. 29619 dell’8/7/2010, Leorati, Rv. 248145).
Esso, in particolare, è reato «necessariamente abituale», il quale richiede nella configurazione della condotta la reiterazione intervallata di più condotte che vengono valutate unitariamente come una unica condotta illecita.
Come evidenziato in dottrina, in relazione alla reiterazione della condotta è possibile poi distinguere tra reato necessariamente abituale «proprio», quando esso consiste in ripetizioni di condotte in sé non punibili o eventualmente punibili (per mancanza di condizione di procedibilità, ad esempio), ovvero «improprio», quando consiste in ripetizioni di condotte in sé punibili, costituendo di per sé reati, ma che vengono valutati unitariamente come un fatto illecito autonomo con un diverso disvalore complessivo.
Il delitto in parola, in tale sistema, è peculiare: da un lato, infatti, non è necessaria la reiterazione della medesima condotta, essendo possibile che essa comporti l’effettuazione «abusiva» (in tutto o in parte) di diverse fasi della gestione dei rifiuti; dall’altro, per perfezionare il reato la mera reiterazione di condotte non è sufficiente, dovendo essere integrata dagli ulteriori requisiti dell’allestimento di mezzi, dalle attività continuative organizzate e dall’ingente quantitativo di rifiuti.
La citata dottrina, che qualifica il delitto in parola come «reato abituale in forma variabile», ritiene che il tentativo sarebbe configurabile:
- quando il reato si manifesta con una sola attività di gestione, accompagnata da allestimento dei mezzi, organizzazione continuativa finalizzata alla gestione e ingenti quantitativi;
- quando il reato si manifesta con plurime attività di gestione, ma in difetto di (alternativamente o congiuntamente) allestimento dei mezzi, organizzazione continuativa finalizzata alla gestione e ingenti quantitativi.
In questi casi, «le condotte poste in essere sono da qualificare “atti idonei diretti in modo non equivoco alla gestione abusiva”, se questa per ragioni indipendenti dall’autore non si realizza».
Tale ricostruzione dogmatica merita di essere confermata dal Collegio; tuttavia, in concreto, nessuna delle due ipotesi si è verificata nel caso di specie, in cui i giudici del merito hanno accertato in punto di fatto la perfezione del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, per un lungo lasso di tempo (almeno dal 2011).
Il motivo è pertanto inammissibile.
17. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2025.



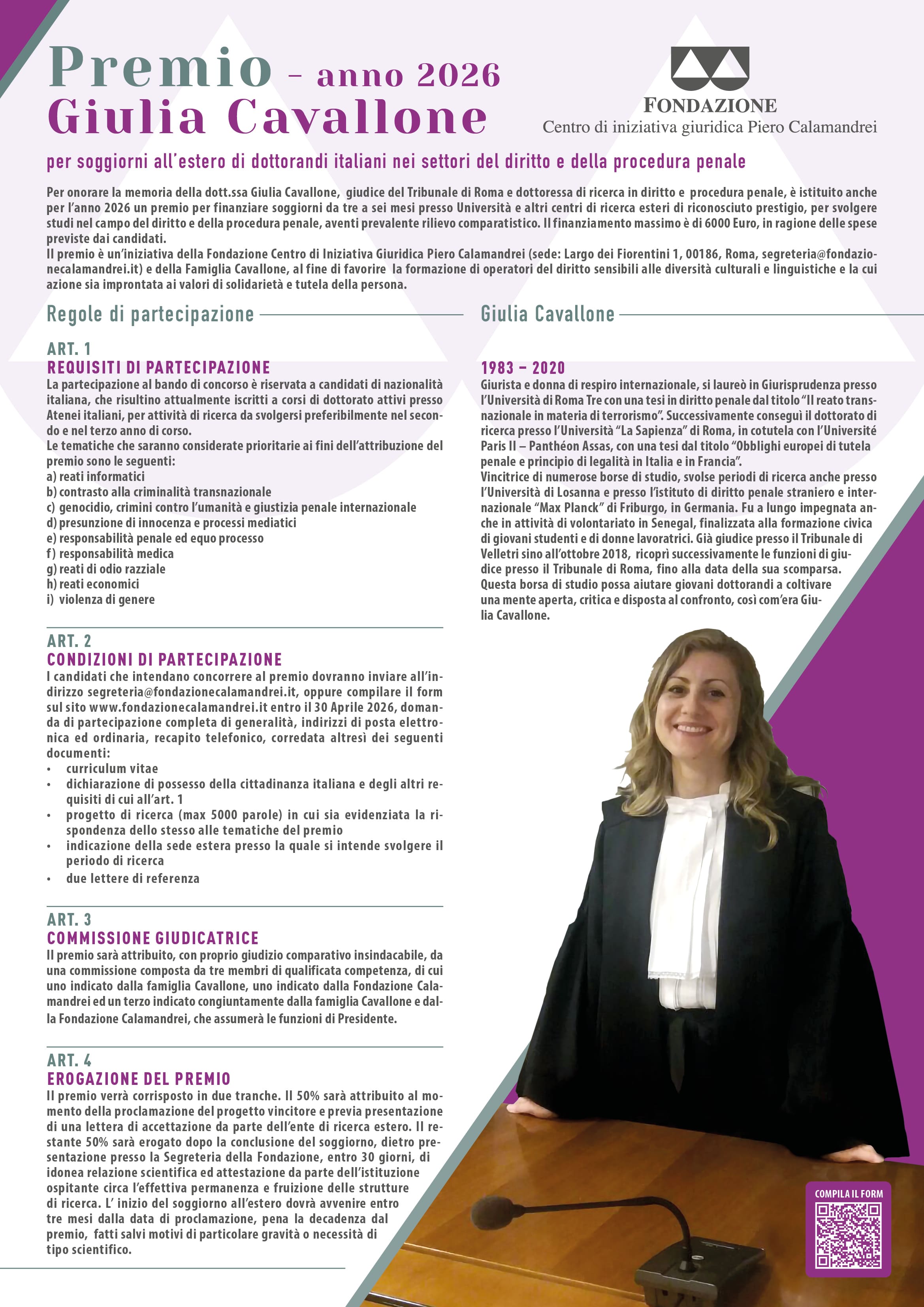 Scarica la locandina
Scarica la locandina

