 Consiglio di Stato Sez. IV n. 5926 del 8 luglio 2025
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5926 del 8 luglio 2025
Beni ambientali.Piano paesaggistico
Se la funzione del piano paesaggistico è quella di introdurre un organico sistema di regole, sottoponendo il territorio regionale a una specifica normativa d'uso in funzione dei valori tutelati, ne deriva che, con riferimento a determinate aree, e a prescindere dalla qualificazione dell'opera, il piano possa prevedere anche divieti assoluti di intervento. La possibilità di introdurre divieti assoluti di intervento e trasformazione del territorio appare, d'altronde, del tutto conforme al ruolo attribuito al piano paesaggistico dagli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali, secondo cui le previsioni del piano sono cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore e vincolanti per i piani, i programmi e i progetti nazionale e regionali di sviluppo economico. Questa interpretazione risulta suffragata dall’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 che, nel dettare la disciplina di coordinamento fra i diversi strumenti di pianificazione, ha disposto che quello paesaggistico risulta “prevalente” anche sulle disposizioni eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici, così confermando la possibile interferenza e antinomia fra disposizioni regolatorie di natura differente, come quelle che dispongano per interessi di conservazione dell’interesse paesaggistico limiti di trasformazione ed edificabilià al bene immobile tutelato e quelle di natura urbanistica che ne avessero invece previsto l’astratta potenzialità edificatoria.
Pubblicato il 08/07/2025
N. 05926/2025REG.PROV.COLL.
N. 05960/2023 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5960 del 2023, proposto dalla società Mige s.a.s. di Salati Angelo & C. e della società Salati Armando s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Grassi e Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Grassi in Roma, piazza Barberini 12;
contro
la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;
il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del Comune di Orbetello e della Provincia di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 1530 del 27 dicembre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e di Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalle società società MIGE s.a.s. di Angelo Salati & C. e società Salati Armando s.p.a. avverso la sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 1530/2024 che ha respinto il ricorso di primo grado.
2. Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione, da parte della società MIGE s.a.s. di Angelo Salati & C. e società Salati Armando s.p.a.:
i. della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana 2 luglio 2014, n. 58, “Integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”;
ii. della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana 27 marzo 2015, n. 37, di “Atto Integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”;
iii. della delibera della Giunta regionale della Regione Toscana n. 1121 del 4 dicembre 2014, con cui è stata approvata l'istruttoria tecnica delle osservazioni presentate al PIT/PPR adottato e le conseguenti proposte di modifica all'integrazione paesaggistica del PIT.
Gli atti suindicati sono impugnati dalle due società odierne appellanti nella parte in cui impediscono l’attuazione delle previsioni urbanistiche già approvate dal Comune di Orbetello sulle aree di loro proprietà e, quindi, le possibilità di sviluppo edilizio dei complessi immobiliari.
3. Si espongono, in sintesi, i fatti rilevanti per la decisione.
3.1. La MIGE s.a.s. di A. Salati & C. è proprietaria di un vasto comprensorio di terreno siti in località Giannella nel territorio del Comune di Orbetello e rientrante nell’U.T.O.E. n. 4 del relativo Piano Strutturale.
Il regolamento urbanistico del Comune di Orbetello adottato con deliberazione del consiglio comunale del 12 aprile 2010, n. 26 prevedeva, con riferimento a detto ambito, tre aree di trasformazione, costituite:
i. dall’At24 (destinata all’ampliamento dell’albergo “Lido di Giannella” esistente, mediante intervento diretto soggetto a permesso di costruire),
ii. dall’At25 (destinata alla realizzazione di un nuovo “imbarcadero”),
iii. dall’At26 (destinata alla realizzazione di servizi ed attrezzature per lo sport ed il tempo libero e di un intervento di completamento di trenta alloggi, subordinato alla realizzazione dell’intervento At24).
3.2. Con la deliberazione 2 luglio 2014, n. 58 del Consiglio regionale della Regione Toscana, è stata adottata l’integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico.
4. Ritenendola lesiva dei suoi interessi, con il ricorso incardinato con il n.r.g. 1819/2014, la società MIGE ha impugnato il provvedimento, nei limiti del suo interesse innanzi al T.a.r. per la Toscana.
4.1. Con il ricorso n.r.g. 1820/2014, anche la società Salati Armando s.p.a. (proprietaria di terreni inclusi nell’area di trasformazione At26 del regolamento urbanistico del Comune di Orbetello adottato con la deliberazione di consiglio comunale del 12 aprile 2010, n. 26 sopra richiamata) ha impugnato la deliberazione 2 luglio 2014, n. 58 del Consiglio regionale della Toscana destinata all’adozione dell’integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico, articolando censura analoghe a quelle poste a base del ricorso R.G. n. 1819/2014 dalla società MIGE.
4.2. Nei relativi giudizi, si sono costituiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, resistendo ai ricorsi.
4.3. Con le ordinanze Presidenziali 12 febbraio 2021, nn. 43 e 44, sono state richieste alle parti informazioni in ordine alla persistenza dell’interesse alla decisione dei ricorsi.
4.4. In ambedue i ricorsi, le società ricorrenti hanno dichiarato di avere interesse alla decisione dei ricorsi a fini risarcitori e hanno domandato, pertanto, la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 34, 3° comma c.p.a..
4.5. Nel corso del procedimento di approvazione, la società ricorrente ha presentato l’osservazione n. 135, che è stata parzialmente accolta dalla deliberazione 4 dicembre 2014, n. 1121 della Giunta regionale.
4.6. Con la successiva deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana 27 marzo 2014, n. 37, si è approvato definitivamente l’atto di integrazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico, con conferma definitiva, salvo alcune modifiche, della disciplina vincolistica contestata dalle società ricorrenti.
4.7. Con il ricorso n.r.g. 1226/2015, la società MIGE ha impugnato anche questo provvedimento innanzi al T.a.r. per la Toscana, proponendo, sostanzialmente, le medesime censure già articolate nel ricorso n.r.g. 1819/2014 e, in aggiunta, una nuova censura di violazione dell’art. 144 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 19 della l.r. 65/2014 (già art. 17 della l.r. 1/2005), violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, illogicità ed irrazionalità manifeste, indirizzata al mancato recepimento dell’integralità delle proprie osservazioni.
Analogamente si è determinata la società Salati Armando s.p.a., che ha proposto il ricorso n.r.g. 1227/2015, proponendo censure sostanzialmente analoghe a quelle proposte dalla società MIGE, con il ricorso n.r.g. 1226/2015.
4.8. Nell’ambito di questi giudizi, si sono costituiti, nuovamente, i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, resistendo ai ricorsi.
5. Con la sentenza n. 1530/2022, il T.a.r.:
i. ha riunito i ricorsi proposti dalla società MIGE con i due ricorsi proposti dalla società Salati Armando s.p.a. avverso i medesimi provvedimenti, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;
ii. ha respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità sopravvenuta dei gravami proposti dalle due società avverso il provvedimento di adozione del Piano, essendo stata formulata da parte loro la domanda di accertamento di illegittimità di questi atti ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a.;
iii. ha respinto i quattro ricorsi proposti dalle due società avverso i provvedimenti di adozione e di approvazione del Piano;
iv. ha condannato ciascuna delle ricorrenti alla corresponsione all’Amministrazione regionale della complessiva somma di € 3.000,00.
6. Le due società hanno congiuntamente proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
6.1. Si è costituti in giudizio la Regione Toscana, resistendo al gravame e formulando l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità delle censure articolate nei ricorsi introduttivi, in quanto “espressione di inammissibili considerazioni di merito”.
6.2. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
7. All’udienza del 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In limine litis, in applicazione del criterio della ragione più liquida, il Collegio ritiene che non sia necessario procedere alla disamina dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello, formulata dalla Regione Toscana, bensì che si possano esaminare direttamente i motivi di impugnazione, essendone palese la loro infondatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.).
9. Con il primo motivo di appello, le società deducono che la pronuncia impugnata non sarebbe corretta e meriterebbe di essere riformata, per aver respinto il primo ed il secondo motivo dei ricorsi avverso l’adozione del Piano, nonché il secondo motivo dei ricorsi proposti avverso l’approvazione, affermando la legittimità del PIT/PPR, nella parte in cui ha imposto vincoli e prescrizioni sull’area della Giannella, al punto da impedire qualsiasi intervento, senza lasciare spazio alle previsioni urbanistiche locali.
Si evidenzia che, con i ricorsi in primo grado, si è censurato il PIT/PPR perché avrebbe introdotto, sin dal livello paesaggistico, una rigida disciplina d’uso dell’area della Giannella, che impedisce qualsiasi intervento edilizio nella zona, in contrasto con le finalità di recupero e riqualificazione del territorio (I motivo) e, sempre sin dal livello paesaggistico, una disciplina talmente dettagliata da non lasciare alcun margine di intervento alla disciplina del territorio già vigente a livello comunale né tantomeno a quella successiva al PIT/PPR (II motivo).
La sentenza del T.a.r. sarebbe viziata per difetto di motivazione, essendosi limitata ad aderire alle difese della Regione Toscana, mentre avrebbe dovuto rilevare come la Regione non avesse operato un corretto bilanciamento tra la tutela paesaggistica e la necessità – prima del PIT/PPR riconosciuta anche dal Comune attraverso le richiamate aree di trasformazione At 25 e At 26 – di riqualificazione dell’area.
Si deduce, in proposito, che l’area della Giannella, per essere effettivamente tutelata, non necessitava di una disciplina volta alla mera conservazione dello status quo, ma di interventi volti a recuperare la bellezza e la fruibilità del contesto paesaggistico, discendendone, perciò, l’irragionevolezza delle prescrizioni approvate con lo strumento di pianificazione, che vengono enumerate nell’appello.
Si deduce che tali previsioni, eccessivamente di dettaglio e imposte sin dal livello paesaggistico violerebbero gli articoli 135, comma 4 (in particolare, lettere b, c, d), e 143, comma 1 (in particolare, lettere g, h, i), del d.lgs. n. 42/2004, nonché l’art. 48, commi 3 e 6 Legge regione Toscana n. 1/2005 all’epoca vigente, in quanto tali norme “non legittimano sempre e comunque anche divieti assoluti di specie in zone, come la Giannella, che necessitano di riqualificazione e completamento.”.
Si rincara la censura rilevando che lo scopo del Piano non può essere quello di ostacolare gli interventi nelle aree considerate paesaggisticamente sensibili o, addirittura, in interi ambiti territoriali, bensì indicare i criteri e i principi per consentire il corretto inserimento degli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio.
Si ritiene, inoltre, che la censura così formulata sarebbe corroborata anche da quanto previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, richiamata sin dagli atti introduttivi del contenzioso.
Si sintetizza l’articolato motivo di appello, chiosando, infine, che il Piano paesaggistico non può essere eccessivamente di dettaglio, giungendo, in sostanza, ad equivalere ad uno strumento urbanistico di livello locale (“cosa che – secondo le appellanti - peraltro è avvenuta: con i ricorsi attualmente pendenti dinanzi al TAR Toscana, r.g. nn. 983, 984/2022 le società del Gruppo Salati hanno impugnato il nuovo Piano Strutturale del Comune di Orbetello che contiene dei veri e propri copia/incolla di intere sezioni del PIT/PPR, qui impugnato”) e ad adoperare “concetti appartenenti più al campo dell’edilizia o comunque del diritto privato che a quello dell’urbanistica (soprattutto con riguardo alla tutela paesaggistica)”.
Si evidenzia, infine, che “le “restrizioni” della libertà di iniziativa imprenditoriale operate attraverso il piano paesaggistico (pag. 10 della sentenza impugnata) seppur in tesi possibili, non potranno legittimamente coincidere con un sostanziale azzeramento di tali facoltà, senza incorrere nel vizio di manifesta illogicità e irragionevolezza.”.
9.1. Con il secondo motivo di appello, le società appellanti deducono che la sentenza impugnata non sarebbe corretta e meriterebbe di essere riformata nella parte in cui ha respinto gli equivalenti primi motivi dei ricorsi di primo grado, ritenendo le censure proposte avverso le previsioni della Scheda 10 del PIT/PPR non sindacabili, perché finalizzate a sostituire le scelte discrezionali della Regione Toscana con quelle delle ricorrenti.
Si evidenzia per contro che le doglianze di primo grado erano incentrate ad evidenziare la mancanza di ragionevolezza delle norme di piano impugnate, perché eccessivamente e senza motivo restrittive.
Per le appellanti, l’art. 48, commi 3 e 6, della legge della Regione Toscana n. 1/2005 chiarisce che la finalità del PIT è quella di delineare “la strategia dello sviluppo territoriale”, individuando gli “obiettivi del governo del territorio e delle azioni conseguenti” e le “azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali” (comma 3). Il comma 6, prevedendo l’obbligo per la pianificazione territoriale comunale e provinciale di adeguarsi al PIT, il che confermerebbe la necessità che quest’ultimo non rechi previsioni eccessivamente dettagliate, perché altrimenti non residuerebbe alcuno spazio di intervento per gli Enti Locali e i due strumenti di pianificazione finirebbero sostanzialmente per coincidere.
9.2. Il primo e il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione oggettiva e in quanto sono comuni le ragioni di fatto e di diritto che depongono per la loro infondatezza.
9.3. Al fine di decidere i motivi di appello in esame, giova muovere dalla considerazione che già a partire dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, che ha convertito con modificazioni il d.l. 27 giugno 1985 n. 312, il concetto di tutela del paesaggio investe non soltanto singole realtà o beni di pregio estetico (art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497), ma aree più ampie, comprensive di ambiti territoriali per categorie di beni o per zone, sicché l’oggetto della tutela si è ampliato anche verso valori culturali e “paesistici” globalmente considerati, rispetto ad una serie di contesti o situazioni territoriali tipizzati che si caratterizzano per la loro ampiezza spaziale e per l’eterogeneità di situazioni considerate (Corte cost., 21 dicembre 1985 n. 359 e nn. 359/1985; 27 giugno 1986 n. 153).
Sul versante degli strumenti di tutela, questo conseguito ampliamento della tutela paesaggistica si è accompagnato, dapprima, sempre ad opera delle legge n. 431/1985, con la “riattivazione” della funzione pianificatoria, già prevista dall’art. 5 della legge n. 1497/1939, ma di scarsa utilizzazione nella pratica amministrativa, e, successivamente, ad opera del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dai d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157 e, in particolare, dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, con l’affiancamento al momento “statico”, di individuazione del bene paesaggisticamente rilevante (da parte del provvedimento puntuale [ai sensi degli artt. 136 e ss.], della legge [art. 142] o dello strumento di pianificazione [art. 143, comma 1, lett. d]), di un momento “dinamico” di individuazione delle prescrizioni d’uso collegate al vincolo derivante dall’interesse paesaggistico consustanziale al bene (la c.d. “vestizione del vincolo”).
9.3.1. L’art. 143, comma 1, d.lgs. n. 43/2004 individua tra i contenuti necessari del piano paesaggistico la “determinazione” delle “prescrizioni d’uso”, la cui disciplina viene declinata in maniera differente a seconda della tipologia di bene paesaggisticamente vincolato che viene preso in considerazione. Stando alla lettera dei singoli enunciati della disposizione:
i. la lettera “b”, disciplinando i beni “immobili e [le] aree dichiarate di notevole interesse pubblico” vincolati in conseguenza del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 140 e 141, in relazione agli immobili ed aree di cui all’art. 136), dispone la determinazione delle “specifiche” prescrizioni d’uso;
ii. la lettera “c”, disciplinando le “aree tutelate per legge” (art. 142), dispone la determinazione “di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree”;
iii. la lettera “d”, disciplinando i beni “eventualmente” individuati attraverso il piano (art. 143, comma 1, lett. d), consistenti nuovamente in quelli elencati nell’art. 136, dispone la determinazione delle “specifiche” prescrizioni d’uso.
9.3.2. Il tenore letterale delle norme passate in rassegna consente di ravvisare la differenza che connota la predisposizione delle differenti “prescrizioni d’uso” ad opera dello strumento di pianificazione, a seconda della tipologia di bene.
La maggiore o minore “specificità”, espressamente richiesta dalla legge per i beni di cui alla lettera “b” e “d”, e non richiesta invece per le aree di cui alla lettera “c”, è consentanea all’ontologia di ciascuno di essi, sicché quando il bene da tutelare non costituisce una “bellezza naturale”, consistente in una “bellezza individua” o in una “bellezza d’insieme”, ma costituisce un “contesto territoriale” (o, per adoperare le medesime parole del conditor iuris, un’“area tutelata per legge”), individuato per le sue caratteristiche di “tipo geomorfologico”, non viola la prescrizione di legge una disciplina delle prescrizioni d’uso che non presenti il medesimo grado di “specificità” previsto per l’altra tipologia di beni paesaggistici.
9.3.3. L’interpretazione letterale dell’art. 143 comma 1, lett. “b”, “c” e “d”, d.lgs. n. 42/2004, non risulta smentita, sul piano dell’interpretazione sistematica, dal diverso tenore letterale dell’art. 135.
In questa disposizione, dedicata alla “Pianificazione paesaggistica”, compare infatti sia il riferimento alla “specifica normativa d’uso” (comma 1), sia la locuzione “apposite prescrizioni e previsioni” (comma 4).
Le due locuzioni individuano come “punti di riferimento” della disciplina da predisporre il “territorio”, nel primo caso, e “ciascun ambito”, nel secondo. La seconda locuzione (“apposite prescrizioni e previsioni”), in particolare, viene riferita alla “salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali” (art. 135, comma 4).
Le due norme permettono, dunque, che il pianificatore assuma a “punto di riferimento” della disciplina predisposta con la pianificazione il “territorio” e ciascun “ambito territoriale” enucleato dalla legge, senza doverlo “frazionare” in “sotto-ambiti” o in una moltitudine di singole aree.
9.4. Tuttavia, venendo all’applicazione di tali principi alle doglianze formulate con i motivi di appello, va evidenziato che, malgrado la disciplina predisposta dal d.lgs. n. 42/2004 non vincoli la modalità di esercizio del potere di pianificazione di cui dispone l’amministrazione preposta imponendo un livello di dettaglio delle prescrizioni dettate nel senso che esse debbano necessariamente essere “specifiche”, ciò non significa che l’amministrazione non possa, discrezionalmente, tenere conto della peculiarità di singoli beni o di singole porzioni dell’ambito territoriale preso a riferimento dalla legge e dettare, perciò, una disciplina più specifica, teleologicamente ritenuta opportuna o necessaria per assicurarne la tutela.
Questa discrezionale scelta pianificatoria, oltre a non essere in contrasto con il paradigma normativo di riferimento, non risulta peraltro connotata da alcun profilo di manifesta irragionevolezza, tenuto conto, peraltro, che, secondo l’orientamento tradizionale del Consiglio di Stato, che deve essere qui ribadito, “Nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l’àmbito delle scelte consentite, lasciando l’autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa.”. Ne consegue che non “ogni atto che appare per qualche verso criticabile, discutibile, poco convincente, sia da ritenere, per ciò solo, irragionevole e dunque illegittimo” bensì solamente quello che risulti “manifestamente irragionevole” (Cons. Stato, Ad. plen., 6 febbraio 1993, n. 3, §§. 3 e 5).
9.5. Sempre in diritto, va poi affermato come la disciplina posta dal d.lgs. n. 42/2004 non individui la “profondità” e l’“estensione” del vincolo paesaggistico. Risulta pertanto rimessa all’amministrazione procedente, in conformità ai consueti principi che conformano l’esercizio del suo potere e in considerazione delle concrete emergenze fattuali, la scelta tra le diverse modalità e possibilità di uso del bene che l’esigenza di conservazione valorizzazione paesaggistica consentono, da quella “meno intensa” che permette la trasformabilità più o meno limitata del bene a quella più intensa che pone il divieto di qualsiasi trasformazione.
9.5.1. Questa conclusione risulta confermata già a partire dalla sentenza della Corte costituzionale resa sull’art. 15 della legge del 24 luglio 1957, n. 8, della Provincia di Bolzano, sulla tutela del paesaggio, rispetto al quale si è ritenuto conforme a Costituzione una disciplina che consentisse all’amministrazione di “proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili”, perché “in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perché questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive; né aggiunge al bene qualità di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale, com'è nel caso dell'espropriazione considerata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sacrificando una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si contrappone (sentenza 9 marzo 1967, n. 20).” (Corte Cost., 29 maggio 1968 n. 56).
Il principio è stato ribadito anche in tempi recenti dalla Corte Costituzionale (23 luglio 2018 n. 172, §. 6.3), che ha affermato che: “la possibilità di introdurre divieti assoluti di intervento e trasformazione del territorio appare… del tutto conforme al ruolo attribuito al piano paesaggistico dagli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali, secondo cui le previsioni del piano sono cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore e vincolanti per i piani, i programmi e i progetti nazionale e regionali di sviluppo economico”.
Tale affermazione di principio risulta confermata, anche più di recente, in altre pronunce (relative ai piani paesistici o territoriali paesistici, (C.G.A. sez. giurisd. 18 marzo 2019, n. 248, secondo cui “se la funzione del piano paesaggistico è quella di introdurre un organico sistema di regole, sottoponendo il territorio regionale a una specifica normativa d'uso in funzione dei valori tutelati, ne deriva che, con riferimento a determinate aree, e a prescindere dalla qualificazione dell'opera, il piano possa prevedere anche divieti assoluti di intervento. La possibilità di introdurre divieti assoluti di intervento e trasformazione del territorio appare, d'altronde, del tutto conforme al ruolo attribuito al piano paesaggistico dagli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali, secondo cui le previsioni del piano sono cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore e vincolanti per i piani, i programmi e i progetti nazionale e regionali di sviluppo economico.”; cfr., inoltre, Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2012, n. 20383; Sez. I, 23 novembre 2004, n. 22117; Sez. I, 19 luglio 2002, n. 10542).
9.5.2. Sul versante dell’interpretazione sistematica, questa interpretazione risulta suffragata dall’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 che, nel dettare la disciplina di coordinamento fra i diversi strumenti di pianificazione, ha disposto che quello paesaggistico risulta “prevalente” anche sulle disposizioni eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici, così confermando la possibile interferenza e antinomia fra disposizioni regolatorie di natura differente, come quelle che dispongano per interessi di conservazione dell’interesse paesaggistico limiti di trasformazione ed edificabilià al bene immobile tutelato e quelle di natura urbanistica che ne avessero invece previsto l’astratta potenzialità edificatoria.
Inoltre, l’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, dispone, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, che “l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta” anche in base “alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico…” (a cui è “succeduto” ex d.lgs. n. 42/2004, art. 143, il “piano paesaggistico”).
9.5.3. Non è infine ultroneo evidenziare che l’attuale disciplina della tutela e valorizzazione del paesaggio si pone in “continuità evolutiva” rispetto a quella “primigenia” contenuta nella legge n. 1497/1939, che, all’art. 16, prevedeva espressamente la possibilità di disporre vincoli consistenti in un “divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili”. In un’ottica di ritenuta pacifica estensione della tutela paesaggistica, qual è quella che ha portato all’attuale disciplina, è arduo sostenere, a meno di voler ritenere sussistente un arretramento in parte qua, che sia venuto meno, nel progredire della legislazione, tale contenuto del vincolo paesaggistico.
9.6. I motivi in esame risultano infondati anche in fatto.
9.6.1. Risulta infondata, infatti, la doglianza di parte secondo cui le prescrizioni dello strumento di pianificazione integrerebbe sempre dei limiti di carattere assoluto agli interventi edilizi (in particolare, doc. 5, depositato in primo grado in data 9 novembre 2022).
9.6.2. Tale disciplina risulta calibrata sulle caratteristiche delle aree in cui essa è chiamata ad operare e al particolare pregio paesaggistico e delicatezza ambientale di tale aree (si tratta, infatti, di aree costiere e litorali, in cui si colloca l’ecosistema, notoriamente molto sensibile e delicato, dei “cordoni dunali”).
9.7. Sempre in punto di fatto, va smentita l’affermazione di parte appellante secondo cui il Piano adopererebbe nozioni urbanistiche ed edilizie e conterrebbe, pertanto, una disciplina equivalente a quella di tali regimi normativi, essendo invece palese il contrario, ossia la teleologica preordinazione del piano alla salvaguardia degli interessi paesaggistici attribuiti alle cure dell’amministrazione regionale dal d.lgs. n. 42/2004.
10. Con il terzo motivo di appello, si deduce che la sentenza impugnata non sarebbe corretta e meriterebbe di essere riformata nella parte in cui ha respinto il III motivo dei ricorsi di primo grado, ritenendo non sussistente il legittimo affidamento delle società ricorrenti all’attuazione degli interventi assenti dagli strumenti urbanistici locali prima del PIT/PPR.
Secondo le appellanti non sarebbe corretto il richiamo da parte del T.a.r. al “tradizionale orientamento giurisprudenziale” per cui la modificazione in peius delle previsioni urbanistiche per una determinata zona non darebbe luogo (salvo particolari ipotesi qui non sussistenti) ad alcuna “lesione dell’affidamento”.
Si deduce per confutare le statuizioni del T.a.r. che:
i. il PIT/PPR sarebbe irragionevolmente restrittivo per quanto riguarda gli interventi sulla Giannella, per le deduzioni già svolte con i precedenti motivi di appello;
ii. sull’area era già stato apposto il vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 con il d.m. 4 dicembre 1964 (pubblicato in G.U. n. 180 del 20 luglio 1965), con cui è stato emanato il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e paesaggistico della zona del “Tombolo di Giannella” nel Comune di Orbetello, e, dunque, “visto che già nella pianificazione locale gli interessi paesaggistici erano stati espressamente considerati, le società del Gruppo Salati hanno legittimamente maturato un pieno e legittimo affidamento, investendo ingenti risorse (per spese di progettazione, studi tecnici, ecc.) in vista dell’attuazione delle previsioni urbanistiche comunali”.
10.1. Il terzo motivo di appello è infondato.
10.2. In primo grado, il T.a.r. ha respinto la corrispondente censura, affermando che: “Nessun affidamento deriva, invece, dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, titolare di una generica aspettativa generica al mantenimento della destinazione urbanistica gradita, ovvero a una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell'immobile.”.
10.3. Le deduzioni di parte non consentono di ravvisare fondati elementi in diritto o in fatto per discostarsi dai tradizionali principi più volte affermati dal Consiglio di Stato, con riferimento a tutte le tipologie e a tutti i livelli di pianificazione, espressione della competenza amministrativa in materia, attribuita dal legislatore, di cui il T.a.r. ha fatto corretta applicazione.
10.4. In linea generale, nella tutela dell’affidamento legittimo risulta centrale la “dimensione soggettiva”, ma, nondimeno, si è messo in risalto che sussistono “limiti fisiologici” alla sua tutela, riconducibili alle caratteristiche del rapporto amministrativo ed alla esigenza di proteggere anche altri principi ritenuti pari-ordinati o superiori alle aspettative di profitto dei singoli. Si pensi, a titolo di esempio:
a) alle evenienze legate alla durata del rapporto nel tempo, al venire meno dell’elemento fiduciario, alla necessità di tenere conto di sopravvenienze normative, all’esercizio di poteri pianificatori e programmatori (Cons. Stato, sez. IV, n. 3018 del 2022; n. 2460 del 2022; n. 2057 del 2022; n. 6470 del 2021; n. 2999 del 2021; n. 2194 del 2021; Corte cost. n. 202 del 2021; n. 179 del 2019);
b) alla prevalenza del principio di neutralità in sede di procedure lato sensu comparative; alle scelte di politica economica; alla necessità di superare prassi amministrative illegittime sia pure reiterate nel tempo (Corte di giustizia UE, sez. VI, 5 marzo 2020, C-211/18; 11 aprile 2018, C-532/16; 1 febbraio 2017,C-430/15; 21 gennaio 2016, C-335/14).
10.4.1. Proprio la materia della pianificazione (in particolare, quella urbanistica) e l’esercizio dei relativi poteri, da parte delle amministrazioni territoriali e locali coinvolte, hanno costituito ab antiquo un “banco di prova” della tutela del principio e dei suoi limiti; un ambito dove contemperare la “dimensione soggettiva” con i valori “super-individuali” contemplati nella pianificazione.
La “misura” scaturente da questo bilanciamento è stata fissata, sin da alcune sentenze del Consiglio di Stato risalenti nel tempo, nella necessità di un’adeguata ponderazione dei diversi interessi in conflitto, senza che l’uno o l’altro “polo” antagonisti (il potere di pianificazione, da un lato, e la tutela del legittimo affidamento relativo ad un interesse legittimo proprietario, dall’altro) risultassero “a priori” prevalenti.
Questa impostazione ha trovato composizione nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 24 del 1999, i cui principi, che si vanno a richiamare in quanto rilevanti per la decisione della controversia, risultano ancora attuali eseguiti dalle più recenti sentenze di questa Sezione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5799; 10 maggio 2023, n. 4749; 05 agosto 2022, n.6952; 10 febbraio 2022, n. 963).
La pronuncia citata ha individuato quali “ipotesi nelle quali vi è un affidamento qualificato del privato”:
i) le ipotesi di precedente convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree,
ii) il caso del privato che abbia ottenuto un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di un silenzio-rifiuto su una domanda edilizia, in ordine alla pretesa di variante di nuove previsioni urbanistiche rilevanti in quanto sopravvenute nel corso del giudizio (dandosi continuità, così, ai principi enunciati da Cons. Stato, Ad. plen., 8 gennaio 1986, n. 1).
In questi casi, l’obbligo di (puntuale) motivazione costituisce il “punto di equilibrio” per salvaguardare l’affidamento legittimamente configuratosi in capo al privato titolare dell’interesse legittimo proprietario e l’attribuzione del potere di pianificazione dell’amministrazione da parte dell’ordinamento
10.4.2. Va peraltro evidenziato che, sul versante dell’interpretazione sistematica, proprio l’art. 145, comma 3, nel prevedere la prevalenza del piano paesaggistico sugli strumenti urbanistici conferma, indirettamente, che eventuali preesistenti previsioni favorevoli degli strumenti urbanistici possano entrare in conflitto con quelle della pianificazione paesaggistica ed essere ritenute soccombenti rispetto a quest’ultime.
10.5. Per converso, contrariamente a quanto sostenuto dalle società appellanti, il mero status quo, derivante da una differente pianificazione (quella urbanistica, nel caso di specie, rispetto all’integrazione di quella paesaggistica) non risulta sufficiente a fondare il legittimo affidamento del privato, rispetto ai poteri di pianificazione di cui dispongono le amministrazioni.
11. Con il quarto motivo di appello, le società deducono che la pronuncia impugnata debba essere riformata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo dei ricorsi di primo grado, ritenendo non obbligatoria la procedura di cui all’art. 141-bis d.lgs. 42/2004, non seguita nella redazione del Piano dalla Regione.
Sarebbe errata, per le appellanti, la motivazione del T.a.r. che avrebbe dichiarato infondata “la censura relativa alla mancata considerazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico …”, perché “tutti i vincoli presenti” avrebbero trovato considerazione e perché “il riferimento di cui all’art. 141-bis del d.lgs. 22 gennaio 2004 che prevede un meccanismo di integrazione dei contenuti della dichiarazione di notevole interesse pubblico” non sarebbe obbligatorio in questa fase.
Si deduce, a contestazione della statuizione gravata, che l’area oggetto dell’intervento pianificatorio risultava già tutelata dal d.m. 4 dicembre 1964, pubblicato in G.U. n. 180 del 20 luglio 1965, con cui è stato apposto il vincolo paesaggistico, e che sarebbero state violate le norme poste dagli articoli 143, comma 1, lett. b), 140, comma 2, e 141-bis, comma 1, che consentirebbero esclusivamente di integrare nel Piano il vincolo preesistente, mentre, nel caso di specie, “il PIT/PPR ha dato “un giro di vite” rispetto alle previsioni locali senza rispettare l’iter normativo descritto”.
11.1. Il quarto motivo di appello è infondato.
11.2. L’art. 141 bis d.lgs. n. 42/2004, introdotto con il correttivo al Codice apportato con l’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, dispone che: “1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.”.
11.3. La norma predispone il meccanismo di integrazione (c.d. “vestizione del vincolo”) di quei vincoli apposti da precedenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ma senza la previsione della “specifica disciplina” preordinata alla conservazione dei valori paesaggistici.
La sua collocazione topografica colloca l’istituto nell’ambito del procedimento di apposizione del vincolo paesaggistico mediante l’emanazione del provvedimento puntuale di dichiarazione di notevole interesse pubblico e costituisce lo strumento predisposto dal legislatore per consentire di disciplinare a posteriori quei vincoli già emanati nel passato, senza la previsione delle apposite prescrizioni d’uso.
11.4. Nell’ambito dell’odierna controversia viene in rilievo tuttavia non già il procedimento preordinato alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, bensì la predisposizione del piano paesaggistico (o meglio una sua integrazione).
Relativamente alla pianificazione risulta corretta in diritto, pertanto, la statuizione del T.a.r. che ha affermato che “non fondato risulta poi anche il riferimento alla previsione di cui all’art. 141-bis del d.lgs. 22 gennaio 2004 che prevede un meccanismo di integrazione dei contenuti delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ma certo non ne impone l’obbligatoria attivazione “a monte” dell’esercizio del potere di pianificazione paesaggistica di cui al capo successivo del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”. Tanto, in considerazione della circostanza che i contenuti tipici della pianificazione (e dunque dell’integrazione della pianificazione esistente, come nel caso di specie riguardante l’adozione e l’approvazione dell’integrazione del piano di indirizzo territoriale), a mente dell’art. 143, sono proprio la ricognizione dei beni paesaggisticamente vincolati e la determinazione delle prescrizioni d’uso, sicché il pianificatore ben può determinare le regole da osservare nella gestione dei beni vincolati.
In proposito, va evidenziato come la norma di cui all’art. 140 comma 2 d.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui prevede che la disciplina di tutela contenuta nella dichiarazione di notevole interesse pubblico “costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo”, non ostacoli quanto appena affermato e non comporti, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, la necessaria applicazione del procedimento di cui all’art. 141 bis, qualora si intenda “vestire” il vincolo già apposto.
Tale ultima norma risulta preordinata, infatti, ad imporre all’amministrazione che esercita il potere di pianificazione la necessaria ricognizione e integrazione nel piano predisposto dei vincoli paesaggistici già esistenti e imposti in precedenza attraverso il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, senza che tali vincoli possano essere “rimossi” o “modificati” dalla disciplina pianificatoria. Tuttavia il lemma “modifiche” adoperato dall’art. 140, comma 2, deve essere correttamente inteso quale divieto di modificazioni in peius o “novazioni” della precedente disciplina d’uso mediante quella successivamente predisposta dal piano, mentre non esclude che l’attività pianificatoria possa individuare ed imporre ulteriori prescrizioni d’uso, purché queste siano coordinate e, dunque, in questa accezione “non modifichino”, quelle già predisposte dal provvedimento puntuale.
Tale soluzione s’impone applicando l’interpretazione testuale dell’art. 143, comma 1, lett. b), c) e d), che enuncia norme che attribuiscono al pianificatore il potere di dettare prescrizioni d’uso e, in tal modo, anche di “vestire” il vincolo già imposto in precedenza, nonché l’interpretazione sistematica-teleologica delle norme in materia di vincolo paesaggistico del d.lgs. n. 42/2004, risultando quest’ultime finalizzate ad accrescere la tutela dei beni de quibus predisponendo a questo fine una panoplia di strumenti amministrativi.
12. Con il quinto motivo di appello, le appellanti impugnano la sentenza domandando che venga riformata nella parte in cui ha respinto il quarto motivo dei ricorsi di primo grado, ritenendo corretta e completa la condivisione del PIT/PPR tra Stato e Regione Toscana, violando gli articoli 133, 135 e 143 d.lgs. n. 42/2004.
Viene dedotto a tale proposito che la cooperazione tra Stato e Regione, nel caso di specie, è stata avviata, ma non è stata conclusa alla data di adozione del PIT/PPR, in quanto:
– l’approvazione della bozza di intesa Regione-MIBACT risale al 9 dicembre 2013;
– l’attuazione del protocollo di intesa risale al 28 ottobre 2014;
– mentre l’adozione del PIT/PRR era già stata disposta il 2 luglio 2014, e la relativa delibera CR n. 58/2014 pubblicata sul BURT il successivo 16 luglio 2014.
Il Piano risulta quindi adottato prima del perfezionamento dell’intesa tra Stato e Regione, in chiara violazione dell’art. 143, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 e non sarebbe pertinente al caso di specie il precedente di questo Consiglio (n. 2633/2021), citato dalla sentenza di primo grado.
12.1. Il quinto motivo di appello è infondato.
12.2. Nel capo della sentenza che ha deciso sulla censura mossa con il quarto motivo di ricorso, il T.a.r. ha affermato che “risulta poi del tutto sufficiente il richiamo della documentazione di cui al doc. n. 1 del deposito dell’Amministrazione regionale che dimostra come Stato e Regione Toscana abbiano ampiamente condiviso i contenuti del nuovo P.I.T. nella sua integrazione paesaggistica anche in fase antecedente all’intervento dell’intesa (poi formalmente intervenuta l’11 aprile 2015), giungendo fino all’espressa “attestazione in merito alla conformità del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di piano paesaggistico ai disciplinari attuativi dell’Intesa tra il Ministero e la Regione Toscana” che è del 24 dicembre 2013 e precede quindi anche l’adozione del piano.
Con tutta evidenza, si tratta pertanto di una censura dal contenuto solo formale e che perde di consistenza alla luce della documentazione relativa all’ampia concertazione dei contenuti del piano tra Stato e Amministrazione regionale”.
12.3. La motivazione risulta corretta e va confermata.
L’art. 135, comma 1, terzo periodo, d.lgs. n. 42/2004, dispone che: “L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.”.
L’art. 143, comma 2, dispone, a sua volta, che: “Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.
Il quadro normativo richiamato enuclea i due strumenti che scandiscono la fase di co-pianificazione, obbligatoria relativamente ad alcuni contenuti della pianificazione: l’intesa e l’accordo ex art. 15 legge n. 241/1990.
12.4. Nella vicenda in esame, dagli atti del procedimento, si evince che, effettivamente, così come accertato dal T.a.r. e ribadito nelle difese della Regione nel presente grado del processo, la pianificazione paesaggistica è stata effettuata mediante un’intensa collaborazione fra le strutture statali e regionali, in concreta attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale.
Giova evidenziare che il procedimento sub iudice ha ad oggetto l’adozione e l’approvazione del procedimento di integrazione del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.
Il procedimento di “integrazione” si innesta su di un precedente procedimento che già era stato scandito da atti di concertazione e di pianificazione congiunta.
Già a partire con l’atto del 15 aprile 2011, siglato dal Ministero dei beni culturali e la Regione Toscana, ai sensi dei richiamati “articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241” hanno integrato e modificato il “disciplinare del 24 luglio 2007 inerente l’attuazione del protocollo d’intesa tra il Ministero dei beni culturali e la Regione Toscana”.
Tale atto presenta i contenuti previsti dall’art. 143 comma 2, in quanto prevede la “procedura di elaborazione ed approvazione del PIT integrato”, pur prevedendo, nel comma 7 dell’art. 3 dell’articolato, la pattuizione della sottoscrizione di un ulteriore accordo espressamente denominato “Accordo di cui all’art. 143 comma 2 del Codice”.
Il 28 ottobre 2014, le parti hanno sottoscritto un atto di integrazione e modifica del disciplinare del 15 aprile 2011.
L’11 aprile 2015, le parti hanno poi sottoscritto un ulteriore Accordo di co-pianificazione ai sensi 143, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, con cui, ad approvazione del piano già avvenuta, le parti si sono limitate a prevedere, dopo averne condiviso l’elaborazione, esclusivamente la disciplina relativa alla revisione.
Analogamente, la pianificazione “integrativa” è stata caratterizzata dall’emanazione di molteplici atti d’intesa, nelle date 22 ottobre 2012, 13 dicembre 2013 e 24 dicembre 2013 “con le quali si dava parziale attuazione ai predetti disciplinari”.
12.5. Risulta pertanto evidente e condivisibile quanto correttamente affermato dal T.a.r., che ha evidenziato come la censura di parte ricorrente abbia costituito il tentativo di infirmare il procedimento amministrativo e il suo esito pianificatorio prospettando mere violazioni formali, che non violano nella sostanza né “i fini determinati dalla legge” (art. 1, comma 1, legge n. 241/1990) né le modalità che il legislatore ha approntato per il perseguimento di queste finalità (cioè la concertazione attraverso intese ed accordi).
Giova rilevare, in proposito, che questo Consiglio ha rimarcato che “il principio di legalità risulta rafforzato in senso “sostanziale”, nel senso di postulare sia il fondamento legislativo dei poteri conferiti all’amministrazione, sia l’apposizione di limiti contenutistici alla sua azione” (così, Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024 n. 2255).
Tale consolidata declinazione del principio di legalità trova un ulteriore elemento di interpretazione, specificazione dei contenuti ed applicazione nell’ottica “del risultato”, come evincibile in base alle norme poste dal legislatore, che “nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione: al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all’entrata in vigore del richiamato d. lgs. n. 36 del 2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad “ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo”, facendo “transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili” (nuovamente, Cons. Stato, Cons. Stato, sez. III, 26 marzo 2024 n. 2866 e Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024 n. 4701).
Partendo da questa impostazione, va evidenziato che le società appellanti non considerano che il “risultato” a cui la legge (in particolare, dell’art. 143, comma 2) preordina l’attività amministrativa è costituito dalla predisposizione di un piano paesaggistico che sia condiviso nel corso della sua elaborazione e approvazione nei suoi contenuti dai livelli di governo statale e regionale e non allegano effettive lesioni del principio di “leale cooperazione” e del metodo della co-pianificazione, che possano aver comportato la menomazione delle competenze di uno dei due livelli di governo coinvolti oppure lo sviamento dell’esercizio del potere di pianificazione o altri profili di illegittimità (ad es., una carente o non congrua istruttoria).
13. Con il sesto motivo di appello, le appellanti impugnano il capo della sentenza che ha respinto il V motivo dei ricorsi di primo grado, ritenendo corretta l’anticipazione dei contenuti del PIT/PPR sin dalla data della sua adozione.
Si censura la sentenza del T.a.r. che avrebbe ritenuto prevalente la finalità “conservativa-cautelare” in linea con l’art. 143 comma 9 del d.lgs. n. 42/2004, “anticipando l’efficacia della buona disciplina vincolistica onde salvaguardare l’interesse pubblico ad evitare modifiche del territorio nelle more del procedimento di approvazione”.
Si evidenzia che l’art. 143 comma 9 del d.lgs. n. 42/2004 disporrebbe esclusivamente che le “prescrizioni” del piano siano immediatamente cogenti sin dalla data di adozione, mentre non lo siano anche gli “obiettivi di tutela”, che dovrebbero quindi essere soltanto previsioni programmatiche e di indirizzo, insuscettibili di dispiegare efficacia sin da subito e non applicabili alla stregua di misure di salvaguardia.
Come sarebbe stato già evidenziato nel precedente grado del giudizio, il PIT/PPR non si sarebbe limitato a dettare misure di salvaguardia dopo la sua adozione, ma avrebbe introdotto una vera e propria disciplina transitoria, volta ad anticipare quasi integralmente i contenuti e gli effetti del PIT.
Si opina che a causa di questa applicazione anticipata delle norme contenenti “obiettivi di tutela” si sarebbe snaturata la funzione delle misure di salvaguardia che, per loro natura e funzione, non sono dirette ad impedire qualsiasi utilizzo del territorio nel tempo occorrente all’approvazione del Piano, ma soltanto quegli interventi incompatibili con le prescrizioni specifiche dettato dal nuovo strumento di pianificazione.
In tal modo, sarebbe stata sostanzialmente vanificata la partecipazione dei privati, venendo meno, in definitiva, la distinzione tra la fase di adozione e quella di approvazione.
Si impugna inoltre l’ulteriore affermazione del T.a.r., secondo cui le ricorrenti non avrebbero “concretamente” articolato la differenza di significato tra i concetti di “prescrizioni” e “obiettivi di tutela”, ovvero fornito “argomentazioni in ordine alla stessa possibilità logica di pervenire ad una considerazione autonoma delle due categorie”, che sembrerebbero riportate nel PIT/PPR “ad una prospettiva coordinata ed unitaria, che attribuisce alla prescrizioni il carattere attuativo degli obiettivi di tutela”
Si deduce, in proposito, che l’art. 143, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004 prevedrebbe che, a partire dall’adozione del PIT/PPR, “non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 [beni paesaggistici], interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso” e non anche con quelle previsioni meramente programmatiche ovvero addirittura rivolte alle Amministrazioni. In ciò, secondo l’appellante, risiederebbe la differenza tra “prescrizioni” e “obiettivi di tutela” e, quindi, l’illegittimità del piano nella parte in cui anticipa l’efficacia cogente non solo delle prime, ma anche dei secondi.
13.1. Il sesto motivo di appello è inammissibile, improcedibile e infondato.
13.2. In punto di ammissibilità della censura, in diritto, va evidenziato che “l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato” (Cons. Stato, Ad. plenaria, 26 aprile 2018, n. 4; da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419).
Ebbene, non si comprende, in base all’allegazione di parte, quale sia stato l’effettivo, diretto e concreto pregiudizio che la parte ha subito dall’allegata “anticipazione” e dunque quale sia l’interesse ad impugnare la prescrizione di piano con la quale si è prevista l’anticipata efficacia di queste misure. Non viene allegato, infatti, la diretta applicazione nei suoi confronti di questa “anticipazione” nell’applicazione di quelli che vengono denominati “obiettivi di tutela” né quale bene della vita sarebbe stato in tal modo precluso.
13.3. Inoltre, sempre in rito, va evidenziato che: “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il sopravvenuto mutamento, in pendenza di giudizio, dell'assetto di interessi attuato tra le parti, in maniera da impedire la realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.” (Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2022 n. 2297).
In disparte quanto evidenziato al paragrafo precedente, non si comprende quale interesse a ricorrere permanga in capo alla parte appellante dopo l’avvenuta approvazione dell’integrazione del piano, che ha comportato la piena efficacia ope legis di ogni previsione di pianificazione di natura regolatoria e ha comportato, pertanto, la cessazione dell’efficacia del regime “transitorio”, scaturente dall’adozione dell’integrazione, di cui si lamenta l’illegittimità e il consolidarsi degli effetti dell’integrazione del Piano.
Ne consegue che, in disparte la declaratoria di inammissibilità della censura per difetto d’interesse sin dal momento della sua proposizione, con l’approvazione del piano, è senz’altro maturata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
13.4. Nel merito, infine, il Collegio evidenzia che risulta priva dei vizi censurati il capo della sentenza del T.a.r. che ha ritenuto, relativamente alla censura sub iudice, che: “…parte ricorrente che propone solo un’ulteriore distinzione tra prescrizioni di piano ed obiettivi di tutela, senza però concretamente articolare argomentazioni in ordine alla stessa possibilità logica di pervenire ad una considerazione autonoma delle due categorie (che, nelle schede di tutela, come quella relativa all’area della ricorrente, sembrano essere riportate ad una prospettiva coordinata ed unitaria, che attribuisce alle prescrizioni il carattere attuativo degli obiettivi di tutela) ed alla rilevanza che potrebbe assumere, nella prospettiva delle ricorrenti (la cui posizione sembra essere concretamente lesa più dalle prescrizioni che dagli obiettivi di tutela), l’anticipazione dell’operatività degli obiettivi di tutela, in un contesto in cui risulta indiscutibilmente legittima l’anticipazione, al momento di adozione del piano, dell’operatività delle prescrizioni ovvero dell’aspetto che concretizza, nei confronti delle ricorrenti, il regime vincolistico imposto all’area)”.
14. Con il settimo motivo di appello, si impugna la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha respinto il sesto motivo dei ricorsi di primo grado, riguardante il mancato coinvolgimento del Comune di Orbetello nel procedimento di pianificazione, ritenendo la censura generica.
Per censurare il capo della sentenza, le appellanti muovono dall’art. 144, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 e invocano, altresì, la Convenzione Europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000 (ratificata in Italia con la legge n. 14/2006), che stabilisce che: “Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell’autonomia locale” (art. 4).
Si evidenzia che, a causa del mancato coinvolgimento del Comune, nel procedimento di formazione dell’integrazione del PIT con valenza paesaggistica, si sarebbe verificata la presenza di errori, anche evidenti, nelle schede e nella disciplina del PIT riferita al territorio di Orbetello, come risulterebbe dalle osservazioni presentate dall’Amministrazione comunale.
L’esigenza di partecipazione del Comune non potrebbe, inoltre, ritenersi soddisfatta dal “rapporto del Garante della Comunicazione richiamato nella Relazione generale al provvedimento impugnato”, che avrebbe la diversa funzione di assicurare soltanto “la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio” (art. 19, legge regione Toscana n. 1 del 2005).
Non risulterebbe idoneo, inoltre, ad assicurare la partecipazione del Comune il presunto “incontro del 6 giugno 2013 a Scansano”, che la Regione Toscana ha richiamato per integrare l’apporto collaborativo dell’Ente locale.
14.1. Il settimo motivo di appello è infondato.
14.2. Ai sensi dell’art. 144, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 “Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione”.
14.3. La norma non reca una puntuale indicazione di come questa attività di concertazione debba svolgersi e, nell’appello, le appellanti non hanno dedotto la violazione di una specifica disposizione regionale.
Risulta pertanto corretta la statuizione del T.a.r. secondo cui la doglianza di primo grado, riproposta criticamente in appello, non avrebbe adeguatamente allegato il perché la concertazione, per come effettuata, sarebbe deficitaria e provocherebbe l’illegittimità del piano approvato.
Il T.a.r. ha infatti affermato che le ricorrenti non hanno mai “specificato attraverso quali effettivi meccanismi avrebbe dovuto essere assicurato l’”adeguato” coinvolgimento del Comune di Orbetello nella fase di elaborazione del Piano, rivendicato con il motivo di gravame”.
Inoltre, secondo quanto dedotto dalla Regione, dalla relazione del garante della partecipazione risulta che il Comune di Orbetello risulta aver prese parte all’incontro istituzionale tenutosi in data 6 giugno 2013 a Scansano.
15. Con l’ottavo motivo di appello, si impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto i ricorsi in primo grado avverso l’approvazione del PIT/PPR, ritenendo correttamente motivate le controdeduzioni alle osservazioni delle società.
Viene criticamente dedotto in proposito che le controdeduzioni regionali alle osservazioni formulate dalle appellanti fossero tautologiche, generiche o insoddisfacenti e pertanto violassero le norme sulla partecipazione al procedimento degli interessati.
15.1. L’ottavo motivo di appello è infondato.
15.2. Relativamente alla declaratoria di infondatezza del motivo di appello, il Collegio richiama anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, la precedente sentenza di questo Consiglio, secondo cui: “Le osservazioni avanzate dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica e paesaggistica non rappresentano veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, di conseguenza, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, risultando sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio, attraverso una congrua motivazione, anche non dettagliata, quanto alla loro incompatibilità con le linee generali dello strumento” (Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 764).
15.3. Alla precedente motivazione, già idonea di per sé a comportare la declaratoria di infondatezza in diritto del motivo in esame, va aggiunto, da un lato, in astratto, che le osservazioni formulate dalle società appellanti sottendano, in realtà, differenti valutazioni di opportunità, come tali inidonee a fondare un concreto obbligo di puntuale risposta in capo all’amministrazione, che ben può insistere e rimanere convinta della propria valutazione di opportunità senza la necessità di fornire un minuzioso riscontro a quanto invece auspicato dal privato; dall’altro, in concreto, che nel caso di specie la risposta fornita dall’amministrazione è stata tutt’altro che formale e laconica rispetto a quanto prospettato dalle osservanti.
16. In conclusione, per le motivazioni sin qui evidenziate, l’appello va respinto.
17. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti delle due società appellanti sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società Mige s.a.s. di Salati Angelo & C. e la società Salati Armando s.p.a. alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), in favore della Regione, e in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), in favore del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura, oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%), se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere



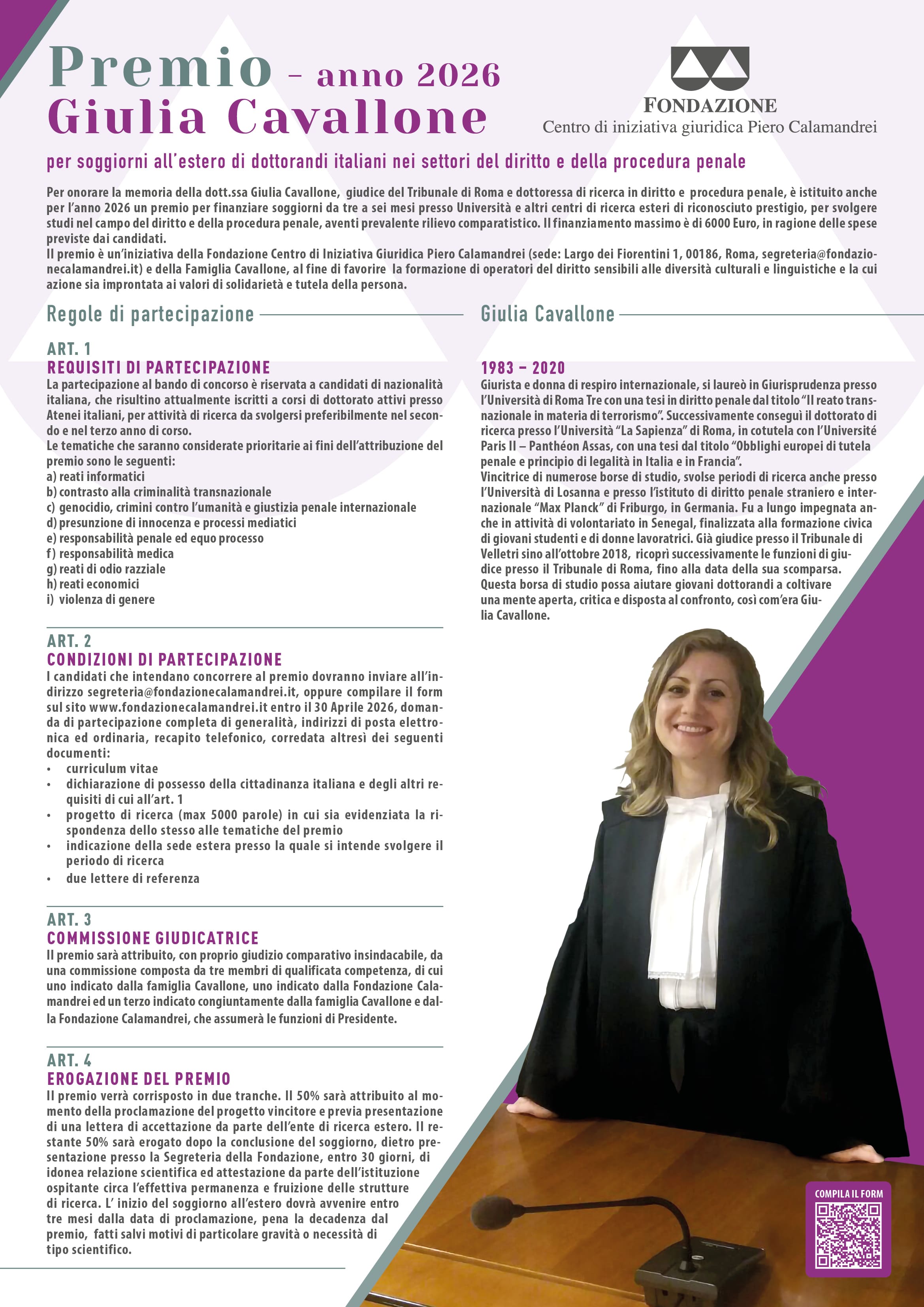 Scarica la locandina
Scarica la locandina

