 Cass. Sez. III n. 30648 del 12 settembre 2025 (UP 12 giu 2025)
Cass. Sez. III n. 30648 del 12 settembre 2025 (UP 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Rossetto
Rifiuti.Differenze tra abbandono e discarica abusiva
La contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. Tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva.
RITENUTO IN FATTO
1.Rossano Rossetto ricorre per l’annullamento della sentenza del 30 settembre 2024 della Corte di appello di Lecce che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di otto mesi di arresto e 6000 euro di ammenda inflitta con sentenza del 20 settembre 2022 del Tribunale di Lecce per il reato di cui all’art. 256, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto perché, quale titolare dell’omonima impresa individuale esercente attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, realizzava o comunque gestiva una discarica non autorizzata di rifiuti depositando, sul terreno intestato alla madre e per una estensione di circa 7000 metri quadrati, rifiuti non pericolosi, tutti stratificati nel tempo, essendo ricresciuta anche vegetazione erbacea spontanea, adagiati sul suolo in assenza di copertura ed esposti agli agenti atmosferici, o comunque abbandonava o effettuava il deposito incontrollato di tali rifiuti. Il fatto è contestato come accertato in Casarano l’8 luglio 2020. Con la stessa sentenza l’imputato era stato condannato al risarcimento del danno subito dalle costituite parti civili, Comune di Casarano e Provincia di Lecce, liquidato in euro 10.000 a favore di ciascuna di esse.
1.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 e la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione che ha escluso la sussistenza della ipotesi alternativa, pure formulata dalla rubrica, del deposito incontrollato, piuttosto che della discarica. Sostiene che dall’esame del compendio probatorio emerge che egli non aveva alcuna intenzione di disfarsi delle cose che invece aveva intenzione di riutilizzare in un prossimo futuro, considerata la propria attività.
1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto basata sugli stessi elementi utilizzati per ritenere la sussistenza del reato e senza considerare la condotta tenuta sei mesi dopo l’accertamento del reato allorquando aveva provveduto alla rimozione e allo smaltimento di tutti i rifiuti.
1.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen. e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 e la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
1.4.Con il quarto motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 538 e segg. cod. proc. pen. nonché la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di risarcimento del danno in favore delle parti civili.
2.Le parti civili, Provincia di Lecce e Comune di Casarano, hanno depositato memorie e conclusioni scritte con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
2.Il primo motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, in fatto, che:
2.1.sul terreno di proprietà della madre del ricorrente era stata accertata la presenza di una notevole quantità di rifiuti;
2.2.l’area in passato era stata utilizzata come cava, come sito cioè per l’estrazione di materiale tufaceo, e benché fosse parzialmente recintata era accessibile con i mezzi da un cancello metallico scorrevole;
2.3. in diversi punti dell’area, l’8 luglio 2020 erano stati rilevati cumuli di terra e roccia da scavo, materiale edile di risulta, conglomerato bituminoso proveniente dalla scarificatura dell’asfalto stradale, la carcassa di un autocarro non marciante privo di targa e pneumatici, pannelli coibentati non integri (rotti o deformati), pneumatici fuori uso, sfalci di potatura, due barche in legno in cattivo stato di manutenzione, una delle quali provvista di motore completamente arrugginito;
2.4.uno dei cumuli era di notevoli dimensioni ed esisteva già dal 2018 siccome rilevato da una ortofoto del 20 luglio 2018; altri cumuli erano presenti e visibili nelle ortofoto del 2015, 2017 e 2018; l’autocarro era presente già il 19 luglio 2015;
2.5.tutto il materiale si presentava buttato alla rinfusa e risultava rotto o comunque in stato di usura e in diversi punti i rifiuti risultavano stratificati, non erano separati in modo omogeneo, ma miscelati tra loro, erano abbandonati sul suolo senza alcuna protezione del terreno sottostante e completamente esposti agli agenti atmosferici siccome privi di copertura;
2.6.in alcuni punti erano visibili dei prelievi di terra e il successivo riempimento/colmatura con rifiuti (terra mista a fresato di asfalto);
2.7.l’area occupata dai rifiuti era pari a 7000 metri quadrati ed al momento dell’accesso vi erano parcheggiati un escavatore e un rimorchio di proprietà dell’imputato, titolare di impresa che si occupa della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di attività di scavi e movimento terra, manutenzione del verde pubblico, recupero e smaltimento di pneumatici, lavori edili stradali;
2.8.la quantità di rifiuti complessivamente smaltiti dopo il sequestro è pari a kg. 293.820.
2.9.Incontestata la natura di rifiuti del materiale in questione, la Corte di appello ha confermato, in diritto, la qualificazione della condotta come gestione di discarica abusiva, qualificazione già data dal primo Giudice in presenza di un capo di imputazione che aveva contestato, in via alternativa, il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.
2.10.Il ricorrente se ne duole ma nel far ciò introduce, in modo oltremodo confuso e contraddittorio, elementi di fatto finalizzati a sovvertire non solo la descrizione dell’area e di quanto vi era stato rinvenuto, quanto, più ancora, a escludere la natura di rifiuto delle cose e a contestare la qualificazione della condotta come gestione di una discarica perché - afferma - non è mai stata sua intenzione disfarsi delle cose, con conseguente svalutazione del versante soggettivo della qualificazione delle cose stesse come rifiuto a tutto (erroneo) vantaggio di quella oggettiva.
2.11.In disparte le inammissibili deduzioni fattuali (il ricorrente non denunzia il travisamento delle prove indicate dalla Corte di appello a sostegno della ricostruzione dei fatti con la conseguenza che i fatti stessi così come descritti non possono essere sovvertiti in questa sede), va ribadito il principio di diritto secondo il quale il desiderio di riutilizzo della res che si trova in oggettivo stato di abbandono è preso in considerazione dal legislatore solo se si realizza secondo un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale (Sez. 3, n. 7567 del 22/04/1992, Abortivi, Rv. 190923 - 01), non quando è affidato alle intime e insondabili intenzioni dell’agente. Non può essere l’autore del reato a costituire se stesso interprete autentico della norma incriminatrice e a regolarne l’ambito applicativo. E’ stato al riguardo precisato (e deve essere ribadito) che la definizione dell'art. 183, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi, esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza o meno di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912 - 01, che, in fattispecie, relativa all'abbandono in un'area agricola di rifiuti speciali, tra cui materiali di risulta di attività edile, sfabbricidi, pneumatici, fusti, tubi e rocce da scavo, ha ritenuto che correttamente i giudici di merito ne avessero escluso la destinazione all'utilizzo, come sostenuto dall'imputato, trattandosi di materiali accatastati alla rinfusa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea). E' noto che la corretta individuazione del significato del termine «disfarsi» ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli); di interpretare il verbo «disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti; di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit). Prescindendo dall'esaminare le diverse - note - posizioni, può qui rilevarsi come sia assolutamente certo che, secondo i principi generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale (Sez. 3, Costantino, cit.; Sez. 3, n. 2125 del 27/11/2002, Ferretti, Rv. 223291 - 01; Sez. 3, n. 48316 dell’11/10/2016, Lombardo, non mass.).
2.12.Va altresì ribadito che la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva (Sez. 3, n. 33287 del 10/07/2024, Paparazzo, Rv. 286844 - 01 che ha precisato che, tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva). Si tratta di principio che si colloca nel solco del consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale l'abbandono differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall'unicità ed estemporaneità della condotta - che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive - e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale - come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti "in loco” (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269914 - 01; Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996 - 01)
2.13.Ai fini, dunque, della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, sono necessari: 1) l'accumulo, più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; 2) la eterogeneità dell'ammasso dei materiali; 3) la definitività del loro abbandono; 4) il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, anche in difetto di una specifica organizzazione di persone e di mezzi (così, in motivazione, Sez. 3, n. 11258 dell’11/02/2010, Chirizzi, Rv. 246459 - 01, con richiamo ad ulteriori precedenti conformi). Non è, peraltro, inutile ricordare, in questa sede che, secondo la definizione legislativa adottata in attuazione della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, è discarica qualunque area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo (art. 2, lett. g, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36). Si tratta di definizione che, da un lato, come anche in dottrina non si è mancato di evidenziare, espunge definitivamente, dall’area del penalmente rilevante, e comunque non la individua come requisito essenziale, la necessaria predisposizione di uomini e/o mezzi per la realizzazione e/o la gestione della discarica, dall’altro, come evidenziato anche da questa Corte, valorizza piuttosto la destinazione dell’area a luogo di smaltimento permanente dei rifiuti, a prescindere dall’effettivo degrado che ne può derivarne (e che, in ipotesi, potrebbe essere anche del tutto assente ove la discarica sia realizzata e gestita secondo la migliore tecnica possibile) (Sez. 3, n. 17289 del 20/02/2014, Terrizzi, non mass.).
2.14.Sicché, anche in caso di deposito di rifiuti che si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 01).
2.15.La descrizione dello stato dei luoghi, la loro estensione, la durata pluriennale del deposito, la presenza persino di un escavatore, la colmatura dei rifiuti, la loro quantità ed eterogeneità, convergono verso la conclusione definitoria condivisa dalla Corte di appello e mal contrastata dal ricorrente.
3.Il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e proposto, anch’esso, al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
3.1.La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità dell’offesa in considerazione dell’ingente quantità di rifiuti (kg. 293.820), della notevole estensione dell’area da essi ricoperta (7000 metri quadrati), della professionalità e organizzazione della condotta, della sua reiterazione nel tempo, delle attività di gestione dei rifiuti stessi (miscelamento e interramento), dello stato di degrado dell’area, pur tutelata dal PUTT della Regione Puglia, del danno alle risorse ambientali (suolo, sottosuolo e acque superficiali). Anche tenendo conto della successiva attività di rimozione dei rifiuti l’offesa, per i Giudici distrettuali, non può comunque ritenersi di particolare tenuità. Sotto altro profilo, la Corte di appello ha rimarcato l’abitualità della condotta avuto riguardo ai due precedenti penali per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata).
3.2.In disparte le inammissibili deduzioni fattuali inerenti «quanto affermato in costanza di istruttoria dibattimentale da parte di Rossetto» (pag. 9 del ricorso), le informazioni fornite dalla Corte di appello sono più che sufficienti a spiegare le ragioni perché il danno (o il pericolo di danno) non possa dirsi di speciale tenuità.
3.3.Come insegnato da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01, l’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto «persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente. Il dato normativo conduce senza dubbi di sorta a tale esito interpretativo. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (…) è chiaro che la novella intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo, bensì l'entità del suo complessivo disvalore». Il richiamo al primo comma dell’art. 133 cod. pen. mette in campo, annotano le Sezioni Unite, Tushaj, «oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa (…) D'altra parte, - proseguono - occorre considerare che se è vero che lo sviluppo del progetto normativo ha in più occasioni mostrato di preferire la considerazione dei tratti più obiettivabili rifuggendo dai profili interiori, tuttavia, come ormai comunemente ritenuto, anche l'elemento soggettivo del reato penetra nella tipicità oggettiva. Ciò è particolarmente chiaro nell'ambito della colpa, ove rileva il tratto obiettivo della violazione della regola cautelare. Ma anche nell'ambito del dolo condotta e colpevolezza s’intrecciano (…) Essendo richiesta la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed è quindi escluso che una preclusione possa derivare dalla modesta caratterizzazione, sul piano descrittivo, della fattispecie tipica». Tali considerazioni valgono anche ai fini della valutazione del danno o del pericolo: «anche qui nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze (…) l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente», sicché «la valutazione inerente all'entità del danno o del pericolo non è da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto». Del resto, «anche in presenza di un danno di speciale tenuità l'applicazione dell'art. 131-bis è pur sempre legata anche alla considerazione dei già evocati indicatori afferenti alla condotta ed alla colpevolezza» e, per converso, «quando si è voluto evitare che la graduazione del reato espressa in una circostanza aggravante ragguagliata all'entità della lesione sia travolta da elementi di giudizio di segno opposto afferenti agli altri indicatori previsti dalla legge lo si è ha fatto esplicitamente».
3.4.Tali principi sono stati ripresi e confermati da Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01. Lo scopo primario della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ribadiscono, è «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo». Il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo ove ricorrano le condizioni indicate nell’art. 131-bis cod. pen. Una prospettiva - ricordano, accolta e più volte rimarcata anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 30 del 2021; sent. n. 156 del 2020; ord. n. 279 del 2017) che ha successivamente esteso l'ambito di applicazione dell'istituto (sent. n. 156 del 2020) anche ai reati puniti con la reclusione che, pur superiore nel massimo edittale a cinque anni, abbia un minimo edittale coincidente con quello generale di quindici giorni.
3.5.Ed infatti la Corte costituzionale ha più volte ribadito che «la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, a norma dell’art. 133, primo comma, cod. pen., incluse quindi le modalità della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto» (così Corte cost., sent. n. 156 del 2020) e che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione» (Corte cost. ord. n. 279/2017).
3.6.Ciò nondimeno, l’esiguità del danno (o del pericolo) costituisce, insieme con «le modalità della condotta», una condizione imprescindibile dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Sicché, se il danno (o il pericolo) non è “esiguo”, il fatto, pur globalmente considerato, non può mai essere considerato di particolare tenuità.
3.7.La natura esigua del danno (o del pericolo) concorre a rendere non punibile un fatto che è comunque offensivo, sicché essa non può essere confusa con le ipotesi di “lieve entità” o di “minore gravità” o modestia del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l’offensività. Si tratta di concetti non sovrapponibili che collocano la non punibilità per particolare tenuità del fatto nella angusta area schiacciata tra la totale inoffensività della condotta e il reato attenuato dalla sua lieve entità, modestia o minore gravità. Si tratta, dunque, di accertamento che deve essere effettuato caso per caso, non potendosi escludere l’esiguità del danno (o del pericolo) in base a valutazioni astratte ma nemmeno in base a interpretazioni eccessivamente dilatate dell’istituto e distoniche rispetto alla sua finalità.
3.8.La necessaria offensività del reato è concetto ormai acquisito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in particolar modo di quella del giudice delle leggi (sentenza n. 263 del 2000 e altre pronunce ivi richiamate: nn. 247 del 1997; 133 del 1992; 333 del 1991, 144 del 1991, 360 del 1995). Come insegnato dalla Corte Costituzionale, «la verifica del rispetto del principio dell'offensività come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore ordinario nel perseguire penalmente condotte segnate da un giudizio di disvalore implica la ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla variabilità del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti in essa sussumibili (…) Diverso profilo è quello dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata; ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato (…), viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen.)» (Sentenza n. 360 del 13-24 luglio 1995). L’offensività, è stato precisato, «deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del fatto e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore, salvo talune ipotesi marginali (…) nelle quali, a causa della necessaria astrattezza della norma, può verificarsi divergenza fra tipicità ed offesa» (Sentenza n. 333 del 10-11 luglio 1991). Di rilievo, ai fini della ratio dell'istituto, l'affermazione che «l’art. 25 [Cost.], quale risulta dalla lettura sistematica a cui fanno da sfondo, oltre ai parametri indicati dal remittente, l'insieme dei valori connessi alla dignità umana, postula, infatti, un ininterrotto operare del principio di offensività dal momento della astratta predisposizione normativa a quello della applicazione concreta da parte del giudice, con conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale» (Sentenza n. 263 del 2000; cfr. altresì sentenza n. 225 del 2008 che ha ben sintetizzato lo stato dell’arte ricordando come «l’ampia discrezionalità che – per costante giurisprudenza di questa Corte – va riconosciuta al legislatore nella configurazione delle fattispecie criminose, si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni o interessi. Rientra, segnatamente, in detta sfera di discrezionalità l'opzione [anche] per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo; nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva. Tali soluzioni debbono misurarsi, nondimeno, con l'esigenza di rispetto del principio di necessaria offensività del reato: principio desumibile, in specie, dall'art. 25, secondo comma, Cost., in una lettura sistematica cui fa da sfondo «l'insieme dei valori connessi alla dignità umana» (sentenza n. 263 del 2000). La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito in qual modo si atteggi, a tale riguardo, la ripartizione di competenze tra giudice costituzionale e giudice ordinario (sentenze n. 265 del 2005, n. 263 e n. 519 del 2000, n. 360 del 1995). Spetta, in specie, alla Corte – tramite lo strumento del sindacato di costituzionalità – procedere alla verifica dell'offensività «in astratto», acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo; esigenza che, nell'ipotesi del ricorso al modello del reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit (tra le altre, sentenza n. 333 del 1991). Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività «in concreto»). Esso – rimanendo impegnato ad una lettura “teleologicamente orientata” degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense – dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva»).
3.9.La non punibilità per particolare tenuità del fatto, dunque, presuppone il positivo superamento del doppio vaglio di offensività (“in astratto” ed “in concreto”) del reato consumato e della condotta posta in essere. L’esiguità, infatti, qualifica il danno o il pericolo concreto cagionati dal reato, ma non lo esclude, pur collocandosi al di sotto delle ipotesi attenuate dalla lieve entità del fatto ovvero della sua minore gravità o modestia.
3.10.L’esiguità del danno (o del pericolo) costituisce requisito per la non punibilità del fatto, che non può essere assorbito dalla non abitualità del comportamento: il reato attenuato occasionale resta pure sempre punibile. S’è già detto che l’esiguità del danno presuppone ma non esclude l’offensività del reato, imponendo pertanto l’obbligatorio esercizio dell’azione penale (art. 112, Cost.) cui lo Stato rinuncia non già per l’esiguità - appunto - dell’offesa, bensì perché la tenuità del fatto incide sulla finalità rieducativa della pena (di qui la necessità che il comportamento non sia abituale).S'é anche ricordato il principio secondo il quale l'offensività deve persistere dal momento della astratta predisposizione normativa a quello della applicazione concreta da parte del giudice. Autorevoli pronunciamenti della Corte di cassazione hanno ulteriormente sottolineato lo stretto legame che deve intercorrere tra la “gravità oggettiva del reato”, la conseguente “proporzionalità della pena” e la “finalità rieducativa” della stessa (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia; Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera). Il Giudice delle leggi ha ribadito che «la sanzione criminale rappresenta non già la risposta alla mera disobbedienza o infedeltà alla legge, in quanto sintomatica di inclinazioni antisociali del soggetto; quanto piuttosto la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore, interprete della coscienza sociale, reputa oggettivamente meritevoli di essere salvaguardati da determinate forme di aggressione col presidio della pena» (Corte cost.le, Sent. 8 novembre 2006, n. 394). Una sanzione proporzionata alla gravità dell’offesa costituisce espressione del diritto inviolabile della persona (Sez. U, Della Fazia, cit.). Necessaria offensività del reato e finalità rieducativa della pena costituiscono un binomio inscindibile sancito dal combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 13, 25 e 27, Cost. La finalità rieducativa della pena non appartiene solo alla fase esecutiva: è già nel precetto, nelle modalità stesse con cui è confezionato e nella sanzione prevista per la sua violazione (Corte Cost.le, sentenza n. 364 del 1988). Si può affermare che la gravità dell’offesa costituisce, a livello di prevenzione generale, unità di misura della pena, ma non in via esclusiva in sede di prevenzione speciale (artt. 132, 133, cod. pen. e oggi anche 131-bis, cod. pen.). Altri criteri, oltre la gravità dell'offesa, concorrono a definire e a regolare l’an e il quomodo della pretesa punitiva al fine di meglio adeguarla alla finalità rieducativa della pena (perdono giudiziale, sospensione del procedimento con messa alla prova, sospensione condizionale della pena, pene sostitutive, sospensione dell’esecuzione della pena, misure alternative alla detenzione; solo per fare degli esempi).
3.11.Quel che ora preme evidenziare, alla luce delle considerazioni che precedono, è che: a) la finalità rieducativa della pena appartiene (anche) al diritto sostanziale, come pure - significativamente - l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui collocazione codicistica, prima dell’art. 132, cod. pen., fornisce, a tal fine, un criterio interpretativo-sistematico fondamentale; b) la necessità della pena è collegata alla sua finalità rieducativa, sicché l’offesa al bene o comunque all'interesse tutelato può escludere la sua applicazione quando, in concreto, il fatto non esprime alcuna esigenza risocializzante del suo autore; c) solo la mancanza, in concreto, di tale esigenza legittima, sul piano costituzionale, la paralisi dell’azione penale.
3.12.L’istituto della particolare tenuità del fatto si inserisce in un sistema in cui l’azione penale è obbligatoria, sicché esso non può costituire (né essere interpretato alla stregua di un) criterio direttivo di politica criminale volto ad affermare il principio secondo il quale "de minimis non curat praetor”. Esso riguarda piuttosto il rimprovero per il singolo fatto, che non si giustifica quando, per la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, la pena non assolverebbe in alcun modo alla finalità rieducativa che la legittima (non a caso l’istituto in questione si collocava nella legge delega n. 67 del 28 aprile 2014 in un più ampio contesto di riforma del sistema sanzionatorio, non attuato dal Governo). La non punibilità per particolare tenuità del fatto, incidendo sui presupposti del rimprovero, si colloca a pieno titolo nell'ambito della colpevolezza, esaltando ancor più il principio di extrema ratio del diritto penale. Un diverso argomentare, che valorizzasse, per esempio, le esigenze deflattive dell'istituto, tradirebbe la centralità che la 'persona' assume nella Costituzione repubblicana, trasformandola da fine a mezzo di politiche criminali ispirate a logiche del tutto estranee anche all'obbligatorietà dell'azione penale.
3.13.In conclusione, la modesta gravità del fatto non esclude la offensività della condotta né la natura esigua del pericolo derivante dalla condotta addebitata all’imputato, sanzionata dal Giudice con una pena superiore al minimo edittale.
3.14.Nel caso di specie, l’esiguità del danno è stata esclusa con motivazione che fa buon governo dei principi sopra illustrati, non è manifestamente illogica, non è intrinsecamente contraddittoria, non si fonda su dati travisati ed è perciò insindacabile in questa sede.
3.15.Così come non è censurabile la motivata affermazione della abitualità della condotta, non vedendosi ragione alcuna per escludere la rilevanza delle condanne inflitte con precedenti decreti penali. Non v’è un passo della norma che ne giustifichi una simile lettura riduttiva.
3.16.La affermata abitualità (che osta comunque alla declaratoria di non punibilità del fatto) rende superfluo ribadire (ma è comunque bene farlo) che la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, Hamdi, Rv. 285360 - 01; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497 - 01).
3.17.Che il ricorrente abbia provveduto alla successiva bonifica dell’area è considerazione irrilevante a fronte della oggettiva gravità del fatto e della abitualità della condotta.
4.Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
4.1.Il ricorrente è stato condannato alla pena di otto mesi di arresto e 6.000 euro di ammenda, così determinata: pena-base, un anno di arresto e 9.000 euro di ammenda, ridotta di un terzo per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
4.2.La pena edittale del reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi (tale è stato ritenuto il fatto) è dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 2.500 a 26.000 euro. I Giudici di merito hanno applicato una pena-base inferiore al medio edittale che, calcolato secondo i criteri fissati da Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01, è pari a quindici mesi di ammenda e 14.250 euro di ammenda.
4.3.L’insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto è chiaro: nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
4.4.La Corte di appello ha ritenuto di non dover modificare la pena irrogata in primo grado, già attenuata ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., in considerazione della rilevante gravità del fatto e, più in generale, per le stesse ragioni per le quali ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto stesso. A tal fine ha preso in considerazione anche gli elementi offerti in valutazione dalla difesa, per un verso ritenendone la insussistenza e l’inconcludenza rispetto al quadro probatorio (come, per esempio, la dedotta intenzione di riutilizzare i rifiuti), per altro verso affermandone la sub-valenza rispetto agli indici di gravità oggettiva e soggettiva del reato (come, per esempio, la bonifica del sito già presa in considerazione ai fini della applicazione delle circostanze attenuanti generiche).
4.5.Il ricorrente se ne duole, lamentando l’elevato «irrigidimento trattamentale», ma sostanzialmente sollecita la Corte di cassazione a sostituirsi al giudice di merito nell’esercizio di una discrezionalità che appartiene solo a questi. Si tratta, all’evidenza, di richiesta inammissibile.
5.Il quarto motivo è generico.
5.1.La Corte di appello ha confermato la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalle parti civili (Provincia di Lecce e Comune di Casarano) in considerazione dei danni non patrimoniali subiti a causa della condotta dell’imputato (ampiamente illustrati alle pagg. 21-23 della sentenza impugnata).
5.2.Il ricorrente se ne duole ma il suo argomentare è assolutamente generico non essendo stato sviluppato un ragionamento critico della ratio decidendi che, invece, è fondata su considerazioni non manifestamente illogiche e su dati di fatto dei quali non viene dedotto il travisamento.
5.3.Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale è sufficiente, per quanto riguarda l’an del risarcimento, l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione (Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Pollifrone, Rv. 287154 - 01; Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 - 01; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450 - 01; Sez. 5, n. 6018 del 31/01/1997, Montanelli, Rv. 208086 - 01). La relativa decisione, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495 - 02; Sez.6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170 - 01; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, R.C. Istituto Città Studi, Rv. 257123 - 01; Sez. 3, n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371 - 01).
5.4.Il ricorrente neglige l’insegnamento della Corte di cassazione e si sottrae all’onere di specificare in quale parte la motivazione della Corte di appello sia contraria ai principi sopra indicati.
6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.686,00 per ciascuna di esse oltre accessori di legge e spese documentate.
Così deciso in Roma, il 12/06/2025.



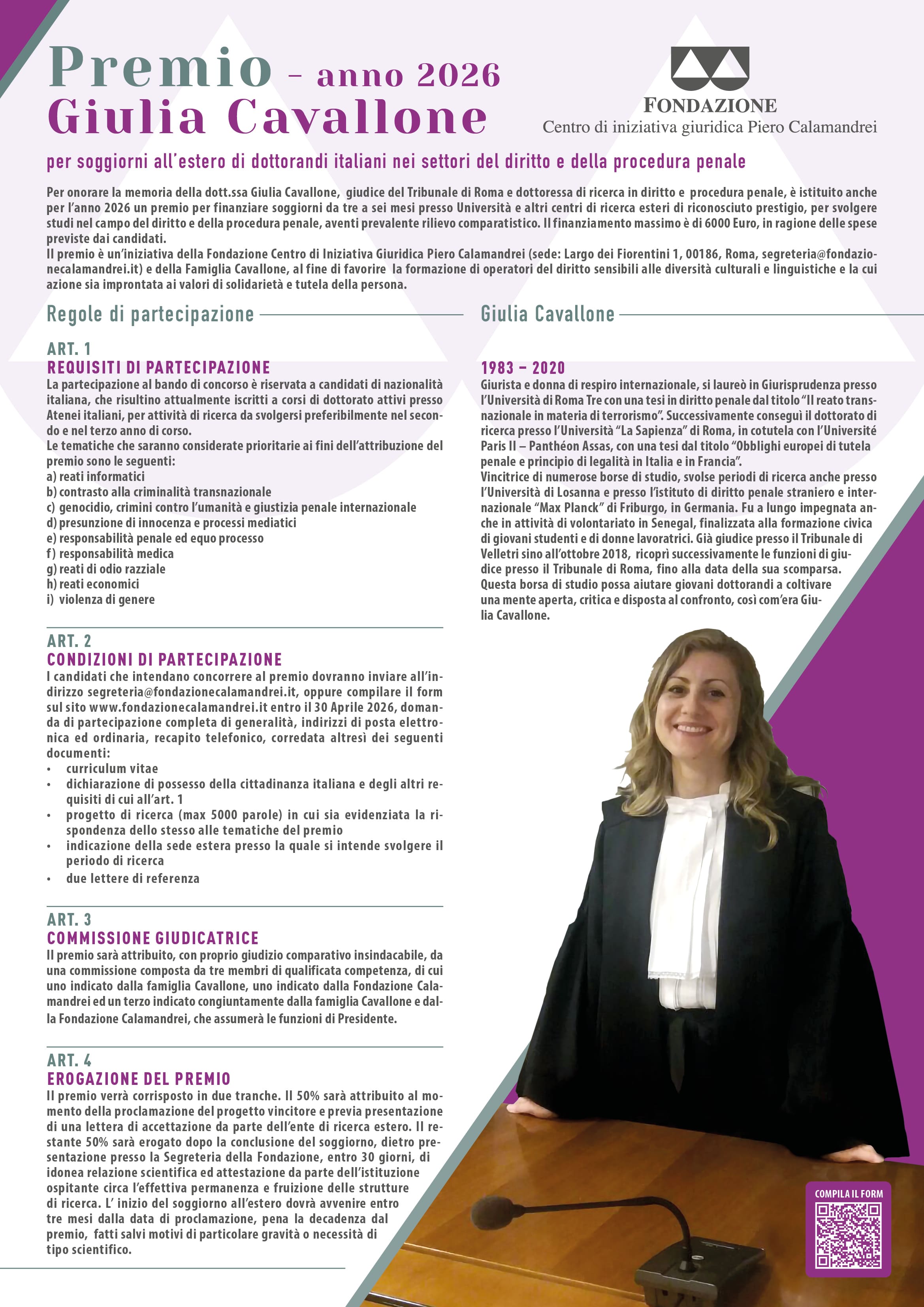 Scarica la locandina
Scarica la locandina

