 Cass. Sez. III n.28569 del 5 agosto 2025 (CC 10 lug 2025)
Cass. Sez. III n.28569 del 5 agosto 2025 (CC 10 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric.Lecchi
Urbanistica.Nozione di carico urbanistico
Il carico urbanistico costituisce un concetto non «statico», ma «relazionale» e il relativo aggravio deve essere valutato in modo dinamico avuto riguardo alle conseguenze dell'attività edilizia sul territorio. Esso consiste nell'effetto incrementale prodotto dall'insediamento primario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in relazione al numero delle persone insediate su un determinato territorio, il che si verifica, a titolo esemplificativo, in caso di concreta e sostanziale alterazione dell'originaria consistenza del manufatto in termini di metratura, volumetria e destinazione d'uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee (come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, il passaggio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, ecc.), ovvero anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture .e di opere collettive correlate.
PREMESSO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18/03/2025, il Tribunale del riesame di Verbania confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 06/02/2025 dal Tribunale di Verbania, avente ad oggetto un immobile corpo del reato di cui agli artt. 480 cod. pen., 44 lett. e) d. P.R.
380/2001.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Lecchi.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e segnatamente degli articoli 321 e 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., sotto forma di mancanza di motivazione.
Va premesso che il GIP ha ravvisato la sussistenza del fumus del reato di cui all'articolo 44 lettera a), e non c), d.P.R. 380/2001.
Nel caso in esame i lavori erano ultimati, era stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per cui non sussisteva il pericolo di aggravare le conseguenze del reato.
Il Tribunale del riesame, a fronte dalla espressa censura difensiva, ha ritenuto che il periculum sussistesse in relazione al «possibile» aumento del carico urbanistico e alle altre conseguenze della condotta, sottratta a qualunque controllo pubblico, l'aumento del quale va però effettuato in concreto, non in astratto.
Inoltre, la motivazione in ordine al periculum deve essere resa anche in riferimento ai reati paesaggistici.
2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e segnatamente degli articoli 321, 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen..
Il Tribunale del riesame ritiene che il sequestro avrebbe dovuto essere disposto anche ai sensi dell'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di confisca obbligatoria ex art. 44 comma 2 d.P.R. 380/2001, ma in tal modo va ultrapetita, in quanto il sequestro era stato chiesto solo per il comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen..
2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione di legge in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Il Riesame sbaglia nel considerare la seconda relazione agronomica sostanzialmente uguale alla prima, mentre le due differivano in quanto la seconda era stata integrata con l'individuazione dell'intervento nel piano paesistico territoriale.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione al fumus commissi delicti relativo all'articolo 44 lettera a) d.P.R. 380/2001.
Il Tribunale del riesame ritiene che non competesse al tecnico comunale rilasciare il titolo edilizio in quanto solo la Giunta regionale potrebbe adeguare il piano paesistico territoriale, anche ove sbagliato.
In realtà il permesso di costruire rilasciato al Lecchi è conforme agli strumenti di pianificazione regionali approvati nel 2007, ed è stata seguita la procedura indicata dal punto 5.1.9. dell NDA del PRGC, il quale prevede l'acquisizione di una relazione agronomica asseverata, come è stato fatto per due volte, e in esito a tale procedura è stato regolarmente rilasciato permesso di costruire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2 Per ragioni di coerenza sistematica, saranno trattate prima le doglianze relative al fumus e quindi quella relativa al periculum.
2. Il Collegio sottolinea, in via preliminare, che la non conformità dell'atto autorizzativo alla normativa che ne regola l'emanazione (ossia alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici) può essere rilevata non soltanto se l'atto è illecito e, cioè, frutto di attività criminosa, ma anche nell'ipotesi in cui l'emanazione dell'atto medesimo è espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge o nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere (Sez. 3, n. 37847 del 14/5/2013, Sonni, Rv. 25697101, cit.; Sez. 3, n. 40425 del 28/9/2006, Consiglio, Rv. 23703801, cit.), senza che rilevi, in proposito, la «macroscopica illegittimità» dell'atto (Sez.
3, n. 12389 del 21/02/2017, Minosi, Rv. 271170 - 01).
Pertanto, nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo (sussista ma) sia illegittimo, esso non può che ritenersi sostanzialmente mancante, in quanto l'atto è stato emanato in assenza dei presupposti legali per la sua emanazione.
In tal caso, pertanto, è corretta la contestazione dell'art. 44, lett. b) d.P.R. 380 del 2001, non risultando invece applicabile l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo articolo, di natura meramente residuale (Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, Merelli, Rv. 270276 - 01, in motivazione).
3. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che la prima e la quarta doglianza sono inammissibili in quanto, sotto l'ombrello della violazione di legge e dell'assenza di motivazione, in realtà censurano un vizio di motivazione, a fronte di una completa motivazione resa dal provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza del fumus dei reati contestati (v. pag. 4- 5 dell'ordinanza, in cui si dà atto della macroscopica illegittimità del provvedimento autorizzatorio, rilasciato pochi mesi dopo un precedente diniego - da parte di altro tecnico comunale - a situazione normativa immutata e a fronte di una incompetenza per materia dell'amministrazione comunale).
Va infatti ribadito secondo cui, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916).
In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, 3 Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, Rv. 242916; Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226710).
Le doglianze sono pertanto inammissibili in quanto proposte per motivi non consentiti dalla legge.
4. La terza dogliànza, relativa al fumus dell'elemento psicologico del reato, è manifestamente infondata.
Come noto, in sede cautelare reale, il difetto dell'elemento soggettivo deve essere di «immediato rilievo» (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di, Rv. 259337 - 01; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474 - 01), circostanza non sussistente nel caso in esame, posto che l'ordinanza impugnata, a pagina 5, da conto della sussistenza in concreto di plurimi elementi che inducono a propendere per la partecipazione del ricorrente alle condotte contestate, primo fra tutti la riproposizione della medesima istanza a pochi mesi dal rigetto della prima a situazione giuridica e fattuale immutata.
La circostanza che la seconda relazione agronomica contenga delle piccole differenze rispetto alla prima, nulla sposta in concreto, trattandosi in ogni caso di eventuale vizio di motivazione che non può essere dedotto in questa sede.
Del pari, trattandosi di sequestro preventivo c.d. «impeditivo», adottato cioè ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., non rileva in alcun modo chi sia l'autore del fatto per il quale si procede, prevalendo su tutte l'oggettiva finalità cautelare perseguita dal provvedimento.
E' stato infatti affermato che, in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 - 01).
5. Le doglianze relative al periculum in mora sono inammissibili.
La sussistenza del periculum in mora in riferimento al reato edilizio è stata in concreto ravvisata dal provvedimento gravato nel ventilato aumento del «carico urbanistico» e nelle ulteriori conseguenze dovute all'uso ed al godimento dell'opera abusiva al di fuori di ogni controllo prescritto in relazione della tutela degli interessi pubblici coinvolti (così richiamandosi i principi stabiliti da Sez. 3, n. 9058 del 22/01/2003, Rv. 224173; Sez. 3, n. 42717 del 10/09/2015, Rv. 265195).
Il ricorrente ha censurato, anche nella discussione orale, che il Tribunale del riesame non avrebbe in concreto indicato in cosa consisterebbe il paventato aggravio del carico urbanistico.
4 5.1. Va preliminarmente rammentato che, ove anche dimostrata l'ultimazione delle opere, ciò non implicherebbe l'insuscettibilità dell'opera a essere sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen..
Ed infatti, questa Corte ha affermato (Sez. 3, n. 20866 del 13/02/2020, Graziano, n.m.;
Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Rv. 268812) che il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente è ammissibile anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato; Sez. 2, n. 17170 del 2 /04/2010, Rv. 246854; Sez. 3, n. 4745 del 12/12/2007, Rv. 238783).
In proposito va considerato che, secondo la giurisprudenza di questo Consesso, al giudice spetta di valutare in quale misura si sia verificata «la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività» (Sez. 3, n. 170 del 13/12/2017, dep. 2018, Monaco, n.m.).
L'obbligo di motivazione deve riguardare in particolare le conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio (Sei. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812), ciò che può assumere carattere pregiudizievole anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate (Sez. 3, n. 42717 del 10/09/2015, Buono e a., Rv. 265195).
5.2. Per quanto in particolare concerne l'aggravio del c.d. «carico urbanistico», il ricorrente lamenta l'astrattezza della motivazione del Tribunale verbanese.
5.2.1. Sul punto, il Collegio rammenta che la nozione di «carico urbanistico» è stata originariamente approfondita da Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223722, secondo cui essa «deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. "primario" (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno "secondario" di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti di diritto urbanistico: a) negli standards urbanistici di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 che richiedono l'inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie 5 zone; b) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento; c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione; d) nell'esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne (art. 26 L. N. 47/1985 e art. 4 comma 7 I. 493/1993) che non comportano la creazione di nuove superficie utili, ferma restando la destinazione dell'immobile; e) nell'esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico urbanistico (art. 10 L. n. 47/1985 e art. 4 L. 493/1993)».
Il Consiglio di Stato, a sua volta, ha di recente precisato (Sez. VI, n. 3326 del 16 aprile 2025) che «l'accertamento del maggior carico urbanistico, che giustifica la necessità del permesso di costruire e la corresponsione dei relativi oneri di urbanizzazione, assolve alla prioritaria funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti. La nozione di cui si discute è dunque una nozione relazionale, e precisamente differenziale: l'incremento del carico urbanistico si accerta infatti in relazione a un supposto aumento di esternalità negative sull'area considerata, conseguente al mutamento di destinazione d'uso, rispetto agli effetti prodotti dalla destinazione precedente.
Sulla base dell'indirizzo esegetico consolidato seguito dalla giurisprudenza amministrativa, si deve affermare che l'aumento dello stesso si verifica quando la modifica della destinazione funzionale dell'immobile determina un'attrazione per un maggior numero di persone, con la conseguente necessità di un utilizzo più intenso delle urbanizzazioni esistenti».
La natura «relazionale» del concetto di carico urbanistico è stata recentemente ribadita anche da questa Corte, secondo cui «costituisce carico urbanistico l'effetto prodotto dall'insediamento primario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in dipendenza del numero delle persone insediate su un determinato territorio, sicché, ai fini della verifica, in fase cautelare, del pericolo del suo aggravio per effetto della costruzione realizzata, dev'essere compiuta una valutazione dinamica delle conseguenze dell'attività edilizia sul territorio, avendo riguardo anche all'incidenza delle opere in precedenza edificate sulla stessa area, le cui dimensioni possono costituire un valido elemento per apprezzare l'impatto complessivo dell'immobile» (Sez. 3, n. 16085 del 13/02/2025, Lupi, Rv. 287986 - 01).
5.2.2. L'«incidenza» delle opere abusive sul carico urbanistico (Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011, dep. 2012, Susinno, Rv. 252016, non massimata sul punto) va valutata avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della «dotazione minima» degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive; Sez. 3, n. 825 del 04/12/2008, Rv. 242156 e «deve essere rapportata all'aspetto strutturale e funzionale dell'opera abusiva» (Sez. 3, n. 170 del 2018, Monaco, cit.).
6 Essa potrebbe emergere, ad esempio, «mediante concreta e sostanziale alterazione dell'originaria consistenza del manufatto in funzione di volumetria, destinazione d'uso o effettivo utilizzo, tale da comportare un mutamento divergente dalle esigenze urbanistiche valutate nei confronti dello strumento urbanistico e di pianificazione comunale, in riferimento soprattutto agli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68 (Sez. 3, n. 36104 del 22/9/2011, Armelani, Rv.251251)».
La citata sentenza Lupi evidenzia che anche la «metratura» degli immobili preesistenti all'ultima edificazione fornisce dati sufficienti e idonei a calcolare il complessivo impatto di tali immobili (compreso l'ultimo in ordine di tempo) sul carico urbanistico gravante sull'area essendo evidente che anche la realizzazione di una sola unità abitativa in più non può che aumentare la domanda di ulteriori servizi (si pensi, a titolo di puro esempio, all'incidenza che hanno le superfici degli immobili ai fini del calcolo del quantum della tassa sui rifiuti (c.d. "TARI") e del costo del relativo servizio di smaltimento; art. 1, commi 639 e segg., legge b. 147 del 2013). Del resto, l'art. 3 D.M. n. 1444 del 1968 àncora le dotazioni minime inderogabili di spazi pubblici e privati per ogni singolo abitante (da insediare o già insediato) in termini di metri quadri a disposizione di ciascuno di essi. Dunque, è evidente che la maggiore o minore dimensione dello spazio abitativo concorre a definire il fabbisogno di opere di urbanizzazione primaria e secondaria che la realizzazione dell'immobile inevitabilmente comporta. Non a caso l'incidenza degli oneri di urbanizzazione prima e secondaria è parametrata anche all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni e ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell'art.41-quinquies I. n. 1150 del 1942 (art. 16, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001).
Analogamente, si è ritenuto (Sez. 3, n. 42717 del 10/09/2015, Buono, Rv. 265195 - 01) che «è legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo ultimato anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate».
Ancora, si è stabilito che solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee (come nel caso in esame), così come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, per cui «il cambio di destinazione d'uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, e ciò indipendentemente dall'esecuzione di opere» (Sez. 3, n. 11303 del 04/02/2022, Turrin, Rv. 282929 - 01. Per la giurisprudenza amministrativa, v. T.A.R. Salerno, sez. I, 14/05/2018, n.742; T.A.R. Lazio, sez. IL 26/07/2018, n.8452).
7 Si è in altra pronuncia evidenziato (Sez. 3, n. 23139 del 21/03/2019, Formisano, n.m.) che nel concetto di «costruzione» rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. «carico urbanistico» e tali sono pure i «piani interrati», cioè sottostanti al livello stradale, che devono essere computati ai fini volumetrici (Sez. 3, n. 11011 del 9/7/1999, Boccellari, Rv. 214273).
Da ultimo, questa Corte ha ritenuto che il periculum in mora richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola, può essere legittimamente motivato con l'aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come «desumibile dalla loro consistenza e destinazione d'uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell'area su cui insistono», trattandosi di elementi idonei a fornire un'oggettiva indicazione dell'incidenza dell'intervento sulle esigenze urbanistiche di zona (Sez. 3, n. 8671 del 15/02/2024, Alcamo, Rv. 285963 - 01).
5.2.4. Dalle pronunce sopra elencate si ricava il principio secondo cui il carico urbanistico costituisce un concetto non «statico», ma «relazionale» e il relativo aggravio deve essere valutato in modo dinamico avuto riguardo alle conseguenze dell'attività edilizia sul territorio.
Esso consiste nell'effetto incrementale prodotto dall'insediamento primario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in relazione al numero delle persone insediate su un determinato territorio, il che si verifica, a titolo esemplificativo, in caso di concreta e sostanziale alterazione dell'originaria consistenza del manufatto in termini di metratura, volumetria e destinazione d'uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee (come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, il passaggio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, ecc.), ovvero anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture .e di opere collettive correlate.
5.3. Tuttavia, il Collegio evidenzia che la giurisprudenza di cui sopra concerne l'ipotesi in cui le opere risultino ultimate.
Nel caso in esame, invece, a fronte della motivazione fornita dal provvedimento genetico, in cui il GIP ha giustificato l'esistenza del periculum in mora sulla considerazione della mancata ultimazione dei lavori, il ricorrente, al fine di attestare detta ultimazione, in sede di riesame ha allegato una mera segnalazione certificata di agibilità (come espressamente chiarito dall'ordinanza impugnata), documento che, in quanto proveniente dall'imputato e non dall'amministrazione competente, non può attestare oggettivamente l'intervenuta ultimazione dei lavori medesimi (non chiarisce, ad esempio, come sia stato possibile ultimare i lavori su un immobile sottoposto a sequestro), circostanza che rende comunque generica la doglianza originaria.
Questa Corte ritiene infatti che il difetto di motivazione del provvedimento di secondo grado in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare 8 oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 - 01).
In tal caso si parla di «inammissibilità originaria» (nella specie per genericità), cui consegue, nonostante la proposizione del gravame, il passaggio in giudicato della sentenza di merito (Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, Maglieri, Rv. 219060 - 01, ma il proincipio può essere esteso anche alla fase cautelare), posto che essa colpisce l'impugnazione nel suo momento iniziale, con la conseguenza che non si instaura il rapporto processuale di impugnazione (Sez. 1, n. 13665 del 12/11/1998, Scarsi, Rv. 212023 - 01).
In caso di immobile in corso d'opera, costituisce pertanto sufficiente giustificazione del sequestro preventivo la necessità di interrompere la permanenza del reato, impedendo che venga portato a compimento.
La doglianza è pertanto inammissibile.
6. La inammissibilità della censura di cui sopra proietta i suoi effetti anche sulla censura relativa al periculum in mora in relazione al reato di cui all'articolo 181 d. Igs. 42/2004.
Va infatti rammentato che il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, se commesso mediante la realizzazione di lavori che comportino una modifica funzionale di destinazione d'uso di un bene gravato da vincolo paesaggistico, ha natura permanente, e si consuma con l'esaurimento della condotta, o con il sequestro del bene ovvero, in mancanza, con la sentenza di primo grado, quando la contestazione è di natura «aperta» (Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017, Zanella, Rv. 271336 - 01).
L'assenza di prova in ordine alla ultimazione dei lavori determina quindi l'inammissibilità anche della doglianza in parola.
7. Sotto altro punto di vista, se coglie nel segno il ricorrente laddove evidenzia che l'impossibilità per il Tribunale del riesame di fondare la misura cautelare reale su un titolo diverso da quello dell'ordinanza genetica, come quando, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura per finalità di confisca ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, «atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 15852 del 28/02/2023, Caprio, Rv. 284598; in precedenza, per analoghe situazioni di mutamento del titolo posto a base del sequestro, v. Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, Morcone, Rv. 281944; Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194; Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016, Venniro, Rv. 269498; Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748), tuttavia, nel caso di specie, l'inammissibilità del motivo di 9 Ad/ ricorso relativo al periculum in mora determina l'impossibilità per il ricorrente di ottenere un esito positivo, con conseguente inammissibilità della doglianza per mancanza di interesse.
Secondo !Insegnamento di questa Corte, infatti, (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
271227 -01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01), l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione.
8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2025.



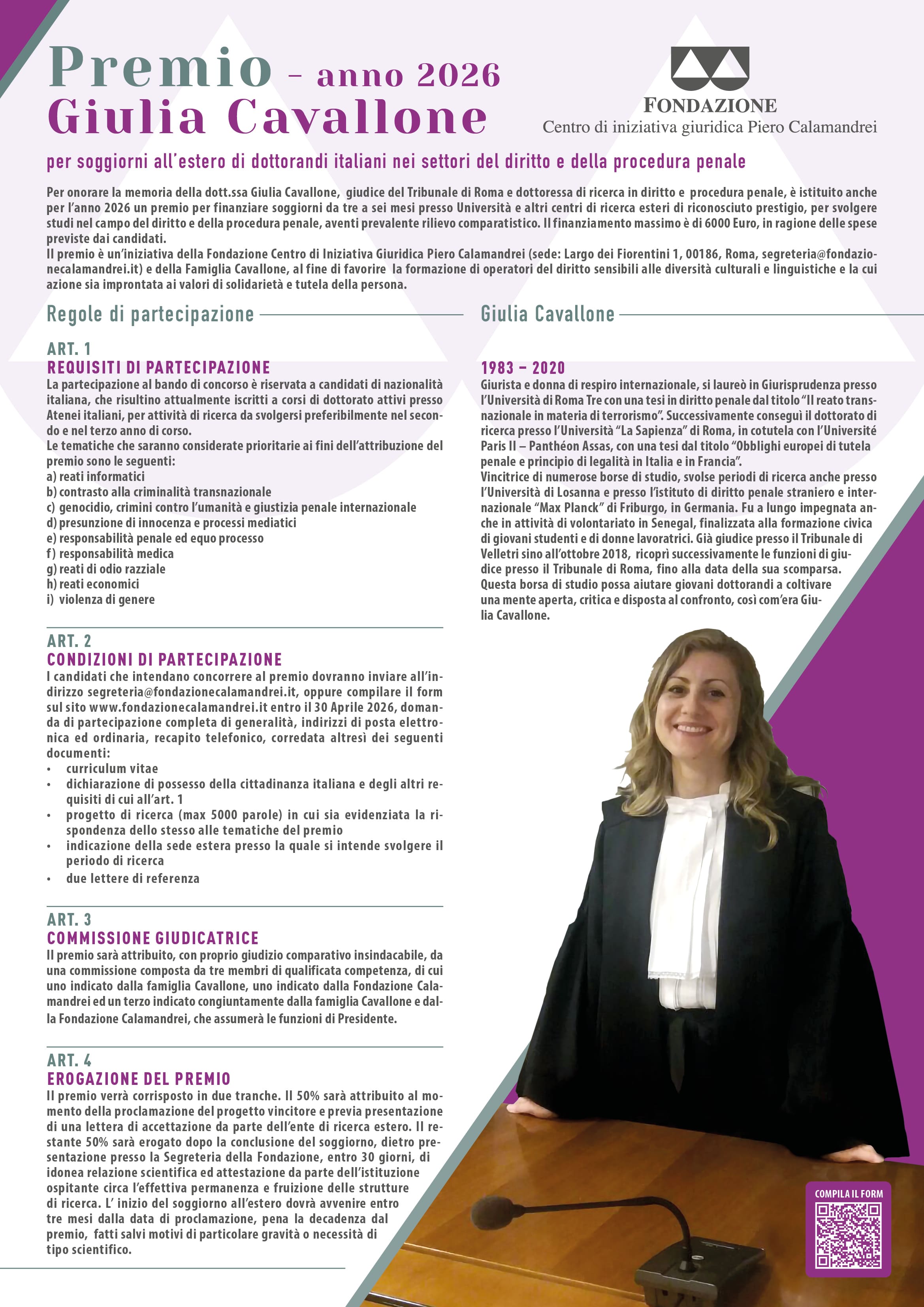 Scarica la locandina
Scarica la locandina

