LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI IN PORTO
A cura di Cristian ROVITO
L’entrata in
vigore del D.Lgs n. 182 del 24 giugno 2003, costituisce uno strumento normativo
attraverso il quale il legislatore, su proposta del Ministro dell’Ambiente e
della tutela del territorio, ha dato attuazione alla Direttiva CE n. 59/2000
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed
i residui del carico. Ha introdotto, quindi, una disciplina ad hoc sui rifiuti riferendosi al contesto marittimo e portuale.
L’obiettivo
primario che s’intende perseguire è di ridurre gli scarichi in mare, in
particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle
navi che scalano i porti nazionali. Non ultimo, migliorare la disponibilità e
l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei citati rifiuti e residui.
E’ utile
analizzare dapprima la terminologia introdotta dalla norma, poiché, in effetti,
l’art. 2 individua opportunamente il concetto di rifiuto prodotto dalla nave,
di residuo del carico, di impianto portuale di raccolta nonché di “autorità
competente”, sulla cui trattazione risulterà quanto mai essenziale spendere
qualche riflessione.
A livello
generale, la materia, affonda le sue prime radici nella definizione individuata
dal D.Lgs 22/97, quale “legge quadro generale sui rifiuti di ogni natura e
composizione, sia solidi che liquidi”; talchè le definizioni fornite dal
decreto 182/2003, offrono all’utenza ed alla collettività in stretta sinergia
con il sistema “scalo marittimo”, una visione piu’ definita del settore
“rifiuti portuali”.
Sebbene il
“Decreto Ronchi”, abbia definito come rifiuto “qualsiasi sostanza che
rientra nelle categorie riportate nell’allegato A1 e di cui il
detentore si disfi, abbia l’intenzione di disfarsi o abbia l’obbligo di
disfarsi, è da precisare che fino al 31/12/2005, le acque di lavaggio e quelle
di sentina prodotte dalle navi, sono sottratte al regime del decreto in
itinere sicché devono essere conferite secondo quanto disposto dall’art.
10 bis della Legge n. 47 del 27/02/2004.
Il rifiuto
prodotto dalla nave, costituisce in termini di conditio
sine qua non, una categoria piuttosto rappresentativa e materialmente ben
definita in cui confluiscono i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui
diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a
bordo di una nave e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati
I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle
linee guida definite a livello comunitario per l’attuazione dell’allegato V
della Marpol 73/78.
Nei residui del
carico rientrano i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico
contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine
delle operazioni di scarico o di pulizia. Sono comprese altresì, anche le acque
di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, se venute a contatto con il carico o i
suoi residui; i resti, de quo, comprendono eccedenze di carico – scarico e
fuoriuscite.
L’impianto
portuale di raccolta è definito come una qualsiasi struttura fissa,
galleggiante o mobile collocata all’interno del porto dove possono essere
conferiti i rifiuti della nave ed i residui del carico prima che vengano avviati
al recupero o allo smaltimento. Infine, con il termine di “autorità
competente”, il legislatore, fa riferimento dapprima all’Autorità Portuale
ed in via secondaria, laddove la medesima non fosse stata istituita ai sensi
della Legge del 20 gennaio 1994 n. 84, all’Autorità Marittima, il cui ruolo,
è bene precisarlo, rimane comunque fondamentale, indipendentemente dal fatto
che operi o meno in via esclusiva.
Destinatari
della norma sono le navi, i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a
prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello
stato; per le unità militari da guerra ed ausiliarie e le altre navi possedute
o gestite dallo stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non
commerciali, è prevista una deroga in attesa dell’emanazione del decreto
concernente le misure da adottare in considerazione
delle specifiche prescrizioni tecniche e delle caratteristiche di ogni
classe di unità.
Ogni porto è
dotato di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle
navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello
stesso porto2.
Il soggetto
pubblico o privato che intende realizzare un impianto fisso di raccolta, deve
dapprima ottenere il rilascio di una concessione demaniale dall’ Autorità
Portuale ai sensi dell’art. 18 della Legge 84/94, limitatamente agli scali
marittimi ove la stessa sia stata istituita, collocandosi tale struttura
nell’ambito portuale così come individuato dal “Piano regolatore
portuale”3.
Di contro, le
incombenze amministrative dell’atto concessorio ricadranno sull’Autorità
Marittima, che esplica la sua funzione amministrativa attraverso il Capo del
Compartimento Marittimo o Direttore marittimo, fermo restando che per il
rilascio delle concessioni di durata superiore ai 15 anni la competenza ricade
sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Altro aspetto
saliente e giuridicamente fondamentale per il soggetto che intende operare in
porto è, altresì, l’autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per
territorio ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97, la cui validità è di
5 anni, rinnovabile alla scadenza.
In ultima
analisi, in tale nuovo contesto legislativo si colloca anche, ed è bene
evidenziarlo sotto un profilo di politica socio - economica moderna in cui si
tende a valorizzare, sviluppare ed estendere il concetto di “mercato unico
europeo”, l’istituto della “gara ad evidenza pubblica” per
l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali e del
servizio di raccolta dei rifiuti, in conformità alla legislazione nazionale e
comunitaria vigente.
Per quanto
riguarda il controllo e l’autorizzazione all’espletamento delle operazioni
di carico e scarico, trasporto, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali,
l’ambito è regolato dal combinato disposto dall’art. 16 della legge 84/94 e
dall’art. 28, comma 6, del D.Lgs 22/97; ne consegue, quindi, la subordinazione
ad un atto autorizzativo da parte dell’Autorità Portuale o, laddove non
istituita, dall’Autorità Marittima.
Mentre nel
primo caso le Capitanerie di Porto svolgono attività di controllo e di polizia
sotto l’aspetto inerente la “sicurezza della navigazione”, ed in effetti
tale compito è riconosciuto anche in seno alla legislazione portuale del 1994
piu’ volte citata; nel secondo, invece, espletano anche funzioni
amministrative vere e proprie attraverso, appunto, il rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio delle operazioni commerciali che, come si è
detto, ricomprendono il carico, lo scarico, il trasbordo, deposito e maneggio di
merci, materiali e persone in genere svolte in ambito portuale.
L’art. 6 del
decreto stabilisce che il comandante di una nave diretta verso uno scalo
nazionale deve notificare all’Autorità Marittima riportandoli su di un
apposito modulo i seguenti dati4 :
1)
nome della nave, indicativo radio, numero IMO;
2)
stato di bandiera;
3)
ora presunta di arrivo (ETA);
4)
ora presunta di partenza (ETD);
5)
precedente e successivo porto di scalo;
6)
ultimo porto di scalo in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti
dalla nave;
7)
la dicitura . . . intendete conferire tutti . . /alcuni . ./nessuno dei vostri rifiuti in impianti portuali di
raccolta?
8)
Tipo e quantitativo di rifiuti e residui da conferire o trattenuti a
bordo e percentuale della di stoccaggio della nave;
La notifica
deve effettuarsi almeno 24 ore prima dell’arrivo nel porto di scalo, se detto
porto è noto; non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto, a meno
di 24 ore dall’arrivo; prima della partenza dal porto di scalo precedente, se
la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
Ricevuta la
notifica, l’Autorità Marittima trasmetterà le informazioni all’Autorità
portuale, ai gestori dell’impianto di raccolta, agli uffici di Sanità
Marittima ed agli Uffici Veterinari di porto.
Le navi in
servizio di linea con scali frequenti e regolari possono fornire le informazioni
di cui sopra cumulativamente all’Autorità Marittima dello scalo di
conferimento dei rifiuti.
Ogni nave,
prima di lasciare il porto, dovrà conferire i rifiuti prodotti dalla nave
all’impianto portuale di raccolta, tuttavia può essere concessa una deroga
dall’ Autorità Marittima, dopo aver accertato, con l’ausilio dell’Autorità
Sanitaria e del Chimico del porto, che l’unità abbia una capacità di
stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che
saranno prodotti fino al momento dell’arrivo nel successivo scalo di
conferimento.
Il conferimento
dei rifiuti e dei residui ad un impianto di raccolta deve avvenire in conformità
alle disposizioni della Convenzione Marpol 73/78.
Le Capitanerie
di Porto, ai sensi dell’art. 11, hanno il compito di verificare l’osservanza
delle disposizioni relative alla fase del “conferimento”, dando attuazione
al D.M. n. 305/03 relativo all’attività di controllo dello stato di approdo5.
L’attività
di accertamento ha inizio con un’attenta valutazione del modulo di notifica e
della capacità di stoccaggio dei rifiuti a bordo in funzione degli spazi
disponibili, della durata del viaggio nonché delle possibilità di successivo
conferimento. Ne consegue, quindi, che in un siffatto quadro operativo, il
personale della Guardia Costiera, darà priorità ai casi in cui la notifica non
sia stata resa, oppure, anche se resa, la stessa risulti palesemente incongrua.
Inoltre, è da evidenziare come l’Autorità Marittima, in via del tutto
cautelativa, possa non esonerare la nave dall’obbligo di conferire i rifiuti
qualora il porto di destinazione sia sconosciuto o vi sia la certezza che il
medesimo non sia adeguatamente attrezzato per il conferimento.
L’inosservanza
della prescrizione sulla notifica determina l’irrogazione di una sanzione
amministrativa nei confronti del comandante della nave trasgredente, da 3000 a
30000 euro. Alla stessa sanzione soggiace quando non ottemperi ai disposti
inerenti la fase di conferimento dei rifiuti
e dei residui del carico, di cui agli artt. 7 e 10; inoltre, di tale
inosservanza ne viene data comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Per quanto
concerne i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, gli importi della sanzione
applicabile al comandante inadempiente, variano da un minimo di 103 euro ad un
massimo di 500 euro.
Pur essendo
state escluse dall’obbligo di notifica i pescherecci e le imbarcazioni da
diporto6 rimane fondamentale il ruolo assegnato alle Capitanerie di
Porto – Guardia Costiera – sull’attività di prevenzione, controllo
e vigilanza sull’osservanza degli
artt. 7 e 10 anche da parte di queste unità. Infatti, il comma 5 dell’art.
14, affida all’Autorità Marittima il compito di definire le procedure di
controllo atte ad espletare l’attività cui prima si è fatto riferimento7
(si pensi al potere di regolamentazione esplicabile a mezzo ordinanza).
I compiti che
vanno a delinearsi, quindi, si presentano piuttosto complessi e ricchi di
particolari caratteri e problematiche tecnico – operative, ai quali si può
ottemperare soltanto se si dispone di una grande responsabilità, dedizione e
professionalità. Tutte prerogative che da sempre hanno contraddistinto e
contraddistinguono gli uomini delle Capitanerie di Porto che si prodigano per la
salvaguardia della vita umana in mare, per la sicurezza della navigazione e del
personale marittimo e la protezione e salvaguardia dell’ambiente marino.
Cristian ROVITO
1 Previsto
dall’art. 6, comma 1, lett. A del Decreto Ronchi: sono riportati il catalogo
europeo dei rifiuti ed un indice in cui ogni rifiuto è classificato con un
codice di 6 cifre, Codice CER.
2 La
legge del 20/01/94, n 84 “riordino della legislazione in materia portuale”
ha classificato i porti i due categorie: porti I^ ctg. finalizzati alla difesa
militare e alla sicurezza dello stato, porti II^ ctg. ripartiti in tre classi
correlate alla rilevanza internazionale I^Cl., nazionale II^Cl., regionale e
interregionale III^Cl.
3 Art.
5 della Legge del 20 Gennaio 1994, n. 84
4
Allegato 3 al Decreto 182/03 “Modulo di dichiarazione contenente le
informazioni da notificare prima dell’entrata nel porto”;
5 Circolare
del Ministro dell’Ambiente e tutela del territorio del 09/03/2004 recante
“chiarimenti ed applicazione delle modifiche introdotte con la Legge del
27/02/2004, n. 47”.
6 La
legge del 08/07/2003 n. 172 recante “disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto del turismo nautico” classifica le unità da
diporto in natanti (unità da diporto a remi e unità di lunghezza pari o
inferiore a 10 m), imbarcazioni da diporto (unità da diporto di lunghezza
compreso tra 10 e 24 m) e navi da diporto (unità da diporto di lunghezza
superiore a 24 m).
7 L’Autorità Marittima
definisce le procedure di controllo atte a verificare il rispetto degli articoli
7 e 10 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate
per un massimo di dodici passeggeri.
(*) Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera –



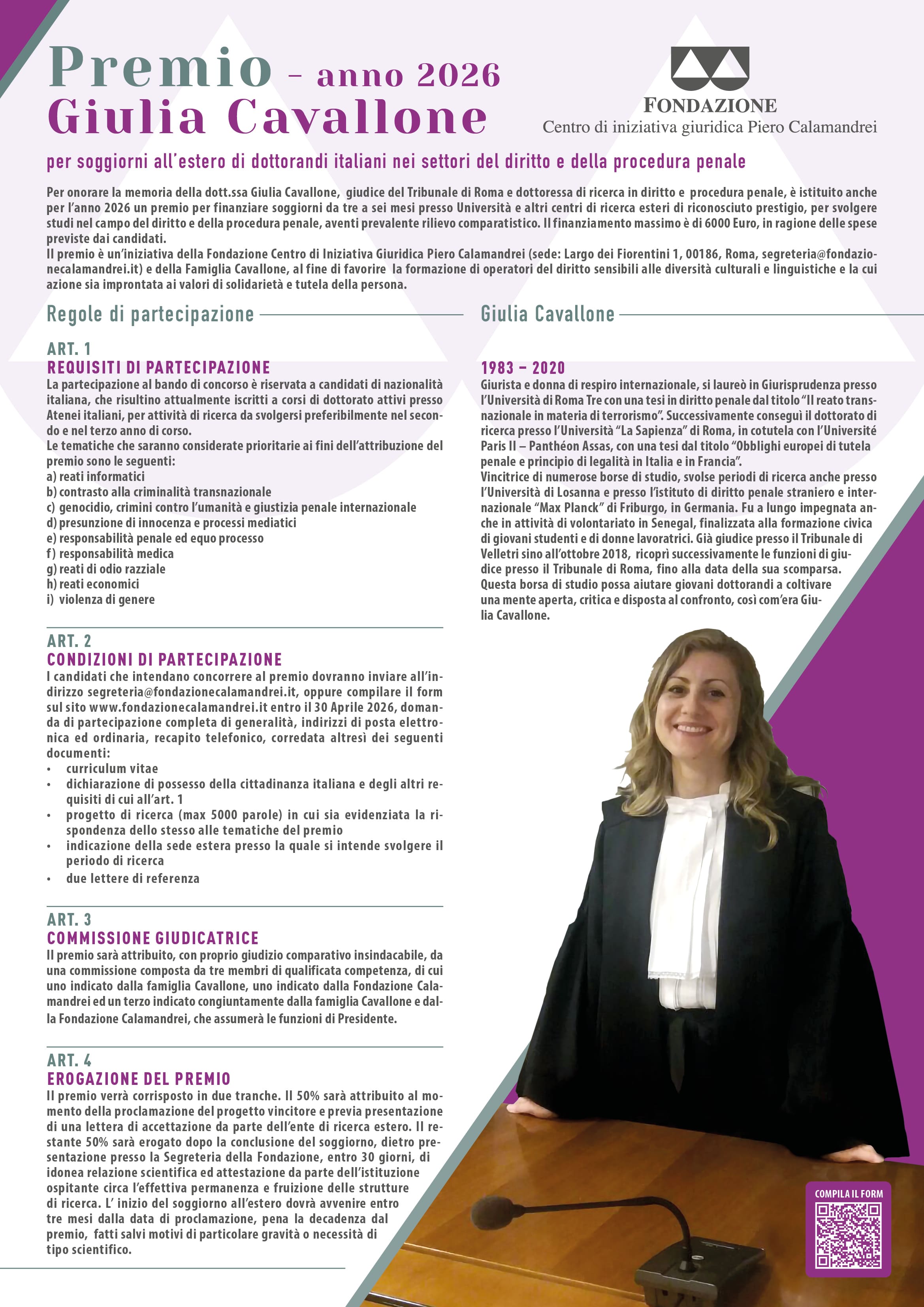 Scarica la locandina
Scarica la locandina

