 Brevi riflessioni sul piano gestione rifiuti regionale (o delle Provincie autonome) tra i princìpi (in particolare) di autosufficienza, prossimità, criteri ARERA su impianti minimi, autorizzazioni, ecc.
Brevi riflessioni sul piano gestione rifiuti regionale (o delle Provincie autonome) tra i princìpi (in particolare) di autosufficienza, prossimità, criteri ARERA su impianti minimi, autorizzazioni, ecc.
di Alberto PIEROBON
pubblicato su osservatorioagromafie.it. Si ringraziano Autore ed Editore.
1. Una visione più ampia tra intervento pubblico, mercato, autorità di regolazione. - 2. Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. - 3. I princìpi qui fanno capolino… cenni. - 4. I princìpi ambientali che vanno considerati… - 5. La programmazione pubblica nella considerazione dei princìpi di autosufficienza e di prossimità. - 6. Aspetti organizzativi implicati nel Piano per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. - 7. La disciplina regolatoria dell’ARERA: cenni. - 8. Prime combinazioni tra i princìpi di autosufficienza, prossimità e specializzazione. Attuazione autorizzativa.
1. -Una visione più ampia tra intervento pubblico, mercato, autorità di regolazione.In generale, ogni Stato democratico, anche nell’ambito dei servizi pubblici locali (SSPPLL) utilizza la eterocorrezione e la eterocompensazione del mercato, le quali funzionano in modo diverso con riferimento al diverso quadro di decentramento1.
Trattasi di strumenti che ricercano di assicurare le aperture dei mercati e il gioco della concorrenza nella finalità della tutela del consumatore e dell’equilibrio complessivo, onde favorire la funzione di ecosistema evolutivo.
In particolare, secondo l’ordinamento nazionale ed europeo (integrato) la concorrenza tutelata dev’essere workable, efficace, sufficiente a far rispettare le esigenze fondamentali che si riscontrano nel settore dei rifiuti urbani (RU) e speciali (RS).
Ecco perché – ricalcando l’insegnamento di Predieri – in questo contesto e tendenza, il mercato va:
- eterocorretto: quale condizione affinché il mercato sia concorrenziale, secondo le regole europee, in una fissazione di valori che deve essere comune al mercato e allo Stato, evitando che vi siano abusi di posizioni dominanti o di controllo congiunto, ecc. È anche un meccanismo di efficienza allocativa nella regolazione di processi economici, in un quadro di sussidiarietà. L’eterocorrezione si articola con norme e provvedimenti autoritativi agendo altresì sul mercato non sia in grado, appunto, di auto-correggersi per mantenere la sua funzione essenziale;
- eterocompensato: inteso nella doppia funzione di allocazione di risorse e della loro redistribuzione tendenti all’equilibrio e alla stabilità, compensando le disuguaglianze e le ingiustizie.
Gli indirizzi e i dosaggi di queste variabili avvengono nelle relazioni tra i vari livelli coinvolti: istituzionali, degli operatori, della comunità.
Giova ricordare che l’art. 5 della Cost. guarda al policentrismo della società. Nel tempo si è passati dal potere pubblicistico imprenditoriale (segnatamente dalle imprese partecipate statali) ad un potere regolatore, come pure dalla riserva per legge ai privati, al gioco (più o meno libero) della concorrenza.
Lo Stato regolatore è produttore di diritto, nella primazia normativa dell’Unione europea che ha reso il monopolio illegittimo e pure gli «aiuti di stato» contrari alle regole unionali, imponendo così la disapplicazione di norme (ad esempio gli artt. 43, 44, 45 Cost.) nella regola della concorrenza. Anche l’art. 41 Cost. sull’iniziativa economica privata fa riferimento all’utilità sociale nei limiti imposti dalla specificazione della concorrenza come obiettivo di questa utilità sociale.
La tendenza è ora quella di separare la funzione regolativa e sanzionatoria da quella allocativa e promozionale del mercato, agendo con più meccanismi: normativi, amministrativi e imprenditoriali, di mercato; nella preferenza di moduli convenzionali di accordi tra amministrazioni pubbliche e di contratti tra amministrazioni pubbliche e imprese.
Quindi l’organizzazione e il bilanciamento del mercato, anche nel settore dei rifiuti e della concorrenza, riguardano i soggetti pubblici e privati, in funzione di un equilibrio generale politico e di altri equilibri particolari, ad es. avendo a riferimento le specificità territoriali e autonomistiche, ecc. nonché i valori costituzionali.
Peraltro, non illudiamoci che l’economia di mercato sia di mero mercato, ossia quella chimerica e meccanica formazione di prezzi tra una pura domanda ed offerta, essendo piuttosto ben altro: impresa, autoproduzione, Stato, produzione pubblica di beni collettivi e di esternalità positive che il mercato non può produrre (queste sono infatti le c.d. “esternalità”), allocazione pubblica, ecc.
Pertanto, lo Stato – e le altre Autorità competenti – devono evitare che si producano degli effetti negativi, cioè le famose «esternalità negative», piuttosto producendo «esternalità positive», a beneficio anche delle generazioni future. Insomma, occorre – tra altro 2 – ridurre le cosiddette “diseconomie”, operando come fattore dell’economia, nella più ampia visione della solidarietà.
Oggigiorno la legislazione di tutela del mercato vede l’intervento di più «Autorità Amministrative Indipendenti» (AAAAII) che devono bilanciare diversi diritti costituzionalmente garantiti, nella prevalente funzione di regolazione di vari settori economici, per quanto qui ci riguarda: ricordiamo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’Autorità Nazionale di Regolazione dell’Energia Reti e Ambiente (ARERA), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), eccetera.
Le AAAAII svolgono le loro funzioni anche in attuazione di talune norme costituzionali: il già citato art. 41 Cost. ma più ancora l’art. 3, comma 2, Cost. il quale ultimo è considerato dal Predieri la «chiave del sistema in cui l’organizzazione dello Stato opera come organizzazione fra organizzazioni» e quindi nel mercato che è organizzazione.
Nell’ambito della liberalizzazione dei Servizi Pubblici Locali (SSPPLL), come quelli sul servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (SIGRU), con caratteristiche di “universalità” 3 e di “accessibilità”, anche i SSPPLL (e le public utilities)sono condizionati dalla rivisitazione delle regole del gioco e dei sistemi di disciplina settoriale, ove si cerca di promuovere l’efficienza, la concorrenza e adeguati livelli di qualità dei servizi a tutela dei cittadini-utenti.
Com’è noto, nel settore della gestione dei rifiuti urbani l’Autorità nazionale di regolazione è l’ARERA 4 che ha funzioni implicanti l’esercizio di poteri amministrativi in materia tariffaria; qualità del servizio5; assetto del mercato; accesso ai mercati e ai servizi; conformazione della struttura e controllo imprese; tutela della concorrenza e sua promozione; efficienza dei servizi. Inoltre l’ARERA ha compiti di informazione e di trasparenza e monitoraggio del settore, godendo anche di potestà consultiva e persino normativa, che in alcuni casi è talmente pervasiva da incidere sulla stessa autonomia contrattuale delle parti, imponendo di inserire nei contratti bilaterali clausole negoziali o regolamentazioni tecniche (c.d. eteronormazione), ecc.6.
Ecco perché la «regolazione» va intesa quale «potere amministrativo di correzione alle irregolarità nel funzionamento del mercato economico, in cui gli atti amministrativi (anche delle Autorità amministrative indipendenti N.d.R.) sono divenuti fonte di diritto obiettivo»7.
Questo potere amministrativo viene, nella regolazione, posto di fronte alla necessaria «correzione» delle cosiddette «irregolarità» nel funzionamento del mercato economico.
Sono correzioni, per loro natura, spesso non predeterminabili, ma ricavabili dalla cosiddetta regola della «natura delle cose» 8 che sono, appunto, da regolare perché il mercato sia concorrenziale.
Insomma, l’intervento pubblico dovrebbe, tra altro, migliorare l’efficienza nel ridurre il divario tra i costi privati e sociali, e, l’efficienza dei mercati diventa ragione ed oggetto dell’attività delle AAAAII, in particolare dell’ARERA, determinando il mercato efficiente, ovvero apprestano rimedi contro le inerzie pubbliche e private, ciò avviene utilizzando il parametro dell’efficienza, nel passaggio dal mercato non regolato al mercato regolato, così come sta avvenendo per i SSPPLL dei rifiuti tramite la nuova una disciplina tariffaria ed altro ancora.
2. -Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (d’ora in poi «PNGR»), previsto dall’art. 198 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d’ora in poi «TUA»), come introdotto dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha modificato, tra altro, l’art. 195 (Competenze dello Stato), comma 1, viene definito «uno strumento strategico di indirizzo» nella pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, con validità sessennale (quindi per il periodo dal 2022 al 2028), salvo intervengano altre modifiche o novità.
Il PNGR è un documento che si approccia alla transizione ecologica, nel quale rimangono:
a) talune questioni indeterminate concernenti la produzione, quantificazione e qualificazione dei RU, oltre che le esclusioni, i sottoprodotti, l’End of Waste, ecc. per le quali questioni esso rinvia giustamente alla normativa europea, oltre a quella nazionale;
b) da precisare le interpenetrazioni tra i RU e i RS, sintomatica è la vicenda del sub-flusso dei RU/RS di cui al codice EER 1912129, come pure i rifiuti da inquinamento-bonifiche, i fanghi, ecc. Il PNGR sul punto rinvia al censimento dei flussi e sub-flussi correlati alle discipline di specialità delle varie tipologie di rifiuti, oltre a quelle di altri settori;
c) altre questioni interpretative aventi una rilevante ricaduta nella pianificazione, come pure nell’operatività, ad esempio: la delimitazione dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) che porta con sé il principio di autosufficienza e il principio di prossimità (di cui all’art. 16 direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) ed altri ancora sui quali vedasi oltre;
d) la settorializzazione disciplinare e dei diversi livelli di autonomia tra la disciplina dei rifiuti dei SSPPLL e del mercato pubblico/privato, nonché dei contratti pubblici nei vari modelli e forme utilizzabili (ad es. gestione diretta in economia, appalti, concessioni, affidamenti in house, ecc.) di cui al nuovo codice dei contratti pubblici (NCCP) (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), ma anche del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 sul riordino dei SSPPLL di rilevanza economica.
Si tratta, infatti, di un «Programma» (si noti: non di un Piano) sul quale poi si innestano e/o derivano i Piani regionali o delle Provincie autonome.
3. -I princìpi qui fanno capolino… cenni.Attualmente siamo in una epoca ove a fronte dell’inadeguatezza della legge, della sua interpretazione e applicazione, riemergono e danno luce i princìpi che non sono una categoria unitaria10, pur presentando essi dei tratti omogenei. L’approccio principialista va oltre la codicistica, e, pur rimanendo nell’ambito giuridico, ha una propria giustificazione valoriale di fondo per la quale le prescrizioni normative devono, per l’appunto, presupporre questi valori, in una riflessione che è piuttosto bottom-up che top-down11.
I princìpi si distinguono tra «princìpi-valore» (es. proporzionalità, affidamento, trasparenza, non discriminazione) e «princìpi-regole» i quali ultimi sono immediatamente cogenti. Ad esempio, nel NCCP i princìpi-valore sono: il principio del risultato (art. 1, commi 1, 2, 3); il principio della fiducia (art. 2, commi 1 e 3, in attuazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione exart. 97 Cost.); il principio di accesso al mercato (art. 3).
Per i princìpi valore si effettua il bilanciamento (che, invece, non avviene per i princìpi-regole) applicando le norme in coerenza con i parametri della logicità e razionalità o, in altri termini, dell’elasticità, per l’esercizio della discrezionalità.
Va notato che il principio del risultato non si richiama alla concezione e al metodo aziendalistico (del new public management) perché in quest’ultimo occorre una correlazione col rischio di impresa necessariamente intermediata dal profitto. Piuttosto con questo principio si intende rilanciare la discrezionalità amministrativa, in un corretto rapporto tra il legislatore e l’amministrazione alla quale ultima sono riservati spazi di valutazione necessaria.
In questo scenario l’affidamento c.d. in house providing 12 rimane una eccezione, sempre in nome della concorrenza, la quale ultima non è però un fine, piuttosto è uno strumento che si accompagna al confronto competitivo.
Inoltre, non è affatto detto che la tutela della concorrenza debba realizzarsi “meccanicamente” imponendo procedimenti di gara più complessi, preferendoli a modelli di confronto competitivo semplificato, né che la tutela della concorrenza suggerisca una riduzione della discrezionalità amministrativa e della stessa logica del risultato, dove l’una e l’altro invece possono ben trovare attuazione.
Addirittura, recentemente, circa l’ambito del NCCP è stato affermato che il principio di risultato asservisce tutti gli altri princìpi, persino quelli eurounitari della concorrenza e della trasparenza che devono normalmente presiedere allo svolgimento delle gare. In tal senso questi ultimi princìpi dovrebbero considerarsi ancillari al risultato, addirittura potendo esser sacrificati, ove necessario, in virtù di esso13.
Va notato che tra i princìpi generali (PG) e i princìpi di settore (ad es. quelli ambientali del TUA che sono anche di matrice unionale) sono questi ultimi a prevalere per la specialità, a meno che i PG non siano dotatati di base costituzionale o unionale.
Laddove si abbiano princìpi di pari grado dovrà usarsi il criterio della ragionevolezza e della necessaria considerazione (nella valutazione comparativa) di tutti gli interessi coinvolti. In proposito, si veda la sentenza della Corte costituzionale 23 novembre 2021, n. 218 per la quale il proseguimento delle finalità proconcorrenziali incontra pur sempre il limite, appunto, della ragionevolezza e della necessaria considerazione di tutti gli interessi coinvolti.
Invero, la tutela da apprestarsi è sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro (sentenza n. 64/2012 richiamata dalla sentenza della Corte cost. 8 aprile 2013, n. 85, parte 9 in diritto)».
Ricordiamo che i “nuovi” princìpi superano le attuali categorie dei princìpi «fondamentali» (art. 117 Cost.) 14 e «fissati» (es. artt. 6-7 del Testo Unico Enti Locali o TUEL) 15 avendo una carica innovativa e che sono onnicomprensivi, nel senso che sono princìpi di legislazione, e princìpi basilari, di struttura.
Trattasi quindi di «regole delle regole», di «norme delle norme», e costituiscono i princìpi che saranno poi sviluppati in altre norme relative a fattispecie o argomenti o materie simili.
Eccoci, quindi, alla «interpretazione congiunta» che determina un «parametro interpretativo».
Ora, i princìpi vanno calati nelle attuali forme di produzione (che non sono le classiche fonti a cui ci hanno abituato) di nuove norme che contemplano anche i Piani, i quali vengono perlopiù formulati in termini discorsivi, nelle finalità della programmazione delle attività dei diversi settori.
I Piani sono com’è noto degli atti amministrativi generali, ma la sintesi della disciplina quivi contenuta deve riguardare le norme legislative statali che fanno riferimento ad essi, costituendo questa sintesi il citato «parametro normativo che è duttile (poiché va interpretato e applicato alla fattispecie concreta) considerato che i princìpi costituiscono la premessa maggiore di un sillogismo giuridico, ma che sono uniti alle altre norme gerarchicamente inferiori»16.
Per cui, a seconda, il rapporto (sempre più sbiadito) generale/speciale si potrà configurare nei limiti individuati nella compatibilità o meno di una norma speciale (NS) rispetto alla norma generale (NG).
I “nuovi” princìpi richiamabili per i Piani rapportati alle disposizioni specifiche, consentono all’interprete di avvicinarsi maggiormente alla certezza giuridica, talché le eventuali NS devono essere inserite, per alcuni settori, nel principio stesso stabilendo i settori, i casi e tempi della deroga17.
Tutti questi nuovi problemi, in particolare della necessità dell’applicazione congiunta, mostrano che un siffatto sillogismo giuridico diventa il meccanismo necessario e valido per i problemi del diritto. Oggigiorno vi sono notevoli cambiamenti nella premessa maggiore del sillogismo, che è costituita da un parametro dove non esiste una sola premessa, ma ve ne sono due o più, che sono stabilite dalle regole collocate in posizione gerarchica, e la stessa cosa vale per la premessa minore.
Per cui l’attuale sistema normativo si presenta – secondo la lettura di Italia – in una sorta di “scacchiera” diversa da quella del passato, infatti ora il sillogismo deve essere adattato perché l’interpretazione e l’applicazione congiunta consenta all’interprete di altresì disporre di una discrezionalità molto ampia, formulandosi – appunto – il sillogismo sulla base di una perspicua costruzione normativa.
Tutto questo va effettuato attraverso la scelta della norma o della legge o del principio che sono nella «scalinata normativa gerarchica» e che l’interprete ritiene essere più adatto a risolvere il problema18.
4. -I princìpi ambientali che vanno considerati…Com’è noto il principio di precauzione costituisce un principio generale del diritto ambientale , prevalente sugli interessi economici come è stato precisato in varie sentenze degli organi di giustizia europei19, altresì in questo settore si hanno altri fondamentali princìpi, quali in base all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’UE o TFUE: il principio di prevenzione; il principio dell’azione preventiva e di correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente; il principio chi inquina paga; il principio di maggiore protezione, ecc. Sono princìpi che una esperta dottrina ha inquadrato tra le «norme di azione» (non «di relazione») produttive di «obblighi di conformazione»20.
Ma vanno tenuti in considerazione anche i valori sostanziali da tutelare in relazione al «principio di concorrenza», come pure a quello di «chi inquina paga» e altri ancora, in un sillogismo giuridico che – ancorché su elementi indeterminati del ragionamento – deve essere svolto.
Infatti, la metodologia comparativa specie in materia ambientale non va applicata in modo formalistico, essendo «fondamentale l’indagine sul ruolo concreto degli istituti realmente vigenti dei diritti nazionali, al fine di verificare l’effettività delle espressioni formali contenute nei documenti e nei testi normativi (ovvero N.d.R.) approfondire la distinzione tra diritto apparente (... law in the books) e diritto vivente (... law in action)21».
Come si vedrà in prosieguo, il principio dell’autosufficienza – che va riferito a un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) o Bacinale – è un principio fondamentale del c.d. “diritto comunitario derivato” (regolamenti e direttive) 22 prescrivendo, nel criterio ordinatore territoriale, l’adozione di misure finalizzate alla realizzazione di un SIGRU, attraverso la «realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di trattamento»23.
In proposito la sentenza Corte di giustizia UE del 12 dicembre 2013, in causa C-292/12, par. 59 richiamava anche il principio di prossimità ove «In forza dell’art. 16 della direttiva 2008/98, gli Stati membri sono tenuti a istituire una rete integrata ed adeguata di impianti di trattamento dei rifiuti destinati allo smaltimento e dei rifiuti urbani non differenziati che sono raccolti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, e concependo tale rete, in particolare, in modo tale da consentire loro di raggiungere individualmente l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e che tale trattamento possa aver luogo in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione di tali rifiuti».
Il principio di autosufficienza, come vedremo, è connesso al principio della prossimità e al principio della specializzazione, minimizzando la movimentazione e circolazione dei rifiuti e avviando i rifiuti agli impianti che possiedono il trattamento più appropriato, a seconda delle tipologie dei rifiuti e loro pericolosità.
In questa ricostruzione merita evidenziare la natura organizzativa, con programmi di azione del criterio dell’ATO24. Pertanto, anche la sua pianificazione va conciliata con la libertà di iniziativa economica, il mercato unico e la libertà di concorrenza.
In questa complessiva “rete” o “arcipelago” di riferimento, si dovrà quindi opportunamente valutare il livello di c.d. “neutralità” dell’Autorità di ATO (o EGATO) circa l’attitudine concorrenziale, considerando, per l’appunto, i princìpi di autosufficienza, prossimità e specializzazione nel settore dei rifiuti.
All’interno del Piano di gestione dei rifiuti, ciò rileva e va ponderato, oltre che nel versante della governance, anche in quello gestorio, sui regimi c.d. di privativa, correlati ai surrichiamati princìpi di autosufficienza e di prossimità in materia di rifiuti, altresì considerando il perimetro e il modello del servizio pubblico dei rifiuti urbani in rapporto all’ATO e alle figure della nuova governance.
In generale si è inteso superare la situazione della frammentazione in cui versano molti ATO richiamando l’art. 182 bis del TUA relativo alla autosufficienza e prossimità di una rete integrata e adeguata di impianti secondo le migliori tecnologie disponibili e nel rapporto costi-benefici, con l’art. 200 del TUA, onde far smaltire i rifiuti urbani nell’impianto più vicino al luogo di raccolta, considerati gli aspetti ambientali implicati nella loro movimentazione e trasporto.
Al contempo nelle scelte dell’ATO-EGATO occorre valutare le potenziali conseguenze anticoncorrenziali sulla gestione integrata del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come pure sulle singole fasi gestionali.
5. -La programmazione pubblica nella considerazione dei princìpi di autosufficienza e di prossimità.Al di là della rete integrata e adeguata di impianti (cfr. sent. Corte di giustizia UE 12 dicembre 2013, in causa C-292/12 cit.), va ricordato che per l’art. 16 della cit. direttiva 2008/98/CE si deve consentire alla Unione europea di raggiungere l’autosufficienza, sia nello smaltimento che nel recupero dei RU, potendo anche limitare le spedizioni in uscita dei rifiuti per motivi ambientali o qualora non siano recuperati con standard equivalenti a quelli europei exregolamento n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006. Per il ‘considerando’ n. 33 della direttiva 2008/98/CE ai fini dell’applicazione del cit. regolamento i RU indifferenziati rimangono tali «anche quando sono stati oggetto di una operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà»25.
Com’è noto, l’autosufficienza nella concreta applicazione, in una ottica anche sostanzialista, non può che rifarsi alla fase programmatoria, che sta a monte (cioè quella del Piano), allorquando vengono censiti i flussi (e sub-flussi) quali-quantitativi dei RU prodotti, mentre per i RS originati direttamente dai produttori “iniziali” (non tanto dei «nuovi produttori» che trattano RU e pure RS26), la produzione non è predeterminabile, appunto perché inserita nel c.d. “libero” mercato, con dati non del tutto attendibili ancorché venga effettuata una analisi storico-statistica27.
Qui, vanno preliminarmente considerati altri effetti, oltre all’incidenza dei prefati princìpi di autosufficienza/prossimità, nonché di specializzazione.
In proposito si ricordano ancora, non esaustivamente: la perimetrazione del SSPPLL; il regime di privativa e del fuori o extra privativa; il regime fiscale dei diversi sistemi RU e RS, come pure le differenti applicazioni dell’ecotassa, e così via.
Sempre argomentando sui RU/RS e sui rifiuti (che possono essere RU o RS) di cui al codice EER 191212, correlati non solo alla loro qualificazione, ma pure agli impianti di destino e alle procedure da rispettare, anche con riferimento ai princìpi di autosufficienza e di prossimità, recentissimamente si è espressa la Commissione europea, servizio giuridico, in data 23 novembre 2020, sj.h.(2020) 7664812, in seguito all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4196/2020, che ha inviato alla Corte di giustizia le proprie osservazioni scritte nella causa C-315/20 Regione Veneto/Plan Eco Srl avente ad oggetto, appunto, questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del cit. regolamento n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE28. Ove la natura dei rifiuti sia effettivamente diversa, la disciplina sulla spedizione transfrontaliera di rifiuti destinati al recupero (art. 12, 1 reg. cit.) non prevede un riferimento ai princìpi di prossimità e di autosufficienza29.
Per quanto riguarda la questione dello smaltimento connessa alla autosufficienza bacinale, ma anche agli eventuali divieti di conferire rifiuti teoricamente recuperabili ad impianti di smaltimento, come leggibile nel complessivo mosaico normativo e, recentemente oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 20 giugno 2024, n. 5511 (decisa il 21 marzo 2024) basti rinviare a una mia recente ricostruzione30.
6. -Aspetti organizzativi implicati nel Piano per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.Il Piano, alla luce delle considerazioni e riferimenti dianzi lumeggiati, deve considerare le dosi e proporzioni nelle scelte da determinarsi, considerando, tra l’altro, oltre alla surrichiamata normativa e ai princìpi, altresì: le economie di scala; di scopo; di densità; i costi di transazione/dissociazione, tra rappresentanza democratica e controllo della gestione (ad es. nei modelli degli organi di governo di tipo derivato); le competenze tecniche necessarie per le maggiori complessità da affrontare; la frammentazione e gli squilibri dimensionali tra i Comuni e/o Comprensori; il c.d. principio di differenziazione, superando la uniformità; il principio di adeguatezza delle dimensioni delle organizzazioni alle funzioni; eccetera.
Il tutto ovviamente tenendo conto dei dati strutturali del contesto locale e delle sue caratteristiche ambientali, sociali, economiche, demografiche, peculiarità territoriali, ecc.
È chiaro che dal punto di vista organizzativo-gestionale, nel principio gestionale di unitarietà (si badi: non di unicità come avviene nel Settore Idrico Integrato o SII), gli assetti organizzativi e funzionali degli ATO sono complessi ad es.: nelle componenti a monte della filiera labour intensive , delle economie di densità e dei bacini di utenza frequentemente provinciali, dei requisiti di merit good, etc., come pure nei segmenti a valle che sono capital intensive, delle significative economie di scala, dei bacini più ampi, dei fabbisogni di investimenti e aperti alla concorrenza tra diversi operatori tramite autorizzazioni rilasciate dalle Regioni o Provincie, ecc.31.
Un altro aspetto da considerare riguarda l’integrazione verticale od orizzontale del SGIRU non priva di aspetti problematici sotto il profilo della competizione32. Tanto rileva quantomeno per certuna impiantistica (vedasi gli impianti cosiddetti a tecnologia complessa) in base all’art. 200, comma 1, lett. a) del TUA, che riguarda anche il contratto di servizio tra la gli enti locali (o l’EGATO) e il gestore.
Peraltro, i princìpi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti (urbani e speciali) consentono alle autorità pubbliche competenti di determinarsi anche sulla responsabilizzazione relativa alle già richiamate «esternalità negative». Di qui la caratterizzazione sistemica e globale del sistema, trattandosi l’ATO-EGATO di un modulo organizzativo che riguarda anche la tutela ambientale (gli interessi cosiddetti super-individuali) più adeguata al contesto territoriale, auspicabilmente funzionalizzando l’attività dal gestore all’utente nella nuova responsabilità estesa dei produttori (o REP)33.
Essendo la tutela ambientale anche un principio di azione34, essa vincola l’attività dei soggetti pubblici e privati conformando le attività umane giuridicamente rilevanti, nella scansione per cui le norme costituzionali e i princìpi ambientali (soprattutto europei) sono attuati legislativamente (es. dalle singole discipline, testunificate e non) e poi implementati da vari strumenti, nell’ambito delle rispettive competenze.
Per l’ARERA il miglior approccio rimane quello cosiddetto “funzionalista” anche nell’allocazione dei compiti amministrativi ed altri aspetti di cui alle posizioni di ARERA manifestate sul metodo tariffario che impingono in molti altri aspetti organizzativi e gestionali.
Tornando al rapporto tra i princìpi di autosufficienza e di prossimità rispetto ai princìpi e alle regole di matrice euro-unitaria relativi alla realizzazione del mercato interno, funzionale cioè «alla creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa» 35 è il valore fondamentale della protezione dell’ambiente (peraltro riconosciuto sia nelle disposizioni generali dei Trattati, sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea36) che consente una loro declinazione settoriale richiamando, come detto in una «interpretazione congiunta», i princìpi generali in materia di protezione dell’ambiente e talune misure restrittive della concorrenza.
Non si tratta necessariamente dei «diritti speciali o esclusivi» di cui all’art. 106 del TFUE (uguale all’art. 8 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, c.d. «Leggeantitrust») che gli Stati possono attribuire a singole imprese che svolgono «servizi di interesse economico generale» (SIEG), per esercitare monopolio o riserva di attività.
Questa rispondenza all’interesse generale porta a individuare i relativi servizi da parte delle articolazioni interne (competenze), dove, sempre per il Predieri, «l’indirizzo politico può diversificarsi a livello regionale anche nella scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione» essendo una chiara scelta politica, nei limiti del principio di proporzionalità, della sussidiarietà orizzontale e della necessità di una efficace allocazione delle risorse.
Si tratta degli obblighi di pubblico servizio che impegnano l’amministrazione a determinare prestazioni a favore degli utenti, ove i princìpi di autosufficienza e di prossimità si limitano a porre discipline conformative delle attività, giacché le promananti restrizioni alle libertà economiche vanno intese in questa prospettiva.
Quindi il mercato ha un limite nei princìpi di matrice ambientalistica, in base a considerazioni di carattere “sociale” che prevedono spazi per l’autonomia statale nella determinazione dei regimi economici delle attività37.
E sono proprio i princìpi di autosufficienza e di prossimità che rendono possibile la funzione di regolazione e l’emersione di percorsi nel rapporto tra pubblico servizio, territorio e collettività.
Così per il SIGR potrebbe essere progettato dagli enti titolari del SPL in una scelta politico-assiologica circa la responsabilità delle cosiddette «esternalità ambientali» poiché incidenti nelle collettività, coinvolgendo i soggetti produttrici di rifiuti, investendo i pubblici poteri – che sono espressione di quelle stesse collettività – nella doverosità, conseguente alla erogazione del SPL, di organizzare e approntare sul proprio territorio un’adeguata rete infrastrutturale (si pensi alla impiantistica nei suoi vari livelli) per il SIGR.
Ovviamente sono altresì decisivi gli indici normativi ritraibili dalla disciplina sull’affidamento della gestione del SPL e di quella concretabile nel contratto di servizio tra gli enti locali (o l’Ente di governo ove istituito e funzionante) e i gestori o il gestore. Gli ATO potrebbero infatti non assolvere a una funzione pro-concorrenziale, essendo anzitutto preposti al conseguimento di obiettivi di tutela ambientale, costituendo essi uno degli strumenti per la realizzazione di una specifica politica industriale dei RU nel settore delle public utilities.
Ognun si avvede che si tratta di una mission composita contemplante una organizzazione di attività per gli obiettivi, abbracciante visioni, contenendo elementi e considerazioni ambientali, sociali, economiche, che vanno riconsiderate nonostante possano essere implicate alla maggiore complessità di fasi del SPL capital intensive.
7. -La disciplina regolatoria dell’ARERA: cenni.Come accennato, la regolazione dell’ARERA anche in materia di RU, è atipica in quanto paralegislativa, certamente non rientrando nella legislazione amministrativa, anche se bisogna vedere – di volta in volta – il contenuto della norma che disciplina l’esercizio del potere amministrativo attribuito all’ARERA.
Generalmente parlando, tutto nasce dalla volontà, soprattutto europea, di realizzare e omogeneizzare (se non simulare, laddove inesistente: nel caso del «fallimento del mercato») un mercato concorrenziale, tramite provvedimenti amministrativi disciplinanti i negozi giuridici di diritto privato e, in qualche caso, anche sostitutivi dei negozi giuridici di diritto privato38.
Come una autorevole dottrina ha affermato «per tutelare la concorrenza libera, vi sono da un lato le politiche antitrust per vietare i comportamenti scorretti e dall’altro le politiche di regolazione, lì dove servono, per i fallimenti di mercato (...epperò N.d.R.) mancano valutazioni politico-amministrativo-economiche per le quali potrebbe servire la discrezionalità (...) il nodo sta altrove: nella legittimazione politico-rappresentativa dei centri di potere amministrativo, nella riconduzione a unità del pluralismo istituzionale amministrativo (...) e in una equilibrata distribuzione di potere e responsabilità»39.
L’ARERA continua nella sua attività disciplinante il settore dei RU, da ultimo citasi le deliberazioni: 27 dicembre 2024, n. 596 recante la «definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»; 29 luglio 2025, n. 355 recante «Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57 bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.p. 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/COM, 366/R/COM, 55/2018/E/IDR e al TICO»; 29 luglio 2025, n. 373 recante «Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani»; 29 luglio 2025, n. 374 recante «Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/R/rif»; 5 agosto 2025, n. 396/2025/R/rif avente per oggetto «Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti»; 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif recante la «Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-202». Sempre l’ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 è intervenuta sul sistema impiantistico, incidendo anche su aspetti programmatori del SIGRU e quindi rilevando agli effetti del PGRU.
Si badi che i flussi dei RU vengono dall’ARERA considerati essere rilevanti indipendentemente dalla classificazione assunta nel processo di trattamento finale e intermedio escludendosi gli impianti «riconducibili alle filiere del riciclaggio, destinati al recupero di materia» – che ne modifica la natura e la composizione chimica, giacché prevalgono le attribuzioni regolatorie.
Tanto ci riporta alla già lambita problematica dei sub-flussi e alla dualità tra RU/RS, sintomaticamente osservabile, ad esempio, nel sintomatico flusso (o sub-flusso) del rifiuto codice EER 191212, apparentemente rientrante nella sola categoria dei RU40.
Ed è la impiantistica di chiusura per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che riporta – con le opzioni regolatorie – alla pianificazione ottimale bacinale, rispettosa dei noti obiettivi, potendo prevedere diverse opzioni strategiche.
Ma l’ARERA altresì introduce (cfr. del. n. 363/2021 cit. e il suo allegato «A») una tassonomia impiantistica (impianti «integrati», «minimi», «aggiuntivi») che si rifà all’attività di programmazione e settoriale di cui agli artt. 195, 198 bise 199 del TUA, ma anche all’art. 7 del cit. d.lgs. n. 201/2022 relativo al riordino dei SSPPLL a rilevanza economica41.
Più esattamente, per l’ARERA, gli impianti «minimi» vengono individuati «anche alla luce delle caratteristiche dell’operatore (...) presenti sul territorio» a certune condizioni e vengono individuati in ambito regionale o in macroaree, ipotizzandosi l’intervento governativo, nel quadro di un «progressivo dinamismo concorrenziale».
Si attenziona ancora sulla scelta funzionalista di ARERA, guardando alla classificazione dei RU assunta nel processo di trattamento finale e intermedio (Titolo VI del MTR-2) anche laddove si modifica la natura e la composizione chimica dei medesimi rifiuti, poiché essa classificazione per l’ARERA soggiace alle attribuzioni regolatorie, ovvero alle scelte politico-strategiche orientate-imposte dal MTR, anche nel rispetto delle posizioni manifestate dall’AGCM sulla libertà di circolazione dei rifiuti differenziati, distinguendo quelli organici e valutando la rilevanza dei mercati di sbocco, ciò in sinergia col MITE, richiamandosi al PNGR cit. dell’art. 198 bis TUA.
Qui l’ARERA guarda alla impiantistica cosiddetta «di chiusura per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani», ovviamente da raccordare con le opzioni regolatorie, con la pianificazione ottimale del bacino, etc. in una modulazione degli strumenti di regolazione che distingue, per l’ARERA, tra: impianti «integrati»: «ricompresi nell’affidamento al gestore della raccolta integrato, che gestisce almeno uno dei servizi a monte e a valle della catena del valore del settore, e soggetti a regolazione tariffaria». Esse gestioni adottano totalmente il metodo tariffario ARERA; impianti «minimi»: «(per la chiusura del ciclo): non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe»; impianti «aggiuntivi»: «impianti non integrati e non indispensabili che offrono sul libero mercato la propria capacità, soggetti a meri obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti». Solitamente si ricorre a questi impianti tramite le ordinanze contingibili ed urgenti, ad esempio per fronteggiare talune crisi od emergenze, oppure utilizzando altri moduli di accordo tra pubblico e privato (di programma, ecc.) e/o comunque nell’ambito dei contratti pubblici di cui alle rituali procedure di gara. Quindi ad essi non si applica il MTR ma, come visto (al minimo) gli obblighi di trasparenza e di accesso agli impianti; impianti «intermedi».
Si tratta di una prossemica al SPL che diventa una sorta di aggiuntivo criterio nell’organizzazione della gestione integrata del SPL. Viene poi sottolineato nel MTR il tentativo di trasporre il principio di prossimità con meccanismi di regolazione incentivante delle gestioni, a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe, trasferendo gli incrementi ai flussi provenienti dalle aree non di prossimità.
Così viene confermato che il principio di prossimità non può considerarsi un automatismo, dovendosi calare nello specifico contesto, coordinandolo con la impiantistica e guardando anche alle cosiddette «esternalità». Anche sotto questo profilo l’Autorità competente deve essere messa nelle condizioni di conoscere la provenienza (se non l’origine) dei flussi trattati, così da dimensionare e stimare gli impatti ambientali nelle loro matrici, ovvero valutare il rispetto del più volte citato principio di prossimità di cui all’art. 16 della direttiva 2008/98/CE, con ciò senza necessariamente intendersi violato il principio della libera circolazione delle cose (art. 120 Cost.).
Va altresì evidenziato che la legge nazionale può delegare all’ARERA di implementare il dettato normativo con opzioni regolatorie che devono restare raffrontabili alla luce di indici, parametri e standard elaborati dalla comunità scientifica di riferimento. Occorre però precisare che le funzioni che comportino scelte distributive o volte alla realizzazione di valori extra mercantili richiedono un mandato espresso del legislatore (è il c.d. «circuito politico rappresentativo» di cui all’art. 95 Cost.) e quindi «il deficit di legalità sostanziale non può essere “compensato” da una declinazione ‘procedurale’ del principio di legalità (...), e neppure aggirato con la teoria dei c.d. poteri impliciti»42.
Peraltro gli interventi dell’ANAC, dell’AGCM, oltre alla numerosa giurisprudenza formatasi sulle casistiche di queste materie consentono di meglio interpretare la complessiva disciplina. Ad es. le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II n. 2255 del 7 marzo 2024 e n. 10550 del 6 dicembre 2023 sono utili per meglio comprendere sia il sistema delle fonti (in particolare europee) che la «nuova assiologia compositiva» (cfr. la l. 11 febbraio 2022, n. 1) come trasversalmente voluta tra lo sviluppo economico e la tutela ambientale recata coi “nuovi” articoli: l’art. 9 Cost. e gli artt. 41-42 Cost.
La appena menzionata sent. Cons. Stato, n. 2255 del 2024 si sofferma sulle attività gestionali dei RU (di «pubblico interesse» exart. 177, comma 2 del TUA) le cui attività si svolgono in regime di monopolio, cioè in regime di «privativa» («monopolio legale») applicata ai RU in tutte le loro fasi gestionali, salvo che per il loro «avvio» al recupero (peraltro, consentito solamente alle utenze non domestiche: cfr. l’art. 238, comma 10 del TUA e altre disposizioni ad essa riconducibili). Di qui, ancora, il richiamo ai princìpi “di autosufficienza” e “di prossimità” nel SGIRU – in un sistema di governance che è anche multilivello – partendo dalla suddivisione del servizio medesimo in orizzontale e verticale43.
Al di là delle generiche formulazioni finalistiche, tornando alla tassonomia impiantistica dell’ARERA, per gli «impianti minimi» la misura regolatoria areriana sarebbe stata assunta per fronteggiare manifestazioni di potere economico dei titolari di impianti privati, anche se – per la cit. pronuncia del Consiglio di Stato – il mandato legislativo di ARERA sarebbe andato oltre la determinazione autoritativa del prezzo sulla base dei costi efficienti di cui all’art. 1, comma 527 della cit. legge n. 205 del 201744.
Come detto, l’ARERA nella sua attività regolatoria cerca di poter uniformare le tariffe dei diversi impianti, innestando anche le «esternalità» dosate ricorrendo al citato criterio della prossemica e incentivando il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento. In tal modo l’attività regolatoria interviene anche sulle infrastrutture, stimolando investimenti all’impiantistica che riceverà più facilmente finanziamenti attraverso il meccanismo del MTR. Difatti il MTR si raccorda con le opzioni anche pianificatorie dell’impiantistica c.d. “di chiusura” per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, in una modulazione degli strumenti di regolazione che distingue come sopra (cioè nella tassonomia) gli impianti, assumendo come criterio della GISRU anche la prossemica al SPL. Un SPL che è stato p.c.d. ridefinito dai “nuovi” RU (in una definizione dei RU più estensiva rispetto a quella precedente al d.lgs. n. 116/2020) sussumendo ope legis , i rifiuti che un tempo venivano dichiarati assimilati e quindi dimensionando con questi “nuovi” RU una diversa perimetrazione del SPL dei RU (residuandosi dei margini di scelte in capo ai titolari dei servizi) e, conseguentemente, della latitudine del “regime di privativa” (che, com’è noto, riguarda essenzialmente i RU) comportando effetti di non poco conto anche nell’ambito della fiscalità locale (ad es. per i cosiddetti “ bonus sociali”) che esulano dalla mera gestione dei RU.
Surrettiziamente il MTR traspone il «principio di prossimità», con meccanismi di regolazione incentivanti le gestioni, a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe, trasferendo gli incrementi dei costi quale automatismi (pur nella ammissibilità e graduazione dei costi riconoscibili dall’ARERA) o come il frutto di semplici incastri con i princìpi di «autosufficienza» e di «specializzazione» (oltre a quelli reinterpretati, per le spedizioni transfrontaliere) dei rifiuti.
Il «principio di prossimità» va comunque contestualizzato, calandolo nelle specificità e coordinandolo con la impiantistica esistente e potenziale, non senza trascurare le cosiddette «esternalità» negative, derivanti ad esempio, dalla movimentazione dei rifiuti, dagli impatti ambientali, ecc.
In pratica, il mercato dei rifiuti, anche urbani, può essere connesso (rectius, embricato) con altri settori (non pubblici, neppure regolabili) fuori dalla semplice pianificazione degli impianti di trattamento dei RU, essendo la loro gestione “comunicante” con il settore non solo dei RS, ma anche ad esso “esterno”, quantomeno per tecnologia e/o processistica e/o per interessi “comuni”, citasi, esemplificativamente, gli impianti che potrebbero trattare questi flussi di RU nelle acciaierie, nei cementifici, eccetera.
Così, questo sistema complesso (ambiente, società, economia, istituzioni) conferma che spetta al decisore politico di «stabilire i confini tra attività riservate al settore pubblico, attività regolate e attività lasciate alla concorrenza nel mercato, così come orientare il mercato verso assetti più giusti, limitando la spinta alla massimizzazione del profitto» (cfr. punto 5.1 cit. sentenza Cons. Stato n. 2255/2024).
8. -Prime combinazioni tra i princìpi di autosufficienza, prossimità e specializzazione. Attuazione autorizzativa.Come visto il principio dell’autosufficienza e il principio della prossimità della gestione dei RU si riferiscono all’ATO sicuramente per lo smaltimento, mentre per il recupero si dovrà guardare ai soli RU indifferenziati, non valendo per i RS l’autosufficienza bacinale, mentre la specializzazione impiantistica va coordinata alla prossimità.
Rimane però la riduzione preliminare, il più possibile, delle movimentazioni dei rifiuti che causano impatti ambientali (polvere, rumore, inquinamento, consumo di risorse, etc.), ragion per cui la prima opzione da adottare è quella di trattare i rifiuti nel luogo più vicino della loro produzione. Tanto vale anche per i RS45.
Ecco perché in sede di valutazione delle istanze autorizzative-progettuali occorre che l’Autorità competente, nei suoi vari e diversi organi, svolga precise ed obiettive analisi di fatto.
Peraltro, va tenuto presente che nella “misurazione” dei nuovi obiettivi di recupero/riciclaggio, la strategia e la programmazione dei RU-RS cambiano.
Come visto, l’autosufficienza bacinale riguarda i RU distinguendosi dalla prossimità, ma non si tratta di concetti antinomici, potendosi integrare e bilanciare le diverse situazioni, relazionando tra di loro i vari princìpi. Ecco che l’autosufficienza, la prossimità e la specializzazione non sono da considerarsi concetti da incasellarsi in modo automatico e meccanico e neppure escludentesi. La libera circolazione dei RS avviati a recupero deve guardare al «presupposto composito» di RU-RS e di smaltimento-recupero.
In tal modo non si deprime l’iniziativa imprenditoriale operante nel settore di mercato c.d. libero, né con scelte dirigistiche autoritative, bensì si opererà un bilanciamento tra le diverse scelte che sono anche assiologiche, e che ogni Autorità competente, nell’ambito della propria pianificazione (coordinata con quella superiore) riterrà di adottare con riferimento ai valori-interessi dell’ambiente, del paesaggio, ecc.
Tanto trova conforto nella modifica costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost. realizzatasi l’8 febbraio 2022, ponendo la nuova definizione di ambiente entro i princìpi fondamentali, talché si realizzano diversi equilibri, anche nella struttura gerarchica delle fonti, per i princìpi comunitari della «prevenzione», «precauzione», del «chi inquina paga», dello «sviluppo sostenibile», della «autosufficienza», «prossimità» e «specializzazione», ecc.46. Se i «princìpi supremi» dell’ordinamento costituzionale, sono concepiti come non cedevoli, si afferma che essi (tra i quali la materia dei «diritti fondamentali») potrebbero venire meno per «ragioni di interesse pubblico superiori, gerarchicamente sovra-ordinate», giustificandone, in casi eccezionali, il sacrificio.
Sull’art. 41 Cost. e il suo bilanciamento con la tutela ambientale, sintomatico è quello che ragionevolmente deve avvenire tra gli artt. 2, 4, 32, comma 1, art. 35, comma 1 e 41 della Cost. che ora dovrà rapportarsi con la collocazione dell’ambiente entro i diritti fondamentali. È stata la famosa «sentenza ILVA» (Corte cost. sent. n. 85 del 2013) a meglio intervenire sul rapporto tra i diversi valori-interessi che è di integrazione reciproca, non della prevalenza assoluta di un interesse sugli altri47, cioè senza il «tiranneggiamento» di un solo diritto sugli altri (sentenze n. 264/2012; n. 85/2013 e n. 63/2016).
Non si tratta, per la prefata sentenza, di un ordine gerarchico assoluto, bensì del bilanciamento continuo tra diritti fondamentali e punti di equilibrio, valutati dal legislatore e dal giudice «secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale» che trova un punto di equilibrio anche nell’auspicabile bilanciamento tra i diritti sociali, nell’apprezzamento del caso concreto.
Nell’attività amministrativa-autorizzativa, anche per quanto riguarda i RS, si dovrà valutare l’applicabilità del principio di prossimità per i flussi provenienti da fuori Regione, eventualmente limitandone l’accesso ove siano rifiuti comunque provenienti dal trattamento di RU in altre Regioni.
Mentre, in via generale il trattamento di flussi di rifiuti con codici EER già rientranti nella analisi dei flussi in entrata e in uscita, come analizzati e valutati nel PRGRU, potranno essere o non considerati ai fini dell’autosufficienza, laddove la autorizzazione riferita ai singoli impianti (o istanze) comporti criticità contrastanti con il principio di prossimità, ovvero effetti nella sostenibilità sia economica che ambientale dell’iniziativa, anche con riferimento agli impianti già esistenti ed operanti nella Regione o Provincia autonoma.
La movimentazione dei rifiuti ovvero l’impatto ambientale del trasporto dei rifiuti, nei suoi plurimi effetti derivanti dalla maggior percorrenza di mezzi, quali il maggior contributo della congestione delle arterie stradali con un peggioramento della mobilità, un maggior numero di emissioni di inquinanti in atmosfera, in particolar modo, Nox, CO, CO2 e particolato, oltre che di emissioni acustiche 48 può essere ridotto anche richiamandosi al principio di prossimità degli impianti.
Ne viene che in sede autorizzativa (nuove autorizzazioni, modifiche e varianti di impianti di Piano esistenti) relativa agli impianti di RU residui (RUR) sarà richiesto – e valutate in sede istruttoria – agli istanti di fornire informazioni e dimostrazioni relative: alla conformità ai princìpi e alle gerarchie sopra riportate; alle stime dei flussi delle tipologie dei rifiuti previsti e dell’eventuale provenienza, dimostrando il rispetto delle suddette gerarchie; all’effettiva necessità rispetto ai fabbisogni territoriali analizzando la capacità di trattamento degli altri impianti di Piano regionale49.
Per quanto riguarda i RS, sempre in sede autorizzativa, vanno dimostrati i vantaggi ambientali, economici, impiantistici del loro trattamento negli impianti di Piano in luogo di altri impianti dedicati ai RS nel rispetto della gerarchia europea e del principio di prossimità.
Le informazioni di cui trattasi saranno considerate ad integrazione delle valutazioni legate alla tutela della salute della popolazione e dell’ambiente nell’ambito del procedimento di VIA o del procedimento autorizzativo nel caso in cui la VIA non sia prevista o sia già conclusa. Tali considerazioni potranno essere rilevanti ai fini di giudizi di compatibilità ambientale negativi, dinieghi, riduzioni di potenzialità o stralcio di codici EER, ponendo particolare attenzione ai sub flussi degli impianti di trattamento dei RU.
1 Magistrale è il testo di A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti , Firenze, 1997, anche nello sfondo della preziosa lettura socio-economica di G. Sapelli, Comunità e mercato , Soveria Mannelli, 1996: Id., Merci e persone. L’agire morale nell’economia , Soveria Mannelli, 2002; Id., Oltre il capitalismo. Macchine, lavoro, proprietà , Milano, 2018 ed altri ancora.
2 Anche sostituendo le diseconomie esterne con altre connessioni (accostate agli input e output), nella versatilità del concetto di connessione anche per scopi storico-interpretativi, che conducono alle complementarietà e alle causazioni cumulative di eventuali cammini di crescita economica, inusuali e diversi, pensando alle sequenze che nelle analisi economiche appaiono orientate alla rovescia, nella dinamica sempre delle connessioni a monte e a valle n proposito si veda L. Meldolesi, Alla scoperta del possibile. Il mondo sorprendente di Albert O. Hirschman , Bologna, 1994, 122-133.
3 Ovvero nei casi di fallimenti dei mercati, cioè di assenza dell’interesse commerciale di una impresa a fornire certi servizi in segmenti non concorrenziali del mercato.
4 L’ARERA ha competenze in materia, in base alle leggi 14 novembre 1995, n. 481 e 27 dicembre 2017, n. 205, oltre che ad altre disposizioni finanziarie, come pure nel settore dei rifiuti. Si vedano anche i “limiti” dell’ARERA come indicati nella sentenza Consiglio di Stato, Sez. II 7 marzo 2024, n. 2255.
5 disposizioni sulla qualità del servizio (denominato «testo unico sulla qualità contrattuale» o TQRIF) assunte con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 2023.
6 Cfr. F. Merusi - M. Passaro,Le autorità indipendenti,Bologna, 2011, 43 ss.
7 F. Merusi, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011, 13.
8 Che «caratterizza gli indici di pubblicità sostanziale» così F. Merusi, Sentieri interrotti della legalità, Bologna, 2007, 87; dalla quale si ricavano «regole e non valori assoluti» secondo F. Merusi, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa , op. cit., 12; che sarebbe «fonte formale del diritto: vera fonte di produzione secondo Asquini sulla scia del Vivante, ma anche come fonte di conoscenza e non di produzione, sussidio per l’interpretazione del caso concreto, come criterio», così L. Benvenuti, Il “gran realismo” di Fabio Merusi e i sentieri interrotti della legalità ,in L. Benvenuti - M. Clarich (a cura di), Il diritto amministrativo alle soglie del nuovo secolo, Pisa, 2010, 20 e 25; la natura delle cose per i servizi pubblici nella lettura dell’art. 43 Cost nel Novissimo Digesto del 1970 è una clausola generale che si riferisce a un fenomeno i cui indici di esistenza saranno individuati dal legislatore e infine riesaminati, sotto il profilo della ragionevolezza, dal giudice costituzionale. Qui Merusi è però vicino alla concezione soggettiva del servizio pubblico ed è necessaria una forte imputazione dell’attività a un soggetto pubblico, ed è altresì necessario che ci siano erogazioni di prestazioni amministrative, mentre per i sostenitori della concezione c.d. oggettiva del servizio pubblico basta che una certa attività economica svolta dai servizi pubblici sia soggetta a controlli penetranti, non necessariamente a programmi. Ci sono dei limiti nel privatizzare perché i servizi pubblici non sono sconfinati, ciò in nome della realtà, della natura delle cose (vena di liberalismo con aperture a valori di socializzazione) vedasi M. D’Alberti, Il nuovo diritto pubblico dell’economia nell’opera di Fabio Merusi , in L. Benvenuti - M. Clarich (a cura di), op. cit., 38-39 la «natura delle cose» è un atteggiamento realistico che «recepisce la tradizione del diritto romano. Infatti, dall’analisi della cosa in sé, dalla realtà dei rapporti umani e dalla consapevolezza sociale, come ricordava Asquini, il pretore romano ricavava la misura del diritto e costruiva quel diritto che ancora oggi è così tanto apprezzato e che in fondo non è così lontano nella sua impostazione dal nostro diritto amministrativo». È insomma una verità più profonda, la fonte originaria per Merusi è quella del principio di legalità. «Già all’epoca del diritto romano, le cose e i fatti, cioè i rapporti nella loro naturalità hanno al loro interno un proprio ordine condizionante che va esplicitato e che funge da criterio-guida sia per legislatore che per interprete. Alla lunga sono i fatti che prevalgono sulle norme dove esse non si adattino e non siano aderenti alla natura della cosa. L’interprete non può esimersi, per bene interpretare le norme, da un esame accurato e da una valutazione del modo di essere dei rapporti sostanziali». Negli scritti di Merusi si ritrovano vari esempi in cui la natura delle cose e la sostanza dei rapporti e degli interessi fanno valere le proprie ragioni al di là delle qualificazioni normative formali, insomma «la natura delle cose diventa parametro prescrittivo per il legislatore» e per le Autorità Amministrative indipendenti, insomma è «un atteggiamento realistico che recepisce la tradizione del diritto romano. Infatti, dall’analisi della cosa in sé, dalla realtà dei rapporti umani e dalla consapevolezza sociale, come ricordava Asquini, il pretore romano ricavava la misura del diritto e costruiva quel diritto che ancora oggi è così tanto apprezzato e che in fondo non è così lontano nella sua impostazione dal nostro diritto amministrativo», in proposito M. Clarich, I princìpi dell’azione amministrativa nell’integrazione tra ordinamento nazionale e comunitario , in L. Benvenuti - M. Clarich (a cura di), op. cit., 49-50; nel fenomeno della regolazione il potere amministrativo viene posto di fronte alla necessaria “correzione” di “irregolarità” nel funzionamento del mercato economico in cui atti amministrativi sono divenuti fonte di diritto obiettivo. Le correzioni per loro natura spesso non predeterminabili, bensì ricavabili dalla «natura delle cose» da regolare perché il mercato sia concorrenziale. Ora si sta cercando di ovviare alla libertà normativa legittimando la libertà nella produzione di norme con il consenso dei destinatari emergente da procedimenti partecipati, il che è sintomatico nelle AAAAII, cosìF. Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti , Bologna, 2012, 66
9 Cfr. A. Pierobon, Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti: dall’albero altissimo quale frutto? ,in Azienditalia, 11, 2022; Id.,Rifiuti EER 191212: dall’origine ai destini: il caso delle spedizioni transfrontaliere, ivi, 5, 2021; Id., Approcci e soluzioni non tanto giuridiche e non solo tecniche: flussi di rifiuti con lo stesso codice, tra servizi pubblici locali e non , ivi, 2020; G. Angelucci - A. Pierobon, Rifiuti ed emergenza sanitaria: gestione finanziaria e riflessi sulla tariffazione (Rifiuti nel periodo coronavirus flussi degli urbani indifferenziati, dei sanitari, degli speciali, tutte le problematiche e le soluzioni , Milano, 2020.
10 G. Morbidelli, Introduzione a un dibattito sui princìpi nel nuovo codice dei contratti pubblici , in G. Morbidelli (a cura di), I princìpi nel nuovo codice dei contratti pubblici , Firenze, 2023.
11 Con riferimento ad altro ambito, ma in una riflessione d’apice qui richiamabile, si veda A. Fabris, La filosofia all’epoca dell’intelligenza artificiale. Come ci aiuta a vivere negli ambienti tecnologici , Roma, 2025, 121-134.
12 La Corte di giustizia sia in materia di offerte economicamente più vantaggiose, sia in materia di offerte anomale, sia in materia di affidamenti in house ha assunto posizioni favorevoli ad un equilibrato riconoscimento della discrezionalità amministrativa ed a forme semplificate di affidamento dei contratti, si veda F. Cintioli, Il principio del risultato nel nuovo codice dei contratti pubblici , in G. Morbidelli (a cura di), I princìpi nel nuovo codice dei contratti pubblici , op. cit., 35
13 C.M. Oriolo, L’attuazione dei princìpi e le esigenze della stazione appaltante , in G. Morbidelli (a cura di), I princìpi,op. cit., 100.
14 Che avrebbero dovuto costituire il limite tra la legislazione statale e quella regionale.
15 Che sono stati più indicati che esplicitati, sono «princìpi fissati dalla legge».
16 Sulla tematica V. Italia, La legislazione di princìpi, Milano, 2017.
17 Ibidem . Sulla composizione tra norme speciali, settoriali, ecc. si veda quanto emerge nella casistica esaminata in A. Pierobon, Rifiuti autostradali tra disciplina ambientale, stradale e tributaria , in Azienditalia, 3, 2022; Id., La disciplina sulla circolazione stradale e quella sui rifiuti: prime tessiture , in La Polizia Locale, 3, 2022; Id., I rifiuti c.d. “autostradali” tra diverse discipline e gestioni , in L’Ufficio Tecnico, 4, 2022.
18 Così, diffusamente, nel volume di V. Italia, Le probabilità nelle leggi , Milano, 2021.
19 Ad es. la dottrina cita la Corte di giustizia 5 maggio 1998, in causa C-180/96; Tribunale I grado 16 luglio 1998, in causa T-199/96.
20 P. Dell’Anno, Princìpi del diritto ambientale europeo e nazionale , Milano, 2004, 92-92 e 124 sulle quali l’A. ha trovato un criterio interpretativo (39 ss.) richiamandosi a E. Guicciardi.
21 G. Di Plinio, Sei miliardi di ragioni, in (a cura di) G. Di Plinio - P. Fimiani, Princìpi di diritto ambientale , Milano, 2002, 27.
22 P. Dell’Anno, Princìpi,op. cit., 148 ss.
23 Vedasi anche la causa Commissione europea contro Repubblica italiana decisa dalla Corte di giustizia con sentenza 4 marzo 2010, in causa C-297/08, che richiama altre sentenze della medesima Corte.
24 L’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di riferimento associa gli enti locali, ai fini dell’esercizio unitario della gestione dei rifiuti urbani in forma di Autorità di ATO o EGATO, pertanto i soggetti titolari, ossia i Comuni, fino alla costituzione ed entrata in funzione dell’EGATO, rimangono i soggetti responsabili delle competenze attribuite in materia di rifiuti, in particolare, oltre alla determinazione dei proventi tariffari, della corretta chiusura del ciclo di gestione di tali rifiuti all’interno del territorio di competenza, rispettandosi la pianificazione regionale ex art. 199 del TUA.
25 Cfr. quanto fa emergere la sentenza del T.R.G.A. Bolzano n. 166/2019 decisa il 22 maggio 2019.
26 Cioè dei «nuovi produttori» [cfr. art. 183, comma 1, lett. f) TUA] come avviene nel caso degli impianti intermedi di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) che trattano rifiuti urbani e pure rifiuti speciali in entrata, producendo dei rifiuti classificati dai gestori come rifiuti speciali, codificati EER 191212.
27 Sulle metodologie di queste scienze, in rapporto alla conoscenza e finanche all’esistenza sia permesso rinviare all’imminente pubblicazione (dal titolo provvisorio) La mediocrità della cornice , in AmbienteDiritto.it.
28 Confermando: in primo luogo, il carattere normativo dell’elenco rifiuti che è vincolante per la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi: art. 7, par. 1 reg. cit. e decisione 2000/532/CE; in secondo luogo, che i rifiuti trattati meccanicamente non perdono la propria natura di rifiuti urbani indifferenziati, rimanendo soggetti alle disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, col regime delle obiezioni di cui all’art. 11 reg. cit. consentendo alle autorità competenti di basarsi sui «provvedimenti presi» dagli Stati membri per attuare i princìpi, tra l’altro, di autosufficienza e prossimità.
29 La proposta della Commissione alla Corte era la seguente: «L’art. 3, par. 5 e l’art. 11 del regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in G.U.U.E. L 190 del 12 luglio 2006, 1 non si oppongono ad un rifiuto di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti urbani non differenziati, nella misura in cui tali rifiuti anche se trattati meccanicamente non perdano la propria natura di rifiuti urbani non differenziati, e ciò indipendentemente dal codice CER ad essi attribuito, il quale non è suscettibile di ostare a detta conclusione».
30 Sul divieto di conferimento in discarica di rifiuti: princìpi e regole (tra iniziative della P.G.) , in www.osservatorioagromafie.it, 2024.
31 Cfr. Invitalia, Monitor SPL-Assetti organizzativi e gestionali del servizio rifiuti urbani. Report nazionale , maggio 2019, 9.
32 L’AGCM rileva «una tendenza alla verticalizzazione (che favorisce N.d.R.) l’integrazione delle imprese (spesso pubbliche) che operano nella raccolta nelle fasi a valle della filiera». Cfr. AGCM, n. IC49/2016, par. 497.
33 La REP si trova (tra altro) nell’art. 178 bis del TUA nei requisiti minimi di cui all’art. 178 ter, fermo restando la responsabilità della gestione dei rifiuti dell’art. 188 [per la definizione di «gestione dei rifiuti» si veda l’art. 183, comma 1, lett. n )] e i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti dell’art. 179, e, prima ancora, nel campo di applicazione e nelle finalità di cui all’art. 177 del TUA. L’art. 183, comma 1, lett. g bis), definisce (altresì richiamando obiettivi, responsabilità, costi e adempimenti) il regime di REP come «le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto».
34 Già l’art. 1, legge n. 241 del 1990 ha inserito tra i princìpi generali dell’azione amministrativa «i princìpi dell’ordinamento comunitario», tra i quali rientrano quelli ambientali, quale quello di precauzione, applicabile anche in altri ambiti, principio peraltro «che può desumersi dal principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, comma 2, Cost.), nonché da quelli di adeguatezza, di ragionevolezza e di proporzionalità» così M. Santise, Principio di precauzione e tecniche di gestione del rischio , in G.A. Chiesi - M. Santise (a cura di), Diritto e Covid-19 , Torino, 2020, 412-413 (anche in nota 8 citando A. Police).
35 Art. 1 TUE.
36 Art. 3, par. 3 del TUE; art. 11 del TFUE; art. 37 del CDFUE.
37 Le motivazioni adducibili potrebbero riguardare, esemplificativamente: la disomogeneità delle strutture produttive delle diverse fasi del servizio; la stretta inerenza della produzione i rifiuti con il tessuto economico-imprenditoriale; l’importanza, ai fini del conseguimento degli obiettivi, delle condotte dei singoli e, soprattutto, dell’attitudine del mercato ad accogliere gli scarti recuperati come materie prime seconde; ecc.
38 In tal senso è sintomatico il comma 10, dell’art. 238 del TUA.
39 Così F. Cintoli, Per qualche gara in più. Il labirinto degli appalti pubblici e la ripresa economica , Soveria Mannelli, 2020, 49; 52 ss.; 89.
40 Documento n. 196/2021/R/rif dell’11 maggio 2021, recante «Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio» (MTR-2: periodo 2022-2025), box 3, nota 14 di p. 19.
41 Obliquamente l’ARERA adegua alle suddette pronunce amministrative anche la propria delibera sul «Testo Unico della Qualità del servizio dei rifiuti urbani» («TQRIF») del 18 gennaio 2022, n. 15, ove si interviene sui costi ammessi al riconoscimento, cioè sui costi operativi di gestione CTR e CTS, sui conguagli dei costi variabili, sulle matrici delle operazioni regolatorie, sulle tariffe di accesso per gli impianti minimi, aggiuntivi (di chiusura) e intermedi.
42 In proposito si rinvia alla sentenza Consiglio di Stato 7 marzo 2024, n. 2255 (punti 4.5-4.6) che, tra altro, sconfessa la teoria dei c.d. «poteri impliciti».
43 Si veda G.M. Caruso - A. Pierobon, L’organizzazione del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani, in Azienditalia, 11, 2024.
44 Pertanto le valutazioni di ARERA quantomeno interferiscono con le funzioni programmatorie riservate allo Stato con riguardo al fabbisogno impiantistico [art. 195, comma 1, lett. f) e art. 198 bis del TUA] oltre ad aver invaso le competenze statali anche per quanto riguarda la pianificazione regionale (art. 195 del TUA).
45 Com’è noto, nella classificazione dell’art. 184 TUA viene ribadito il criterio dell’origine dei RU e RS (oltre alle caratteristiche di pericolosità). Al comma 2 dell’art. 184 si ha l’ontologia dei RU di cui alla definizione di cui all’art. 183, comma 1, lett. b ter), mentre i RS sono elencati al comma 3. Permane però l’ambiguità per alcune categorie di rifiuti che possono collocarsi tra RU/RS, ed è una ambiguità che non si risolve ricorrendo solo al dato giuridico, bensì nell’effettività col criterio del caso per caso.
46 Sia concesso rinviare alla ricostruzione A. Pierobon, Le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione: tra nobiltà dei fini e pateracchi , in Comuni d’Italia, 3, 2022.
47 In proposito vedasi la sent. Corte cost. n. 182/2017 sulla legittimità dei decreti legge nel bilanciamento ragionevole ed equilibrato dei beni e diritti costituzionali: l’iniziativa economica e il lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) in un ambiente sicuro e non pericoloso, e quindi la salute (artt. 2 e 32 Cost.).
48 In proposito trovo che una delle Regioni che ha tenuto ben presente questi aspetti sia stata la Regione Lombardia, si veda il suo «Secondo Rapporto di Monitoraggio Integrato PRGR/PRB-VAS, biennio 2017-2018», p. 98.
49 Una strategia di judo rispetto a quella di uno scontro boxistico avevo tentato nel PRGRU siciliano, in proposito rinvio agli articoli pubblicati nel tempo, e al volume Governo e gestione dei rifiuti urbani: approcci, metodi, percorsi e soluzioni , Milano, 2022 e bibliografia ivi citata, nonché all’imminente La mediocrità della cornice, cit.



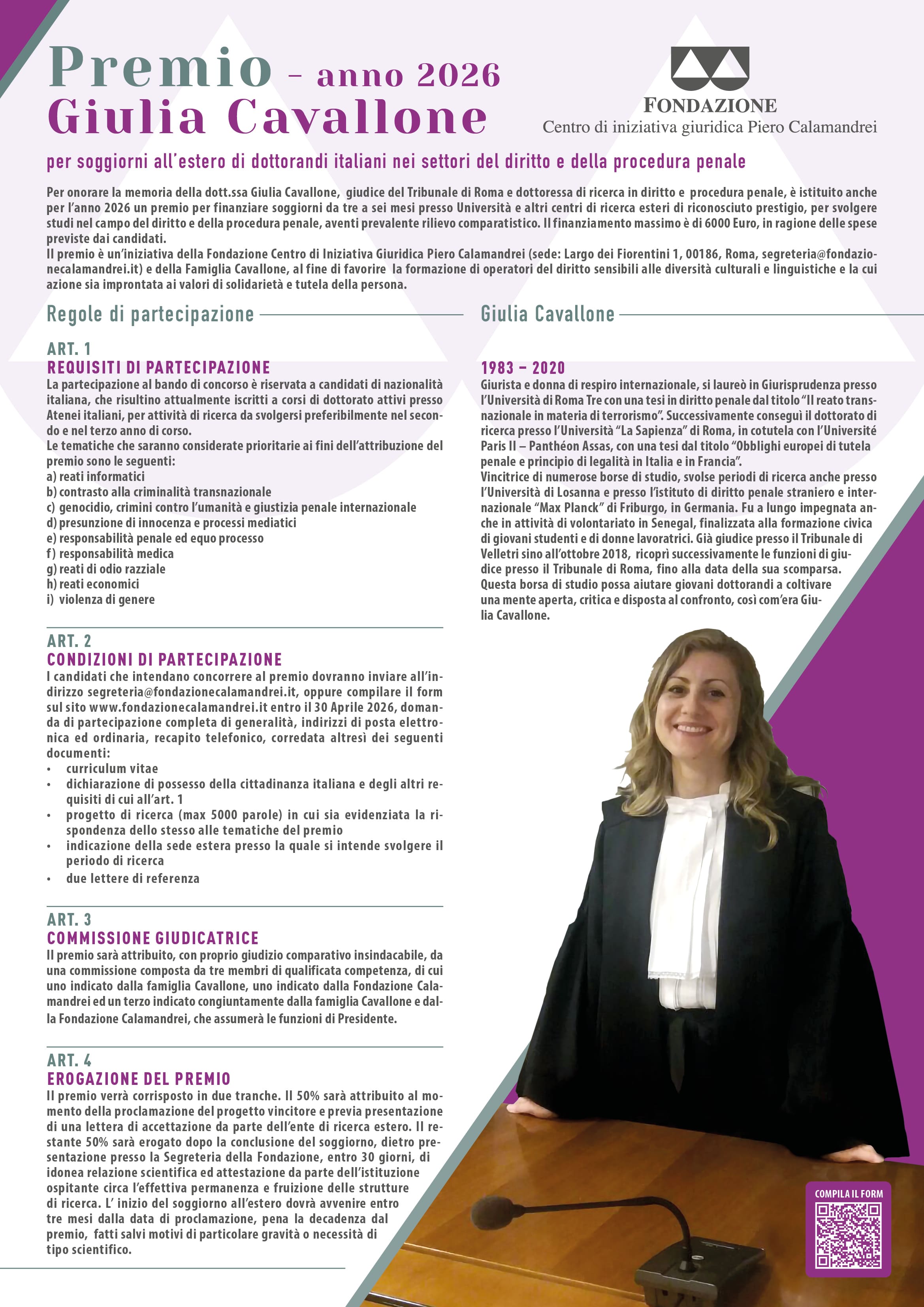 Scarica la locandina
Scarica la locandina

