 Consiglio di Stato Sez. VII n. 8712 del 10 novembre 2025
Consiglio di Stato Sez. VII n. 8712 del 10 novembre 2025
Beni ambientali.Articolo 167 dlv 42\2004
La sanzione di cui all'art. 167 dlv 42\2004 non è una forma di risarcimento del danno, ma una sanzione amministrativa applicabile a prescindere dalla concreta produzione di un danno ambientale. Nella previsione normativa, il danno viene in considerazione solo come criterio di commisurazione della sanzione - in alternativa al profitto conseguito - e non come parametro che ne condiziona l'an. L'assenza di un danno ambientale non ostacola, dunque, il potere sanzionatorio, ma assume rilievo sotto il profilo della quantificazione dell'importo dovuto, che sarà ragguagliata al solo profitto conseguito. Si tratta di una sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo antee proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatorio alternativa alla demolizione essa viene ragguagliata al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione e, in base all'art. 167 del d.lgs. 42 del 2004, le somme sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.
Pubblicato il 10/11/2025
N. 08712/2025REG.PROV.COLL.
N. 09767/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9767 del 2024, proposto da
Comune di Ronciglione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Angelo Annibali, Andrea Ruffini e Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Mibact-Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, Prov di Viterbo e L'Etruria, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9457/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e udito per le parti l’avvocato Giuliana Malara;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante Comune di Ronciglione esponeva che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21 aprile 20017 aveva approvato il progetto esecutivo denominato “Lavori di recupero e valorizzazione del viale Giuseppe Garibaldi” nell’ambito di un programma comunale di riqualificazione del centro storico. Nello specifico, i lavori hanno interessato la pavimentazione del marciapiede nel tratto viario ricompreso tra il civico 28 e il 112 della strada principale che attraversa il centro del paese, appunto viale Giuseppe Garibaldi.
Svoltesi le operazioni di gara, l’appalto dei lavori è stato affidato con contratto sottoscritto in data 24 aprile 2018. Sennonché, appena avviati i lavori, a seguito di un sopralluogo eseguito il successivo 17 maggio, il personale tecnico della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali aveva rilevato che l’intervento pubblico in corso di esecuzione era stato avviato in assenza degli atti autorizzativi di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42 del 2004 in quanto, trattandosi di un tratto viario ricompreso nel centro storico comunale, l’area interessata dall’intervento risultava gravata da vincolo paesaggistico. Per tale motivo, con nota prot. n. 9671 del 31 maggio 2018, il MIBACT aveva invitato l’Amministrazione comunale a dare seguito a quanto disposto dal D.L.gs 42/2004 e, in particolare, “a sospendere immediatamente i lavori, a procedere alla rimessa in pristino dei luoghi, ripiantumando i vegetali rimossi e a iniziare i lavori solo a seguito della nota autorizzativa e nel rispetto delle eventuali prescrizioni espresse”. A fronte di ciò, con Ordinanza n. 107 dell’11 giugno 2018 il Comune di Ronciglione ha immediatamente disposto la sospensione dei lavori, disponendo la rimessa in pristino dei luoghi, da concludersi nei successivi 90 giorni.
Contestualmente l’Amministrazione comunale ha provveduto a conferire incarico per la redazione degli elaborati progettuali finalizzati ad ottenere: a) l’autorizzazione postuma ai sensi dell’art. 160 e 167 D.L.gs. 42 del 2004 relativamente ai lavori già eseguiti; b) le autorizzazioni mancanti ai sensi degli art. 20, 21 e 146 del D.L.gs. 42 del 2004 relativamente ai lavori ancora da realizzare.
Il Comune ha quindi presentato alla Regione l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica - ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del D.lgs. 42 del 2004 - delle opere realizzate in assenza di autorizzazione consistenti nel ripristino dello stato dei luoghi di viale Garibaldi mediante: - rimozione di parte della pavimentazione ivi presente; - posa in opera di pavimentazione secondo gli elaborati grafici progettuali allegati all’istanza, al fine del ripristino dello stato dei luoghi; - piantumazione essenze arboree e arbustive precedentemente rimosse.
A seguito dell’istanza, la Regione Lazio ha ritenuto le opere in oggetto suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica in quanto riconducibili, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), D.lgs. 42/2004 nella tipologia di “lavori realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Pertanto, la Direzione regionale ha trasmesso gli atti alla Soprintendenza per ottenere il parere vincolante di cui all’art. 167, comma 4, D.lgs. cit. con nota prot. n. 671698 del 28 luglio 2020.
La Soprintendenza ha manifestato il proprio parere favorevole “nel merito della compatibilità paesaggistica della sola rimessa in pristino proposta così come rappresentato negli elaborati progettuali allegati ad eccezione delle lastre di copertura dei pozzetti in basaltina in luogo dei quali si chiede di realizzare una struttura che ricomponga il disegno della pavimentazione con cubetti di selce o l’adozione di un coperchio in ghisa”,
Con il provvedimento prot. n. 723518 del 19 agosto 2020 la Regione Lazio, prendendo atto del parere favorevole della Soprintendenza, esprimeva il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere di ripristino e, con il medesimo provvedimento comunicava al Comune di Ronciglione l’irrogazione - sulla base del comma 5 dell’art. 167 D.lgs. 42/2004 e dell’art. 6 del Protocollo di Intesa del 18 dicembre 2007 sottoscritto con il MIBACT - della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 20.000,00.
Con Determinazione n. 279/2020, il Comune procedeva al pagamento della sanzione dando atto di non prestare acquiescenza alcuna al provvedimento sanzionatorio, che impugnava nella parte in cui irrogava la sanzione pecuniaria.
Il TAR adito annullava il provvedimento prot. n 723518/20 del 19 agosto 2020, recante la sanzione pecuniaria nei confronti del Comune ricorrente osservando “le censure relative alla carenza di motivazione sono fondate: la Regione Lazio, infatti, avrebbe dovuto calcolare il valore delle eventuali opere non oggetto di rimessa in pristino e su quelle, se del caso, in base al richiamato Protocollo di intesa, parametrare il danno.” Tuttavia, il TAR non si pronunciava sul primo motivo di ricorso, ovvero se la sanzione amministrativa prevista dall’art. 167, comma 5, D.lgs. 42 del 2004 fosse irrogabile nei confronti di una pubblica amministrazione.
Pertanto, con ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. il Comune di Ronciglione ha nuovamente adito il TAR Lazio chiedendo “chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II quater, n. 9457/2024, e, nello specifico, chiarire se la Regione Lazio è legittimata a riattivare il procedimento amministrativo per l’irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 167, comma 5, D.lgs. 42/2004”.
A seguito di ciò il TAR Lazio, con l’ordinanza n. 20350/2024, ha chiarito che la sentenza da ottemperare aveva escluso la ricorrenza del profitto, ma non quella del danno, facendo implicitamente salvo il potere sanzionatorio della Regione Lazio nei confronti del Comune.
Il TAR ha, altresì, evidenziato che doveva semmai costituire motivo di impugnazione della pronuncia in esame il diverso profilo della dedotta incompatibilità strutturale tra la sanzione de qua e la natura di ente pubblico del soggetto destinatario della stessa.
A seguito di ciò e dei chiarimenti forniti in sede di ottemperanza, il Comune di Ronciglione ha impugnato la sentenza n. 9457/2024.
Resiste la Regione Lazio.
All’udienza del 30 settembre 2025 la causa passava in decisione
DIRITTO
1. Con il motivo di appello l’amministrazione appellante deduce error in procedendo. Omessa pronuncia del T.A.R. Lazio sul primo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, D.lgs. 42/2004 e dell’art. 2, comma 4, D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità e travisamento.
Lamenta che, sebbene con il ricorso introduttivo fosse stato chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Regione Lazio aveva irrogato la sanzione amministrativa a carico dell’Ente oggi appellante, contestando l’assoggettabilità di una pubblica amministrazione alla sanzione amministrativa ex art. 167, comma 5, D.lgs. 42/2004, il TAR Lazio non si era sul punto pronunciato.
Evidenzia che laddove i lavori oggetto di sanatoria non cagionino alcun danno, né determino alcun profitto al trasgressore, come nella specie, la sanzione amministrativa prescritta dall’art. 167 non può ritenersi irrogabile, per difetto dei necessari presupposti (danno e profitto per l’appunto).
Inoltre, evidenzia che il soggetto che aveva posto in essere l’intervento oggetto di sanatoria era un ente locale per il quale, in presenza di un’area pubblica che versava in evidente stato di dissesto, deve ritenersi sussistente un vero e proprio obbligo a provvedere al recupero della stessa.
La censura non è fondata.
1.1. Il TAR accogliendo la censura sulla carenza di motivazione dell’atto con cui è stata quantificata la sanzione ha implicitamente respinto il motivo della non assoggettabilità dell’ente locale alla sanzione amministrativa.
L'art. 167 cod. beni culturali n. 42 del 2004, sotto la rubrica “Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria”, al comma 1 prevede che, “in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4”.
In generale dunque, le opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica, in violazione dell'art. 146 cod. beni culturali (disposizione contenuta nel Titolo I della Parte terza del codice), non sono suscettibili di “sanatoria”, tramite il pagamento di una somma di denaro, ma comportano l'applicazione della sanzione di carattere reale della riduzione in pristino.
Le uniche deroghe alla sanzione ripristinatoria reale sono contemplate al comma 4 dello stesso art. 167, secondo cui l'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica dopo la realizzazione delle opere (onde tale accertamento viene comunemente definito “postumo”) nei seguenti casi tassativi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 t.u. edilizia.
In queste ipotesi, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area è ammesso a presentare domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi (comma 5, primo periodo).
L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni (comma 5, secondo periodo).
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione (comma 5, terzo periodo).
L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima (comma 5, quarto periodo).
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 (comma 5, quinto periodo).
A tale disciplina si raccorda l'art. 146 cod. beni culturali, alla cui stregua, “fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi” (comma 4, secondo periodo).
1.2. Il richiamato assetto normativo è il risultato della modifica introdotta dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), che ha integralmente sostituito l'art. 167 cod. beni culturali.
Il previgente comma 1 di tale ultima disposizione prevedeva, infatti, che “in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima”.
Il trattamento delle violazioni degli obblighi e degli ordini a tutela del paesaggio era dunque caratterizzato, prima della novella del 2006, dalla titolarità in capo all'amministrazione preposta alla tutela del potere di scegliere in ogni caso fra ripristino dello status quo ante e pagamento di una somma di denaro. Ciò, in linea con quanto precedentemente disposto, in termini sostanzialmente identici, prima dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), poi dall'art. 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).
La modifica del 2006 ha dunque significativamente innovato la disciplina, prevedendo che l'amministrazione non ha più la descritta possibilità di scegliere fra riduzione in pristino e misura pecuniaria.
1.3. Ciò premesso, a venire qui in rilievo sono, nel caso in cui sopravvenga l'accertamento “postumo” di compatibilità paesaggistica, i criteri di calcolo della somma dovuta dal trasgressore, che il legislatore statale ha individuato nel «maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione».
La rubrica dell'art. 167 cod. beni culturali parla di «indennità pecuniaria» in relazione all'importo che il trasgressore è tenuto a pagare, una volta accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi.
Il medesimo art. 167 è peraltro inserito nel Capo II del Titolo I della Parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, dedicato alle «Sanzioni relative alla Parte terza» dello stesso codice.
Inoltre, il comma 5 dell'art. 167 prevede che l’importo della «sanzione pecuniaria» sia determinato previa perizia di stima.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non si tratta di una forma di risarcimento del danno, ma di una sanzione amministrativa applicabile a prescindere dalla concreta produzione di un danno ambientale. Nella previsione normativa, il danno viene in considerazione solo come criterio di commisurazione della sanzione - in alternativa al profitto conseguito - e non come parametro che ne condiziona l'an. L'assenza di un danno ambientale non ostacola, dunque, il potere sanzionatorio, ma assume rilievo sotto il profilo della quantificazione dell'importo dovuto, che sarà ragguagliata al solo profitto conseguito (tra le molte, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 30 ottobre 2020, n. 6678, sentenza 25 luglio 2020, n. 4755, sentenza 4 maggio 2020, n. 2840; sezione sesta, sentenza 8 gennaio 2020, n. 130).
Il Consiglio di Stato ha qualificato la misura in esame come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante osservando che, “proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatori[o] alternativa alla demolizione” la sanzione viene ragguagliata “al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione” e, in base all'art. 167 del d.lgs. 42 del 2004, le somme “sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 30 giugno 2023, n. 6380 e n. 6381; nello stesso senso, tra le molte, Consiglio Stato, sezione prima, parere definitivo 18 maggio 2022, n. 877; sezione seconda, sentenza 30 ottobre 2020, n. 6678).
L'atto sanzionabile, dunque, è costituito dall'inosservanza delle norme che disciplinano uno dei fondamentali istituti di protezione ambientale, quale l'autorizzazione paesaggistica. La conseguente sanzione riparatoria, alternativa alla riduzione in pristino nei casi tassativi di abusi suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica, partecipa della medesima natura di ricomposizione della legalità violata propria della misura di carattere reale, a prescindere dall'effettiva produzione di un danno ambientale. In ragione di ciò, il danno si configura come un mero criterio di commisurazione della sanzione e non ne condiziona l'applicabilità.
L'art. 167 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 prevedendo la sanzione pecuniaria come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell'opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, ma con accertamento postumo, rimette la scelta tra le due all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Dunque, la sanzione è delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatorio alternativo alla demolizione viene ragguagliata "al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione" e, in base all'art. 167 del D.lgs. n. 42 del 2004, le somme "sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate".
Pertanto, come in generale per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, tali sanzioni pecuniarie non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione, di cui alla L. n. 24 novembre 1981, n. 689. Tali sanzioni, pur se di carattere pecuniario, partecipano della medesima natura di ricomposizione dell'ordine urbanistico della legalità violata e di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio. Il potere di irrogare le sanzioni cui all'art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004, è posto a presidio dell'interesse pubblico di rango costituzionale alla preservazione del paesaggio ed è esercitabile finché perdura l'illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata.
1.4. La Corte Costituzionale ha avuto modo di occuparsi dell’art. 167 D.lgs. n. 42 del 2004 vagliando la legittimità costituzionale dell’art. 83 della Legge Regionale della Lombardia n. 12 del 2005 (come introdotto dall’art. 27, comma 1, L.R. n. 17 del 2018) per violazione del riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni. La disposizione prevedeva che, in assenza di danno ambientale, la sanzione di cui all’art. 167 D.lgs. 42 del 2024 fosse “quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi”, introducendo un limite minimo non previsto a livello di legislazione statale.
Con la sentenza n. 19/2024 la Corte Costituzionale, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha osservato che: è chiaro, infatti, che la tutela dell’ambiente e del paesaggio prescinde dalla sussistenza di un danno ambientale. Essa si sostanzia nel predisporre strumenti di protezione di tali beni comuni, come i piani paesaggistici, o le autorizzazioni, o i divieti, strumenti questi tutti previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Nella prospettiva indicata, l’eventuale assenza di un danno ambientale non costituisce una ragione idonea a scindere il collegamento tra la sanzione e la disciplina di tutela paesaggistica. L’atto sanzionabile, come si è detto, è costituito dall’inosservanza delle norme che disciplinano uno dei fondamentali istituti di protezione ambientale, quale l’autorizzazione paesaggistica. La conseguente sanzione riparatoria, alternativa alla riduzione in pristino nei casi tassativi di abusi suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica, partecipa della medesima natura di ricomposizione della legalità violata propria della misura di carattere reale, a prescindere dall’effettiva produzione di un danno ambientale. In ragione di ciò, il danno si configura come un mero criterio di commisurazione della sanzione e non ne condiziona l’applicabilità.
Prosegue la Corte: In ogni caso, non è corretto affermare che, sempre al fine di elevare la tutela ambientale, l’intervento legislativo regionale abbia effettivamente colmato una lacuna dell’art. 167, comma 5, cod. beni culturali, completandone il dettato per l’ipotesi di assenza sia di danno ambientale sia di profitto. La norma statale, infatti, ben può essere interpretata nel senso che in tale ipotesi non sia irrogabile alcuna sanzione, non senza considerare che la sfera di efficacia della norma censurata è più ampia di quella prospettata dalla Regione, poiché introduce «comunque» la sanzione pari all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione, anche nel caso in cui un profitto esista, ma sia quantificabile in misura inferiore (Corte Cost. n.19/2024).
In senso diverso, il protocollo d’Intesa tra Regione e Ministero, che definisce le modalità per il calcolo della sanzione, prevede un importo minimo pari ad euro 2.000 applicabile anche nei casi in cui il danno arrecato o il profitto conseguito siano entrambi pari a zero. Tuttavia il protocollo non ha valenza normativa primaria, né può porsi in contrasto con il criterio di riparto delle competenze tra Stato e regioni, essendo a quest’ultime precluso ogni intervento in materia, come già accertato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 19 del 2024.
1.5. Non può ritenersi, invece, che possa essere esclusa, in generale l’assoggettabilità di una Pubblica amministrazione alla sanzione amministrativa ex art. 167, comma 5, D.lgs. 42 del 2004.
L’osservanza delle norme poste a presidio della tutela dell’ambiente non possono ritenersi indirizzate solo ai privati e devono essere certamente osservate dalle pubbliche amministrazioni che sono tenute a comportamenti non solo rispettosi della legge, ma anche virtuosi ed esemplari.
Né può affermarsi, come dedotto dall’appellante, che l’intervento oggetto di sanatoria era operato da un ente locale per il quale, in presenza di un’area pubblica che versa in evidente stato di dissesto, deve ritenersi sussistente un vero e proprio obbligo a provvedere al recupero della stessa.
L’obbligo di provvedere alla manutenzione dell’area pubblica, certamente sussistente, non può certo esimere le amministrazioni dal richiedere gli atti autorizzativi di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42 del 2004; in caso contrario si legittimerebbe qualunque intervento necessario anche se adottato in violazione dell'interesse pubblico di rango costituzionale alla preservazione del paesaggio.
1.6. Vero è che l’applicazione di una sanzione pecuniaria è esclusa nell’ambito del nuovo accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell’art. 36-bis del DPR n. 380 del 2001 qualora si tratti di opere eseguite da pubbliche amministrazioni. Nel caso da ultimo citato, però, si è in presenza di una deroga espressa, contenuta nell’art. 3, comma 2, del D.L. 69 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2024 (“Le disposizioni di cui all'articolo … 36-bis, ad eccezione dei commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) che è certamente norma di stretta interpretazione non applicabile al caso che occupa.
Né può ritenersi che nella specie difetti radicalmente l’alternativa tra la rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione e che, conseguentemente, la sanzione non dovrebbe essere in concreto irrogata, non sussistendo il criterio di commisurazione della sanzione.
L’autorizzazione paesaggistica “postuma” non esclude, infatti, né la sussistenza di un danno, né il conseguimento di un profitto, che evidentemente non è solo quello economico in senso stretto.
Proprio per questo motivo la norma prevede la necessità della perizia di stima.
L’appello deve essere conseguentemente respinto.
In considerazione della novità e della peculiarità della questione trattata, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere



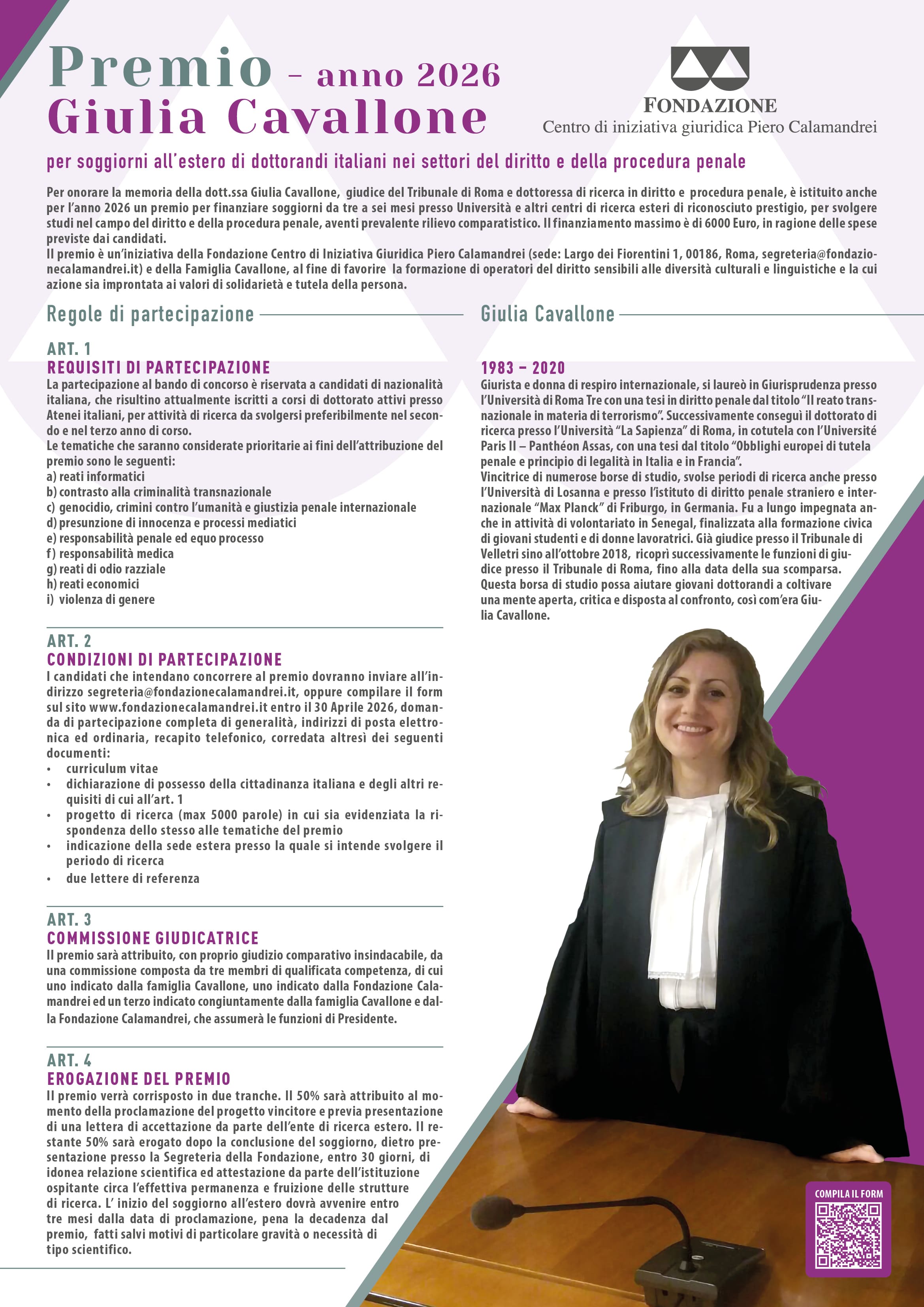 Scarica la locandina
Scarica la locandina

