 Cass. Sez. III n. 29543 del 18 agosto 2025 (UP 15 mag 2025)
Cass. Sez. III n. 29543 del 18 agosto 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Caputo
Rifiuti.Posidonia
I residui della posidonia depositati sulle coste e sugli arenili hanno una peculiare natura per essere, al contempo, risorsa di salvaguardia ambientale da un lato, e sostanza da assoggettare alla disciplina sui rifiuti, dall’altro. Da tale speciale connotazione deriva che tali accumuli, al pari di altri materiali spiaggiati, sono assoggettati alla disciplina statale in tema di rifiuti, che espressamente ne prevede l’esonero nei soli casi in cui gli stessi siano “trattati” in situ; disciplina che non può essere inficiata da una scelta normativa regionale.
RITENUTO IN FATTO
1. Vito Caputo, Giuseppe Corti, Edoardo Lannocca e Alfredo Borzillo ricorrono con separati atti a firma dei rispettivi difensori fiduciari per l’annullamento della sentenza del 17 luglio 2024 del Tribunale di Brindisi che ha dichiarato i primi tre colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81, 734 cod. pen., 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, 54, 1161 cod. nav. e li ha condannati alla pena di 6500 euro di ammenda; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vito Borzillo per il reato di cui all’art. 734 cod. pen. perché estinto per prescrizione e lo ha condannato alla pena di 4500 euro di ammenda per il residuo reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, 54, 1161 cod. nav.
2. Vito Caputo articola cinque motivi.
2.1. Con il primo deduce la carenza di motivazione in ordine alla propria responsabilità soggettiva e la violazione dell’art. 42 cod. pen. in ragione dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dei Consorzi di Bonifica.
Lamenta, in particolare, la mancanza manifesta della motivazione in ordine alla indicazione degli elementi di fatto e di diritto dai quali deriverebbe la propria responsabilità. Osserva, al riguardo, di aver depositato una memoria difensiva con la quale evidenziava la assenza di posizione di garanzia o di rappresentanza nel Consorzio del quale è dirigente posto che i consorzi di bonifica non sono considerati “enti locali” e i relativi dirigenti non hanno poteri di spesa, né di rappresentanza verso l’esterno (riservata dallo Statuto al Presidente), ma svolgono funzioni di dirigenza del personale. E dunque, il direttore generale del Consorzio di Bonifica non è un organo, non ha un autonomo potere di spesa, firma le delibere di presa d’atto in qualità di mero segretario verbalizzante (errato, dunque, il riferimento a tali firme quali fonti della propria responsabilità), non ha il potere di assumere determine dirigenziali, non ha potere, né capacità di sindacare il carattere di urgenza o meno delle situazioni nel loro manifestarsi, fornisce pareri squisitamente consuntivi, svolge la propria attività di controllo in qualità di capo del personale esclusivamente in materie attinenti trasferte, missioni e straordinari dei dipendenti.
Il Tribunale, pretermettendo i riferimenti normativi forniti in ordine al funzionamento dei Consorzio di Bonifica, ha affermato la sua penale responsabilità sulla base della mera, oggettiva posizione apicale da lui ricoperta.
2.2. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 considerata la natura temporanea del deposito di sabbia mista a posidonia (temporaneità contraddittoriamente esclusa e poi affermata dalla stessa sentenza) e la sua datazione (contraddittoriamente individuata dapprima in epoca incerta tra il 2014-2017 e poi nel 2018), laddove tale deposito risaliva al mese di aprile 2019 essendo stato realizzato in occasione di un evento metereologico eccezionale e per motivi urgenti e contingenti. Il medesimo vizio affligge la motivazione anche in ordine alla individuazione della tipologia del rifiuto, alle modalità della raccolta e del successivo smaltimento, non avendo il Tribunale considerato l’applicabilità al caso di specie degli artt. 183, lett. n), e 185 d.lgs. n. 152 del 2006 che escludono la applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 agli accumuli di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici presso il medesimo sito nel quale tali eventi li hanno depositati. Trattandosi, inoltre, di “accumuli antropici” ne va esclusa la natura di rifiuti dovendo essere qualificati piuttosto come “sottoprodotto” ai sensi dell’art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006.
2.3. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 1161 Cod. nav.
2.4. Con il quarto motivo deduce la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 734 cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo deduce la prescrizione dei reati maturata prima della sentenza impugnata.
3. Giuseppe Corti propone sei motivi.
3.1. Con il primo deduce la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sostanziandosi larga parte della motivazione nella trascrizione acritica di stralci delle deposizioni dei testimoni indicati dal Pubblico ministero e dalla difesa di Silvia Palumbo, dell’esame di quest’ultima e del coimputato Caputo Vito. L’affermazione che il cumulo di materiale composto da posidonia mista a sabbia è stato generato nel corso del tempo dal dragaggio del canale cosiddetto "canale a marea”, che collega il bacino con il mare in area demaniale, non trova fondamento negli atti processuali ed anzi é smentita dalle deposizioni dei testimoni Massimo Caputo, Maurizio Nuzzo e dalla numerosa documentazione prodotta dalla quale risulta che il cumulo in questione ha avuto origine in un'unica occasione a causa di un forte evento metereologico occorso nel 2019.
In alcun modo, aggiunge, è stato superato il limite annuo dei 30 m3; la motivazione è, sul punto, contraddittoria (perché in contrasto con le emergenze processuali) e in ogni caso mancante (perché apodittica e assertiva).
3.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 1161 Cod. nav. sotto il profilo della arbitrarietà della condotta e dunque dell’elemento soggettivo poiché l’intervento effettuato in occasione dell’evento metereologico già indicato nel primo motivo non è comunque ascrivibile al Consorzio e si trattava in ogni caso di intervento di somma urgenza per impedire l’allagamento del centro abitato sollecitato proprio da uno degli enti preposti alla tutela del demanio: la Capitaneria di Porto di Gallipoli.
3.3. Con il terzo motivo deduce la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 734 cod. pen.
3.4. Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. del reato di cui all’art. 734 cod. pen.
3.5. Con il quinto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
3.6. Con il sesto motivo deduce la prescrizione dei reati maturata prima della sentenza impugnata.
4. Edoardo Lannocca articola sei motivi.
4.1. Con il primo deduce l’erronea applicazione degli artt. 168-bis e 464-ter cod. pen. in conseguenza della mancata ammissione alla messa alla prova e la mancanza e l’illogicità della motivazione in ordine al rigetto della relativa istanza ingiustamente negata in considerazione della mancata prospettazione, in concreto, di effettive condotte riparatorie e per la persistenza delle conseguenze del reato, laddove il ricorrente non era e non è nella possibilità di rimuovere alcunché essendo egli in pensione dal 1 maggio 2021. Trattasi, aggiunge, di operazione complessa che spetta al Consorzio che si è attivato sin dal 2020 con la presentazione di un progetto per la destinazione del materiale al ripascimento di alcune zone del litorale per il quale l’ente è ancora in attesa dell’autorizzazione della Capitaneria di Porto nonostante i numerosi solleciti inviati.
4.2. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge reg. Puglia n. 17 del 10 aprile 2015 nonché la illogicità della motivazione rispetto alla definizione del cumulo sabbioso come “rifiuto”.
Premette di essere andato in pensione il 1° maggio 2021 (i fatti sono stati accertati l’8 febbraio 2022) e aggiunge che il ruolo da lui ricoperto (Capo Settore Tecnico e Rup del Consorzio di Bonifica “Ugento - Li Foggi”) non prevede alcun autonomo potere decisionale di iniziativa e di spesa essendogli stato affidato esclusivamente il compito di effettuare il sopralluogo e firmare i verbali di somma urgenza.
In punto di diritto sostiene che nel caso di specie non sussiste il deposito di rifiuti posto che:
(i) non è stato accertato da quanto tempo fosse stato depositato il materiale essendo la motivazione sul punto contraddittoria intrinsecamente ed estrinsecamente rispetto alle risultanze processuali;
(ii) le operazioni sono state compiute nel pieno rispetto della normativa di settore (le linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate di cui all’art. 6, lett. d, legge regionale n. 17 del 2015, cit., contenute nella determinazione del dirigente del servizio regionale Demanio e Patrimonio n. 229 del 22 giugno 2015) che la sentenza, pur richiamando, non pare osservare; in particolare, il Consorzio, in assenza di un protocollo di intesa condiviso tra gli Enti e nelle more della adozione del nuovo progetto per l’attività di disostruzione che consentisse lo spostamento degli accumuli ex situ, ha optato per una scelta imposta dalla normativa e dall’urgenza: l’apertura, cioè, di un varco nel canale e lo spostamento della sabbia sui lati del canale stesso ma nello stesso letto, senza spostamento ex situ come si evince dalla documentazione prodotta in sede dibattimentale; il Tribunale ha ritenuto di dare importanza al Progetto di disostruzione dei canali e per il riutilizzo della sabbia per il ripascimento di alcune aree che tuttavia non è mai stato attuato perché la Capitaneria di Porto, fino al giorno prima del sequestro, non aveva ancora autorizzato la consegna delle aree;
(iii) il materiale rinvenuto non è qualificabile come rifiuto, non trattandosi di deposito pluriennale bensì di pochi mesi, e non potendo l’azione del posizionamento essere considerata alla stregua del “disfarsi” di qualcosa; i materiali depositati erano inoltre di natura omogenea, erano stati ripuliti dai materiali antropici, non avevano comportato il degrado quantomeno tendenziale dell’area e non erano pericolosi.
4.3. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 734 cod. pen. e 54, 1161 Cod. nav., e la mancanza e la illogicità della motivazione sul punto non avendo il cumulo deturpato il paesaggio e difettando la natura arbitraria dell’occupazione.
4.4. Con il quarto motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva (la consulenza tecnica di parte dell’ing. Gregorio Raho) e la illogicità della motivazione dell’ordinanza dibattimentale che ne ha immotivatamente revocato l’ammissione.
4.5. Con il quinto motivo deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la omessa motivazione sul punto.
4.6. Con il sesto motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dei doppi benefici di legge.
5. Alfredo Borzillo articola sette motivi.
5.1. Con il primo deduce la violazione degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen., per essere stato condannato per un fatto (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) diverso da quello contestato (realizzazione di discarica non autorizzata).
5.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 178, lett. c), cod. proc. pen., 111, comma secondo, Cost., 6 CEDU per violazione del diritto al contraddittorio non essendo stata la diversa qualificazione del fatto preceduta dalla interlocuzione della difesa sul punto cui non è stata fornita questa possibilità.
5.3. Con il terzo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 nonché della legge reg. Puglia n. 17 del 2015 e il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza del reato oggetto di condanna.
La sentenza, lamenta, contiene affermazioni logicamente inconciliabili perché, da un lato sostiene che il cumulo di rifiuti si era formato per evitare l’allagamento del centro abitato durante un temporale, dall’altro che si sarebbe generato nel corso del tempo. Non è inoltre possibile, prosegue, collocare temporalmente la condotta essendo riportate in sentenza affermazioni contrastanti e incompatibili tra loro: in una parte si sostiene la retrodatazione del fatto al 2016, in altra la sua realizzazione a partire dal 2018 e negli anni successivi. E’ pacifico, però, che si operò in situazioni di somma urgenza (ne dà atto anche la sentenza) in base a delibere legittimamente adottate per evitare il pericolo all’incolumità pubblica derivante dall’ostruzione delle foci di Torre Mozza e Torre San Giovanni a causa del deposito di sabbia e posidonia, situazioni di urgenza acuite, in un’occasione, dalle avverse condizioni metereologiche.
Inoltre, prosegue, si tratta di condotta penalmente irrilevante siccome estranea al perimetro applicativo della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 trattandosi di sedimenti non pericolosi depositati nello stesso sito nel quale gli eventi li hanno accumulati. La stessa sentenza, sostiene, dà atto che lo spostamento degli accumuli fu effettuata in situ ma è poi imprecisa e contraddittoria quando sostiene che i rifiuti furono lasciati in deposito ben oltre i termini previsti per il loro definitivo smaltimento.
La sentenza è altresì intrinsecamente contraddittoria quando, da un lato sostiene che la somma urgenza fu gestita senza la prospettiva di uno smaltimento del rifiuto, dall’altro che le delibere commissariali si erano invece poste il problema della gestione del rifiuto stesso, ed è estrinsecamente contraddittoria perché in contrasto proprio con il contenuto di tali delibere.
Non sussiste, inoltre, il requisito dell’abbandono non essendosi il Consorzio mai disinteressato del cumulo di sabbia del quale era impegnato a trovare la corretta destinazione, progetto che si concretizzò nel 2020.
5.4. Con il quarto motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 54, 1161 cod. nav. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale e alla natura arbitraria dell’occupazione stessa.
5.5. Con il quinto motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato osservando che: a) i lavori dai quali furono originati gli accumuli erano stati appaltati con conseguente responsabilità della ditta appaltatrice; b) la colpa non può derivare dalla mera posizione formale di Commissario del Consorzio non essendo ammessa nel nostro ordinamento penale la responsabilità oggettiva da posizione; c) si è trattato di lavori disposti ed eseguiti in situazioni di urgenza; d) il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. ha connotazione dolosa.
5.6. Con il sesto motivo deduce la prescrizione del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 maturata prima della sentenza di condanna.
5.7. Con il settimo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 162-bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione osservando che il Consorzio sin dal 2020 aveva attivato una procedura volta alla soluzione del problema e non conclusa per ragioni a lui non imputabili.
5.8. Con l’ottavo motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dei doppi benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. I ricorsi sono fondati limitatamente al reato di cui all’art. 734 cod. pen. e alla mancanza di motivazione sulle richieste dei doppi benefici; sono infondati nel resto.
7. I ricorrenti erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati loro ascritti perché, nelle rispettive qualità, Vito Caputo di direttore generale del Consorzio di Bonifica “Ugento - Li Foggi”, Alfredo Borzillo di commissario del Consorzio, Giuseppe Corti di direttore dell’area tecnica, Edoardo Lannocca di capo del settore tecnico e Rup del medesimo Consorzio, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso posto in essere nel corso del tempo, agendo in concorso fra loro realizzavano, occupando un’area demaniale della superficie di circa 25 m2, una discarica abusiva effettuando attività di deposito al suolo di un ingente quantitativo, consistito in circa 80 m3 di posidonia mista a sabbia riveniente dalla disostruzione periodica delle foci del cd. “canale a mare” di Torre Mozza e Torre San Giovanni in agro di Ugento, deturpando così le bellezze naturali del “Litorale di Ugento”, luogo soggetto a speciale tutela dell’autorità in quanto sito tipizzato area SIC. Il fatto è contestato come accertato in Ugento l’8 febbraio 2022. Insieme con gli odierni ricorrenti era stata tratta a giudizio anche Silvia Palumbo, direttrice dell’area tecnica del Consorzio.
7.1. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha assolto Silvia Palumbo dai reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto e, riqualificato il reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, ha condannato gli odierni ricorrenti alle pene indicate nel § 1 del ritenuto in fatto.
7.2. La sentenza indica le seguenti prove utilizzate ai fini della decisione: a) la documentazione fotografica relativa agli atti irripetibili eseguiti dalla polizia giudiziaria; b) i verbali di somma urgenza; c) gli accertamenti tecnici eseguiti; c) le testimonianze del brigadiere della Guardia di Finanza, Massimo Caputo, nonché di Maurizio Nuzzo, direttore dell’area tecnica del consorzio; d) gli esami di Silvia Palumbo e Vito Caputo.
7.3. Sulla base delle informazioni tratte da queste prove, il Tribunale ha così ricostruito la vicenda:
7.4. l'8 febbraio 2022 la Guardia di Finanza, nel corso di un servizio in località Torre mozza del Comune di Ugento aveva notato un ingente quantitativo di posidonia e sabbia accumulata, verosimilmente, con l'ausilio di mezzi meccanici;
7.5. l'area era interamente recintata, vi era un cartello con dicitura "lavori in corso”, i luoghi erano in evidente stato di abbandono;
7.6. il materiale depositato consisteva in circa 80 m³ di sabbia mista a posidonia che occupava una superficie di circa 25 m² collocata vicino alle dune, sul lato sinistro e fronte mare del canale;
7.7. l'ingente quantitativo di materiale era stato depositato lungo gli argini del canale a seguito dei lavori di disostruzione della foce effettuati nel corso di diversi anni; tali lavori, in particolare, sarebbero risalenti agli anni 2015-2016, di qui l’affermato superamento dei tempi previsti per qualificare come temporaneo il deposito di rifiuti e la conseguente responsabilità nella gestione illecita del materiale depositato senza autorizzazioni;
7.8. in particolare, l’ufficiale di PG aveva accertato che non era mai stato redatto un piano di manutenzione ordinaria del canale che spesso veniva ostruito da questi cumuli di sabbia che venivano nel corso degli anni semplicemente tolti e depositati sul lato sinistro; questi interventi, ricostruiti dal pubblico ufficiale sulla base delle delibere commissariali di somma urgenza, venivano periodicamente fatti dal 2016 in poi e solo una parte dei rifiuti (posidonia) erano stati smaltiti presso centri autorizzati (il Tribunale indica anche le due imprese che avevano effettuato i lavori);
7.9. alla data del suo insediamento come responsabile dell'area tecnica del consorzio (1° gennaio 2020), Silvia Palumbo aveva già trovato presente un cumulo di materiale adiacente alla foce del canale che, secondo quanto dalla stessa riferita, si era formato per evitare l'allagamento del centro abitato durante un temporale, con l'acqua che non riusciva a raggiungere il mare;
7.10. l’imputata aveva altresì riferito di aver coordinato l'ufficio tecnico che si occupa della manutenzione dei canali consortili, affidamento di appalti e manutenzione ordinaria tramite il personale interno, di aver avviato un progetto per il riutilizzo del materiale in collaborazione con il Comune di Ugento e altri enti al fine del ripascimento di un tratto di litorale eroso e di aver avviato l’iter organizzativo per ottenere i necessari pareri;
7.11. il Tribunale ha dato altresì conto delle dichiarazioni di Caputo Vito che aveva riferito che il deposito del materiale costituiva una prassi consolidata per prevenire danni durante eventi di forte pioggia e aveva confermato che il materiale veniva temporaneamente rimosso dal canale e depositato accanto per garantire il deflusso dell’acqua; l’imputato aveva anche sostenuto che le sue funzioni erano quelle di capo del personale, di occuparsi solo di bilancio di previsione e di conto consuntivo, di non avere un potere di spesa autonomo, di aver firmato le delibere ma solo quale segretario privo di competenza tecnica;
7.12. Maurizio Nuzzo, che era succeduto a Silvia Palumbo, aveva riferito di aver riscontrato, alla assunzione dell’incarico di direttore dell'area tecnica con funzioni di coordinamento di tutte le attività tecniche del consorzio, la presenza di questi depositi di sabbia e posidonia accumulati per prevenire allagamenti durante i temporali; aveva altresì aggiunto di aver avviato progetti per utilizzare la sabbia e la posidonia per il ripascimento delle coste erose in collaborazione con il Comune di Ugento, progetto ereditato dalla Palumbo e che necessitava le autorizzazioni richieste per procedere con i lavori mediante l'uso dei finanziamenti destinati agli interventi straordinari; il testimone aveva precisato che l'autorizzazione allo spostamento del cumulo di sabbia era subordinata all'acquisizione delle aree di intervento ai sensi dell'articolo 34 Cod. nav., autorizzazione che alla data della testimonianza non era stata ancora rilasciata;
7.13. secondo il Tribunale, le attività effettuate successivamente al 2019 e al 2020 sono interventi di movimentazione in alveo della sabbia laddove quelli antecedenti non sono altrettanto chiari; fino al 2017 era in vigore un protocollo d'intesa in base al quale il Consorzio depositava in adiacenza al canale il materiale che poi veniva riutilizzato dal Comune per ripascere il cordone dunale retrostante; successivamente, scaduta la convenzione, il Consorzio ha continuato a utilizzare il sito per la collocazione del materiale pur in assenza di autorizzazioni;
7.14. in conclusione, «il cumulo di materiale composto da posidonia mista a sabbia, depositato con l'ausilio di mezzi meccanici nelle immediate vicinanze della foce del canale è stato generato nel corso del tempo dal dragaggio del canale cosiddetto "canale a marea" che collega il bacino con il mare in area demaniale» (pag. 6);
7.15. di qui la ritenuta sussistenza materiale del reato di deposito incontrollato di rifiuti, trattandosi di rifiuti speciali non pericolosi (CER n. 16.03.06), ancorché riutilizzati (almeno fino al 2017) mediante ripascimento sulla base della convenzione con il Comune di Ugento, depositati in maniera incontrollata al di fuori delle condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006; secondo il Tribunale risulta rilevante la mancata attivazione da parte degli organi competenti, per un lasso di tempo prolungato, delle procedure di smaltimento in discarica o della richiesta delle autorizzazioni amministrative atte al reimpiego dell'ingente materiale depositato, nel periodo intercorrente dalla scadenza della convenzione per il deposito del materiale estratto dal canale sino alla data di sequestro del sito.
7.16. Il Tribunale dà conto delle linee guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate (BVS) previste dalla legge reg. Puglia n. 17 del 10 aprile 2015 e attuate con determina regionale n. 229 del 22 giugno 2015, modificata con delibera di Giunta Regionale n. 822 del 2022, che stabiliscono un ventaglio di opzioni per la gestione delle biomasse tra le quali in particolare la posidonia.
7.17. L'opzione migliore è quella del mantenimento in loco delle BVS (lo spostamento in situ) che richiede l'individuazione di idonee zone, nell'ambito dello stesso arenile, nelle quali accumulare il materiale raccolto dalla battigia; gli accumuli devono essere ripuliti da ogni rifiuto di origine antropica periodicamente e prima dello spostamento.
7.18. Altra opzione è costituita dall'interramento in situ, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento delle BVS previa obbligatoria separazione dei rifiuti antropici; lo spostamento presso spiagge prossime al sito di origine o comunque all'interno della stessa unità fisiografica è possibile quando all'interno dell’arenile non si possano individuare aree nelle quali accumulare le BVS.
7.19. Altre opzioni praticabili sono la rimozione, il conferimento delle biomasse ad impianti di compostaggio, la reimmissione in ambiente marino, il riutilizzo a fini agronomici e, da ultimo, la rimozione permanente e la via di impianto di trattamento/smaltimento autorizzato.
7.20. Nel caso in esame, la soluzione di fatto prescelta dai responsabili del settore tecnico del Consorzio, con l'avallo dei vertici amministrativi, fu quella, in assenza di un progetto condiviso con gli altri enti competenti, dello "spostamento degli accumuli in situ" ovvero nel letto del canale o lungo gli argini dello stesso, ciò che ha comportato, già a partire dal 2018, un accumulo incontrollato di posidonia mista ad altro materiale, avente dimensioni assai estese, depositato in area sottoposta a vincolo SIC.
7.21. Quanto ai profili di responsabilità, il Tribunale ha affermato che Vito Caputo ha firmato tutte le delibere dal 2017 al 2020 insieme con il commissario, Alfredo Borzillo; in queste delibere si dà atto della necessità di intervenire per risolvere le problematiche relative all'ostruzione delle foci a causa del deposito di posidonia sulla base di quanto accertato dal capo settore dell'area tecnica e RUP, Edoardo Lannocca, dal direttore dell'area tecnica, Giuseppe Corti, mediante conferimento dell'incarico alle imprese individuate per la rimozione del materiale stesso.
7.22. In nessuna di queste delibere e dei verbali di accertamento di somma urgenza ad esse relativi si affronta la questione relativa alle modalità del deposito e gestione del materiale rimosso o dei costi occorrenti per il suo smaltimento così generando o comunque agevolando il deposito incontrollato.
7.23. E dunque, Caputo e Borzillo rispondono quali firmatari dei provvedimenti sopraindicati in considerazione della posizione apicale ricoperta, Corti e Lannocca in considerazione della funzione espletata, tutti in tal modo contribuendo alla causa del danno ambientale a ciascuno ascrivibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.
7.24. Il direttore generale ed il commissario, pur intervenendo solo ex post per approvare le spese e liquidare i lavori, già deliberati dai tecnici, rispondono dei reati loro scritti in considerazione dei poteri di spesa esercitati e delle funzioni di controllo al loro conferite dallo statuto.
7.25. Sussistono altresì i reati di cui all'articolo 734 cod. pen. e 1161 cod. nav. in considerazione del protrarsi a tempo indefinito del deposito dei rifiuti in area sottoposta a vincolo (trattandosi di sito di interesse comunitario), e della mancanza di concessione per la abusiva occupazione di una porzione del suolo demaniale.
8. Va preliminarmente ricordato che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). Di conseguenza, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Il compito del giudice di legittimità, infatti, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Nè la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. La Corte di cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) -, del codice di procedura vigente - era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 - 01). E’ dunque estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio; così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Caradonna, n.m. sul punto, in motivazione).
8.1. L’indagine di legittimità può estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietà della motivazione risulti da “atti del processo specificamente indicati” (cd. travisamento della prova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
8.2. Il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Spiega Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 - 01, che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. Come precisato in motivazione, «il vizio di "travisamento della prova" (o di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve assumere portata decisiva».
8.3. Inoltre, quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). E’ necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
8.4. In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova (ed il suo contenuto) quando se ne deduce il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.
8.5. Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga dedotto il travisamento della prova. La deduzione del vizio non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
9. Il ricorso di Vito Caputo.
9.1. Il primo motivo è infondato.
9.2. Ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. Testo Unico degli Enti Locali) le norme sugli enti locali previste dal testo unico si applicano, salvo diverse disposizioni, anche ai consorzi cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. I consorzi di bonifica hanno la natura di enti pubblici economici, perché, pur perseguendo finalità di ordine generale, operano con struttura imprenditoriale e criteri di gestione di tipo economici (Cass. civ., Sez. U, n. 191 dell’11/01/1997). Ne consegue che non si applicano ad essi le norme del TUEL per espressa affermazione dell’art. 2, cit.
9.3. Il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” è stato istituito nel 1958 ed è attualmente disciplinato dalla legge reg. Puglia n. 4 del 13 marzo 2012. L’art. 8, comma 1, qualifica i consorzi di bonifica come «persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, dotate di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che operano in conformità alle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità». Lo Statuto ne regola il funzionamento (comma 2). Organi dei consorzi di bonifica sono: a) l'Assemblea dei consorziati; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente; d) il Revisore unico (art. 24). Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente (art. 32); per il Consorzio “Ugento e Li Foggi”, l’aveva il Commissario (art. 42, comma 2).
9.4. Non si applicano, dunque, al direttore generale del Consorzio di bonifica le attribuzioni che gli artt. 107 e 108 TUEL riservano ai dirigenti e, in particolare, ai direttori generali degli enti pubblici non economici.
9.5. La funzione e i compiti del direttore generale del Consorzio vanno individuati altrove sulla scorta di presupposti normativi diversi che il ricorrente indica, oltre nella legge regionale citata, anche nello Statuto dell’ente il cui art. 53 attribuisce al direttore il (solo) diritto-dovere di partecipare alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.
9.6. Il Tribunale richiama l’art. 163 d.lgs. n. 150 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) che disciplina gli interventi di somma urgenza e attribuisce al responsabile del procedimento e al tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo il potere di disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità (comma 1). Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori (comma 4). Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata (comma 5).
9.7. Orbene, sostiene il Tribunale, «[è] vero che nel caso delle delibere di somma urgenza, il Direttore Generale ed il Commissario intervengono solo ex post per approvare le spese e liquidare i lavori, già deliberati dei tecnici ai sensi dell’art. 163 del T.U., ciò tuttavia non esclude la responsabilità degli organi apicali in considerazione dei poteri di spesa esercitati e delle funzioni di controllo e medesimi conferiti dallo statuto».
9.8. Il ricorrente se ne duole, infondatamente.
9.9. Egli sostiene: a) di non essere un organo; b) di non avere potere di spesa; c) di firmare le delibere di presa d’atto in qualità di mero segretario verbalizzante; d) di non avere il potere di assumere determine dirigenziali; e) di non avere alcun potere, né capacità (non essendo un tecnico) di sindacare il carattere di urgenza o meno delle situazioni nel loro verificarsi; f) di fornire pareri solo consuntivi; g) di svolgere la propria attività di controllo in qualità di capo del personale esclusivamente in materie attinenti trasferte, missioni e straordinari dei dipendenti. Nega, inoltre, di svolgere una funzione apicale.
9.10. Si tratta, come detto, di rilievi infondati ed in qualche modo anche contraddittori.
9.11. Il direttore generale, quale capo del personale, risponde anche dell’operato dei dipendenti del Consorzio ed in quanto tale la deduzione di non essere un tecnico e di non avere alcun potere di sindacare le situazioni di emergenza non regge alla considerazione critica che così ragionando egli appare un mero “passacarte” rispetto al titolare del potere decisionale. Se si può convenire che il direttore generale non possiede le competenze tecniche per stabilire se sussiste la situazione di somma urgenza che giustifichi l’adozione di una determinata soluzione, è altrettanto vero, però, che egli era perfettamente in grado di comprendere e di sapere se la situazione di “somma urgenza” legittimi, sul piano giuridico, la soluzione adottata dai suoi sottoposti sopratutto quando, come nel caso in esame, l’adozione di tali delibere avalli un modus operandi di gestione dei rifiuti protrattasi per più anni che esclude l’urgenza. Il Tribunale lo afferma con chiarezza: «in nessuno di tali verbali di accertamento di somma urgenza e relative delibere si affronta (…) la questione concernente le modalità di deposito e gestione del materiale rimosso, ovvero dei costi occorrenti per lo smaltimento dello stesso, generando ovvero agevolando così il deposito incontrollato di cui si è detto» (supra § 7.22).
9.12. Le considerazioni che precedono escludono la fondatezza delle deduzioni difensive relative alla insussistenza dell’elemento soggettivo del reato tutt’altro che ancorato alla sola posizione verticistica del ricorrente bensì alla sua funzione di garante della legalità del procedimento esitato con la delibera di ratifica dell’operato dei tecnici sottoposti.
9.13. Il secondo motivo è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge ed è altresì manifestamente infondato.
9.14. Le ampie considerazioni svolte nell’intero § 8 che precede spiegano le ragioni dell’inammissibilità delle argomentazioni di natura fattuale svolte dal ricorrente a sostegno della dedotta contraddittorietà estrinseca della motivazione e della affermata insussistenza del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. Il richiamo agli atti della “istruttoria dibattimentale” (dei quali, peraltro, non viene nemmeno dedotto il travisamento) per sostenere la genesi (nel 2019) e le ragioni (eccezionali ed estemporanee) dell’accumulo della posidonia e della sabbia si basa su una diversa lettura delle prove e un diverso accertamento del fatto che non sono consentiti in sede di legittimità e sono comunque irrilevanti. Né vi è alcuna contraddizione intrinseca nella ricostruzione della vicenda oggetto di scrutinio.
9.15. Non v’è dubbio, in primo luogo, che oggetto materiale della condotta ascritta ai ricorrenti sono rifiuti.
9.16. In termini generali, è noto, secondo la definizione data dall'art. 183, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 152 del 2006, nell'attuale formulazione, che deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi». Tale definizione rispecchia quella contenuta nella direttiva comunitaria di riferimento ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla previgente disciplina (d.lgs. n. 22 del 1997 e, ancor prima, d.P.R. n. 915 del 1982). E' altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine «disfarsi» ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli); di interpretare il verbo «disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti; di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit). Prescindendo dall'esaminare le diverse - note - posizioni, può qui rilevarsi come sia assolutamente certo che, secondo i principi generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912 - 01; Sez. 3, n. 2125 del 27/11/2002, Ferretti, Rv. 223291 - 01; Sez. 3, n. 48316 dell’11/10/2016, Lombardo, non mass.).
9.17. La posidonia costituisce rifiuto “urbano” ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter, n. 4, d.lgs. n. 152 del 2006 ed è sottratta dall’ambito di applicazione del decreto solo se, spiaggiata, sia reimmessa nell’ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana (art. 185, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 152 del 2006). La posidonia spiaggiata può essere utilizzata anche per la realizzazione dell’ammendante compostato verde, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compongono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% della miscela iniziale (allegato 5 al d.lgs. 29 aprile 2010, n 74 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88). L’ammendante compostato verde è una matrice organica destinata alla produzione di concimi organico-minerali come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. q ed r, d.lgs. n. 75, cit.).
9.18. L’art. 39, comma 11, d.lgs. n. 205 del 2010, stabilisce che «laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento».
9.19. Completa il quadro l’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 2006 secondo il quale «[n]on costituiscono attività di gestione dei rifiuti, le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse, mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati».
9.20. E’ opportuno, infine, ricordare che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva emesso due circolari (n. 8123 del 17 marzo 2006; n. 8838 del 20/05/2019) in materia di gestione della posidonia spiaggiata con cui sono state fornite, nel tempo, soluzioni flessibili legate anche alla specificità dei luoghi e delle relative situazioni sociali ed economiche. Tali soluzioni prevedevano:
1) il mantenimento in sito; soluzione ritenuta la migliore dal punto di vista ecologico e che deve essere perseguita nella maggior parte delle spiagge ed in particolare in quelle che si trovano in forte stato di regressione;
2) lo spostamento degli accumuli in zone appartate della stessa spiaggia dove la posidonia si è accumulata o in spiagge limitrofe particolarmente esposte all’erosione. Al fine di evitare che tale spostamento conduca alla realizzazione di vere e proprie strutture di deposito, i cd. accumuli “antropici”, è necessario - precisa la circolare del 2019 - che la movimentazione ed il relativo stoccaggio degli accumuli nelle zone prescelte sia momentaneo, ossia se ne preveda il riposizionamento sulla battigia della spiaggia di provenienza durante la stagione invernale, al fine di proteggere la costa dall’erosione;
3) l’interramento in sito (soluzione proposta dalla circolare del 2019) qualora ricorrano le condizioni di cui all' art. 39, comma 11, d.lgs. n. 205 del 2010 (supra § 9.18);
4) il trasferimento degli accumuli presso impianti di riciclaggio (soluzione indicata dalla circolare del 2019) per la produzione di ammendanti ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, cit. (supra § 9.17);
5) l’avvio in discarica (soluzione indicata da entrambe le circolari);
6) la re-immissione nell’ambiente marino che si configura come un’operazione di smaltimento, prevista dalla normativa comunitaria, e inserita nell’ordinamento nazionale tra le operazioni di smaltimento (Allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operazioni D6 e D7) e richiede una specifica autorizzazione con le relative prescrizioni. Più in particolare, l’articolo 195, comma 2 lettera p) del citato d.lgs. 152 del 2006 stabilisce che tale autorizzazione venga rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta dell’autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.
La circolare del 2019 prende in considerazione, come visto, i cd. “accumuli antropici”, definiti «ingenti accumuli di posidonia e sabbia sui quali hanno agito, nel tempo, fenomeni atmosferici che li hanno completamente trasformati. Tali accumuli, che non possono più essere rimovimentati per svolgere la loro naturale funzione di protezione dall’erosione, sono definiti “accumuli antropici”». Molto spesso - afferma il Ministero - «i processi di alterazione della componente organica sono spinti al punto tale che la sostanza vegetale è completamente mineralizzata. Gli accumuli si presentano quindi come ammassi di materiale prevalentemente sabbioso, almeno negli strati inferiori, frammisto a materiale antropico e spesso le amministrazioni ne prevedono l’impiego ai fini del ripascimento degli arenili. La possibilità di utilizzare il citato materiale inerte andrebbe opportunamente analizzata caso per caso dalle competenti autorità locali valutandola ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. 152/2006, in particolare verificando se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 comma 1 lettera b) o se il suo utilizzo debba avvenire nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani, individuate con codice R10 nell’Allegato C oppure applicando la disciplina dei sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/06».
9.21. E’ bene essere avvertiti del fatto che, trattandosi di circolari ministeriali, le relative soluzioni e proposte di gestione devono essere necessariamente valutate tenendo conto delle cogenti indicazioni che provengono dalla legge, ed in particolare dal d.lgs. n. 152 del 2006 e dalla normativa in materia di rifiuti. Si tratta di indicazioni operative che suggeriscono prassi virtuose non per questo sottratte alle norme che disciplinano i rifiuti sotto il profilo definitorio e gestorio.
9.22. La Regione Puglia ha adottato nel 2015, in attuazione dell’art. 6, lett. d), legge reg. Puglia 10 aprile 2015, n. 17 - Disciplina della tutela e dell’uso del territorio - linee guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate, aggiornate con delibera di Giunta Regionale n. 822 del 6 giugno 2022 (le menziona la sentenza) che recepiscono, in buona sostanza, le indicazioni delle citate circolari ministeriali del 2006 e del 2019.
9.23. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la disciplina di deroga prevista dall'art. 39, undicesimo comma, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (cit. in 9.18) è applicabile solo qualora venga positivamente dimostrata la sussistenza di tutti i presupposti da essa previsti e il relativo onere della prova grava su chi ne invoca l’operatività (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159 - 01). Ciò, del resto, in conformità all’indirizzo consolidato secondo il quale, in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto incombe su colui che ne invoca l’applicazione (Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024, Halili, Rv. 286345 - 01; Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839 - 01; Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784 - 01).
9.24. Il Giudice delle leggi spiega che «[l]e praterie di posidonia, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva n. 92/43/CEE, recepita in Italia con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono classificate tipi di habitat naturali prioritari, ossia tipi di habitat che rischiano di scomparire e per la cui conservazione la «Comunità ha una responsabilità particolare». Tali piante marine sono, inoltre, tutelate dal Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo (ASPIM), sottoscritto nell’ambito della Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento (Convenzione di Barcellona), ratificato con legge 27 maggio 1999, n. 175 (Ratifica ed esecuzione dell’Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995). Si tratta di atti normativi che perseguono, tra gli altri, l’obiettivo di salvaguardare gli ecosistemi marini, quali habitat che sono in pericolo di estinzione o che sono necessari per la sopravvivenza di specie animali e vegetali, nel cui ambito sono state inserite anche le praterie di “Posidonia oceanica”. Mentre per la pianta marina in esame è dunque apprestata una significativa normativa di tutela, nazionale e sovranazionale, non altrettanto può affermarsi per i suoi residui spiaggiati, i quali però svolgono una fondamentale funzione di conservazione delle coste e dei loro ecosistemi. È univocamente affermato, infatti, che le strutture lamellari (così dette banquettes) presenti lungo i litorali costieri – composte dagli accumuli delle foglie morte, dei rizomi e dei resti fibrosi della posidonia frammisti alla sabbia – svolgono un ruolo importante nella protezione dei litorali dall’erosione, in quanto ostacolano l’azione e l’energia del moto ondoso, contribuendo alla stabilità delle spiagge e della costa. In assenza di una specifica disciplina statale sulla gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, derivanti da piante marine o alghe – allo stato è all’esame del Senato della Repubblica il disegno di legge recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare», così detta “legge SalvaMare”, approvata dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2019 (A.S. n. 1571) – l’importante ruolo di protezione ambientale è oggetto di considerazione delle circolari del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), contenenti puntuali indicazioni volte a contemperare la rilevante funzione ecologica dei residui della posidonia con la necessità di rendere fruibili le spiagge; così da tutelare le esigenze turistico-ricreative dei concessionari demaniali, degli enti interessati e, comunque, della collettività in generale. Infatti, già la circolare prot. n. 8123 del 17 marzo 2006 aveva rilevato come la preferibile soluzione del mantenimento in loco della posidonia spiaggiata potesse spesso confliggere con l’esigenza di rendere usufruibili le spiagge ed aveva perciò indicato ulteriori soluzioni legate alla specificità dei luoghi. Accanto al mantenimento in situ degli accumuli quale opzione auspicabile nelle aree marine protette, aveva indicato lo spostamento di accumuli in zone meno frequentate della stessa spiaggia o in spiagge diverse, stabilendo che le modalità dello spostamento dovessero essere stabilite con provvedimento da adottarsi da parte degli enti parco o della Regione, sentiti i Comuni interessati. In presenza, poi, di una oggettiva incompatibilità tra gli accumuli dei residui di posidonia e la possibilità di utilizzo delle spiagge, nella menzionata circolare si era prevista anche la rimozione permanente ed il trasferimento in discarica. In merito alle possibili misure gestionali dei resti spiaggiati, poi, la recente circolare prot. n. 8838 del 20 maggio 2019, in aggiunta al mantenimento in loco o allo spostamento in zone della stessa spiaggia o in spiagge limitrofe, ha indicato ulteriori possibili rimedi. In particolare, si è previsto l’interramento in sito, ai sensi dell’art. 39, comma 11, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive); il trasferimento degli accumuli presso gli impianti di riciclaggio; la reimmissione in ambiente marino previa vagliatura volta a rimuovere eventuali rifiuti e la sabbia. Infine, e soltanto per impossibilità di ricorrere alle soluzioni descritte, la circolare ha indicato la soluzione del trasferimento in discarica. In sintesi, la disciplina sia della posidonia, come pianta marina, sia dei residui della stessa che il moto ondoso deposita sugli arenili ricade nella materia «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema», di competenza esclusiva del legislatore statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); la gestione di tali accumuli (…) è assoggettata, in particolare, alla disciplina dei “rifiuti”, quale prevista dal cod. ambiente (…) plurimi indicatori normativi concorrono univocamente a qualificare come “rifiuti” tali residui – accumuli di foglie morte e altri detriti vegetali – nel senso che si tratta di materiali, certamente rilevanti per l’ecosistema in ragione del loro impatto ambientale, ma che il legislatore statale, nell’esercizio della sua competenza esclusiva, assoggetta in particolare alla disciplina dettata dalla Parte quarta cod. ambiente, recante, tra l’altro, norme in materia di gestione dei «rifiuti». Va però precisato che la riconducibilità dei residui della posidonia alla nozione di «rifiuto» non ha quella connotazione negativa associata a tale termine nel linguaggio corrente, ma esprime solo la qualificazione giuridica da cui discende l’assoggettamento alla specifica regolamentazione dettata dal cod. ambiente per i “rifiuti”. Segnatamente rileva innanzi tutto l’art 183, comma 1, lettera b-ter), numero 4), cod. ambiente, secondo cui i rifiuti «di qualunque natura o provenienza, giacenti [...] sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua», costituiscono «rifiuti urbani», sì da ricomprendere a pieno titolo in tale definizione anche la posidonia spiaggiata. Inoltre, l’art. 39, comma 11, del d.lgs. n. 205 del 2010 – nel contesto quindi della disciplina europea dei rifiuti – prevede, espressamente per la posidonia spiaggiata, non diversamente che per le meduse che il moto ondoso deposita sugli arenili, una specifica norma, stabilendo che essa possa essere oggetto di interramento in loco «laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, […] purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento». Sicché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, se non sussistono tutte le condizioni previste da tale norma, non è possibile derogare alla disciplina sui rifiuti: il trasporto ed il deposito temporaneo della posidonia devono sottostare alla disciplina di cui alla Parte quarta cod. ambiente, dovendosi in mancanza ravvisare la sussistenza del reato di discarica non autorizzata (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 dicembre 2014-28 gennaio 2015, n. 3943). Già in passato la giurisprudenza aveva ritenuto, con riferimento alle alghe marine depositate sugli arenili, che il loro stoccaggio in assenza di autorizzazione configurasse il reato di cui all’art. 51, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), qualificando le alghe stesse come rifiuti urbani non pericolosi ex art. 7, comma 2, lettera d), del citato d.lgs. n. 22 del 1997 (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 marzo-12 aprile 2006, n. 12944). Rileva altresì l’art. 14, comma 8, lettera b-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha modificato l’art. 183, comma 1, lettera n), cod. ambiente, in riferimento alla definizione della attività non costituenti «gestione dei rifiuti» ai fini della applicazione della Parte quarta del medesimo codice. La disposizione statale ha aggiunto nella lettera n) dell’art. 183, comma 1, cod. ambiente, un ulteriore periodo secondo cui «[n]on costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati». Pertanto, con riferimento agli accumuli di posidonia, soltanto quando le indicate attività siano espletate in situ, non trova applicazione l’articolata disciplina sui rifiuti di cui alla Parte quarta cod. ambiente. Si è così ammessa una più spedita rimozione dei materiali portati dalle piene, dalle mareggiate o da altri eventi atmosferici rendendo più snelle le indicate operazioni, ma a condizione che siano effettuate presso il medesimo sito nel quale gli eventi hanno depositato i materiali, consentendo – come risulta dagli atti parlamentari – «l’utilizzo anche di soggetti non iscritti nell’ambito dei gestori ambientali», requisito necessario per lo svolgimento, tra le altre, delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ai sensi dell’art. 212 cod. ambiente. In definitiva, dal descritto contesto normativo e giurisprudenziale discende, dunque, che i residui della posidonia depositati sulle coste e sugli arenili hanno una peculiare natura per essere, al contempo, risorsa di salvaguardia ambientale da un lato, e sostanza da assoggettare alla disciplina sui rifiuti, dall’altro. Da tale speciale connotazione deriva che tali accumuli, al pari di altri materiali spiaggiati, sono assoggettati alla disciplina statale in tema di rifiuti, che espressamente ne prevede l’esonero nei soli casi in cui gli stessi siano “trattati” in situ; disciplina che non può essere inficiata da una scelta normativa regionale» (Corte cost., sent. n. 86/2021).
9.25. Successivamente ai fatti per i quali si procede è stata promulgata la legge 17 maggio 2022, n. 60 (cd. legge “SalvaMare”, richiamata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 86 benché all’epoca ancora in fase di approvazione) il cui art. 5 («Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate») così recita:
«1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall’autorità competente.
2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184 bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l’articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell’ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132».
9.26. Il legislatore prende in considerazione tre casi: 1) le biomasse vegetali (come definite dal primo comma); 2) gli accumuli antropici (come definiti dal secondo comma); 3) i prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica.
9.27. Le biomasse vegetali possono essere, alternativamente: (a) mantenute in loco; (b) trasportate, tal quali a impianti di gestione dei rifiuti; (c) reimmesse nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare in siti ritenuti idonei dall'autorità competente; (d) trasferite nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica; le operazioni di cui alle lettere c e d sono consentite solo previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile. Poiché l’art. 39, comma 11, d.lgs. n. 205 del 2010, non è stato abrogato, si deve ritenere che sia possibile anche l’interramento in sito, alle condizioni e nei termini indicati dalla norma.
9.28. Gli accumuli antropici possono essere recuperati previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico e alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica. Il recupero costituisce operazione che deve essere valutata caso per caso, potendo il (solo) materiale sabbioso: (a) essere escluso dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 ai sensi dell’art. 185 (la cui lettera f, come visto, indica le condizioni per l’esclusione della posidonia, non dei cumuli di sabbia, dal regime dei rifiuti); (b) essere riutilizzato nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia); (c) essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006 purché, ovviamente, soddisfi tutte le condizioni previste dalle lettere a, b, c e d, del comma 1 dell’art. 184-bis.
9.29. I prodotti costituiti di materia vegetale devono essere di provenienza agricola o forestale, devono essere depositati naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, e devono derivare dalle operazioni di gestione di cui all’art. 183, comma 1, lett. n, d.lgs. n. 152 del 2006; se ricorrono tutte queste condizioni il loro produttore è considerato “produttore di rifiuti” ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152 del 2006.
9.30. Non si è mancato di notare, in dottrina, che le operazioni di gestione delle biomasse disciplinate dalla cd. “legge SalvaMare” replicano le soluzioni dettate dalla circolare ministeriale del 2019 (anche se non è stata contemplata la soluzione dell’interramento) e di certo l’art. 5 della legge pone non pochi problemi di coordinamento con le norme contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006.
9.31. Una cosa, però, è certa: la “SalvaMare” non si applica al caso di specie, essendo legge successiva ai fatti, ma non si applicano nemmeno le norme che disciplinano la gestione della “posidonia spiaggiata” né quelle relative alla gestione delle “biomasse vegetali” che hanno in comune il medesimo presupposto: la loro formazione naturale che esclude qualsiasi intervento antropico nella loro genesi.
9.32. Nel caso di specie, invece, si tratta di operazioni di dragaggio, di cumuli di sabbia e posidonia prelevati cioè dalla foce del canale e collocati tal quali altrove senza alcuna operazione di vaglio.
9.33. Vengono dunque in rilievo le operazioni di cui all’art. 183, comma 1, lett. n), seconda parte, d.lgs. n. 152 del 2006, che non sono considerate attività di gestione dei rifiuti alla sola condizione che il deposito preliminare dei materiali e delle sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche se frammisti ad altri materiali di origine antropica, vengano effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale gli eventi li hanno prodotti.
9.34. Nel caso in esame, le operazioni di dragaggio della foce del canale si sono risolte, a partire dal 2017, nel puro e semplice deposito del materiale prelevato dal canale e accantonato per anni senza alcuna ulteriore operazione nemmeno di vagliatura e di certo non per il tempo tecnico strettamente necessario alla sua raccolta e trasporto altrove, laddove fino a quell’anno il materiale, in base ad un protocollo d’intesa con il Comune, era stato riutilizzato da quest’ultimo ente per il ripascimento del cordone dunale retrostante.
9.35. Si sostiene non trattarsi di rifiuti perché non abbandonati da un “detentore” che se ne sia disfatto (art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006).
9.36. Premesso quanto già illustrato al § 9.16 che precede, l’argomento non è convincente e si scontra con il dato letterale fornito, per esempio, proprio dall’art. 183, comma 1, lett. b-ter, n. 3 (rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, si pensi alle foglie degli alberi), lett. n (materiali e sostanze naturali, anche se non frammisti ad altri materiali di origine antropica), e dall’art. 185, comma 1, lett. f) (posidonia naturale).
9.37. Si verte, dunque, in una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti non qualificabile come temporaneo ai sensi dell’art. 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006 sul decisivo rilievo che i rifiuti stessi non sono stati avviati alle operazioni di recupero e smaltimento nei tempi stabiliti dal comma 2, lett. b), dell’art. 185-bis, secondo quanto risulta dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 8 e seg.: «risulta rilevante la mancata attivazione da parte degli organi competenti, per un lasso di tempo prolungato[,] delle procedure di smaltimento in discarica, ovvero della richiesta delle autorizzazioni amministrative atte al reimpiego dell'ingente materiale depositato, nel periodo intercorrente dalla scadenza della convenzione per il deposito del materiale estratto dal canale sino alla data del sequestro del sito»).
9.38. Il che comporta la irrilevanza delle questioni (fattuali) relative alla data di inizio del deposito essendo decisiva la circostanza che al momento del sequestro (8 febbraio 2022) era trascorso già più di un anno dal deposito stesso in violazione dell’art. 185-bis, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 152 del 2006.
9.39. Il terzo motivo è infondato.
9.40. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione di occupazione abusiva di spazio demaniale, è richiesta, in ragione della arbitrarietà che deve connotare la condotta, la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato (Sez. 3, n. 5168 del 21/12/2023, dep. 2024, Reale, Rv. 285943 - 01; Sez. 3, n. 37165 del 06/05/2014, Parisi, Rv. 260179 - 01; Sez 3, n. 29915 del 13/07/2011, Amati, Rv. 250666 - 01; Sez. 3, n. 18822 del 31/03/2011, Bianchi, Rv. 250010 - 01).
9.41. Il ricorrente esclude l’arbitrarietà della condotta (e dunque il dolo) di occupazione di suolo demaniale in considerazione della “somma urgenza” delle operazioni e per l’assenza di soluzioni alternative.
9.42. Si tratta di rilievi del tutto infondati.
9.43. La natura urgente delle operazioni cozza, come già osservato, con la sistematicità del ricorso alla disostruzione del canale e al deposito della posidonia mista a sabbia, laddove la mancanza di alternative è smentita dalla possibilità dello smaltimento mediante avvio in discarica individuata come possibile soluzione già con la circolare ministeriale del 2006.
9.44. E’ fondato il quarto motivo.
9.45. La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Pertanto non è sufficiente per integrare gli estremi del reato ne' l'esecuzione di un'opera ne' la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali. (Sez. U, n. 248 del 21/10/1992, dep. 1993, P.m. in proc. molinari, Rv. 193415 - 01; Sez. 3, n. 40267 del 03/10/2002, Pece, Rv. 222964 - 01; Sez. 3, n. 3247 del 30/10/2014, dep. 2015, Lanza, non mass.).
9.46. La realizzazione dell’intervento in zona sottoposta a particolare tutela ambientale non soddisfa, di per sé, i requisiti materiali del reato, essendo altresì necessario l’effettivo danno della bellezza protetta.
9.47. In disparte le inammissibili deduzioni fattuali, in diritto è vero che il Tribunale fonda la condanna per il reato di cui all’art. 734 cod. pen. ritenendolo sussistente per il sol fatto della realizzazione dei cumuli in zona protetta senza argomentare sull’effettivo deturpamento dell’area, non desumibile esclusivamente dal protrarsi dell’accumulo stesso in tempo indefinito (in questo senso, Sez. 3, n. 46992 del 09/11/2004, Giovannoni, Rv. 230424 - 01, secondo cui per la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen., non è necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, ma la condotta di deturpamento può anche essere successiva ad altri fatti, sempre che il giudice motivi adeguatamente in ordine al verificarsi della permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito; sul punto, anche Sez. 3, n. 40267 del 03/10/2002, Rv. 222964 - 01, cit., per la quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 734 cod. pen., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, non è sufficiente una qualsiasi alterazione naturalistica del sito in questione, ma è necessario che quella specifica alterazione incida sulla bellezza naturale, così che si realizzi quantomeno una lesione o anche un semplice turbamento del godimento estetico dei visitatori o utenti, anche potenziali, del luogo).
9.48. L’ultimo motivo è infondato.
9.49. Il reato di deposito di rifiuti ha, nel caso di specie, natura permanente (Sez. 3, n. 30929 del 10/04/2024, Duse, Rv. 286838 - 01; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632 - 01; Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini, Rv. 262410 - 01).
9.50. Come spiegato in motivazione da Sez. 3, Duse, cit. (cui il Collegio intende dare continuità), «[c]ostituisce approdo recente (e ormai consolidato) della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta (Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916 - 01; Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011 - 01; Sez. 3, n. 5478 del 18/01/2024, Fiorentino, non mass.; Sez. 3, n. 36003 del 12/07/2023, De Grande, non mass.; nel senso che il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura di reato permanente avuto riguardo alle circostanze del caso, Sez. 3, n. 36411 del 09/05/2019, Vitale, Rv. 277068 - 01). Il ricorrente evoca, a suo favore, l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, invece, il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, secondo comma del D.Lgs. 3 aprile 2005, n. 152) ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti (Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, Pinto Vraca, Rv. 258313 - 01; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 38977 del 07/04/2017, Alabiso, Rv. 271078 - 01). Nell’ambito di questo indirizzo, è stato precisato che i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene ovvero con la sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la cessazione della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 3, n. 38662 del 20/05/2014, Convertino, Rv. 260380 - 01, espressamente citata dal ricorrente insieme con la Sez. 3, Pinto). Sez. 3, Franceschetti, ha affrontato l’argomento richiamando l’orientamento per il quale il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente poiché, integrando la condotta da esso prevista una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero od allo smaltimento, la sua consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero (Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519 - 01; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632 - 01, che qualifica la condotta come deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini, Rv. 262410 - 01) e quello per il quale, invece, si tratta di reato istantaneo (…) E ha osservato che il contrasto deve essere considerato più apparente che reale essendo necessario verificare le concrete circostanze che connotino in maniera peculiare la presenza in loco dei rifiuti (nello stesso senso, Sez. 3, Vitale, cit.): «[o]gni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che costituisce il "grado zero"), la relativa illiceità penale permea di sé l'intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio; tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale. Nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento dei rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta condotta di abbandono (…) la verifica del concreto atteggiarsi della vicenda (…) è affidata al giudice di merito (…) [sicchè], senza con ciò esaurirne il novero, costituirà attendibile indice differenziale l'occasionalità o meno del fatto di abbandono e deposito del rifiuto, laddove la sistematica pluralità di azioni, fra loro di identico o comunque analogo contenuto, farà propendere per una forma di organizzazione della condotta, sintomo attendibile di una volontà gestoria e non esclusivamente dismissiva del rifiuto; mentre l'episodicità di esse, ancorché non rigorosamente intesa nel senso dell'assoluta unicità della condotta, dovrebbe indirizzare il giudizio sulla istantaneità della natura del reato posto in essere; altri indici rivelatori della finalità gestoria potranno essere la pertinenza, o meno, del rifiuto oggetto di rilascio, all'eventuale circuito produttivo riferibile all'agente, ove questi svolga attività imprenditoriale; oppure la reiterata adibizione di un unico sito, eventualmente anche promiscuamente utilizzato al medesimo fine pure da altri soggetti, quale punto di rilascio dei rifiuti (…) in tutti i casi in cui, in concreto, sia mancata una successiva fase di gestione e la collocazione del rifiuto ed altri dati oggettivi siano indicativi della mera volontà di liberarsene definitivamente, il disinteresse del detentore del rifiuto dopo la collocazione nel luogo in cui lo stesso viene rinvenuto determina una sostanziale coincidenza con la condotta tipica di abbandono, che si esaurisce nel momento stesso del rilascio; le ipotesi di condotta permanente restano del tutto residuali e l'apprezzamento del giudice effettuato nel caso concreto sulla base di dati obiettivi consente, se adeguatamente motivato, di pervenire ad una corretta soluzione. Anche la dottrina è pervenuta a conclusioni analoghe, osservando che se l'illecito si concretizza nell'abbandono del rifiuto, si configura un reato istantaneo con eventuali effetti permanenti: se il deposito incontrollato assume, di fatto, la conformazione di un rilascio definitivo nell'ambiente è, al pari dell'abbandono, un reato istantaneo con eventuali effetti permanenti; il reato è, invece, permanente ove l'agente pur non abbandonando il rifiuto ne mantiene la detenzione del rifiuto con modalità estranee a quelle conformi a legge, potenzialmente pericolose e la sua consumazione dura fintanto che non vengano a cessare le situazioni di fatto che integrano l'illecito (la regolarizzazione delle modalità di tenuta del deposito, la materiale rimozione dei rifiuti, anche ad opera di terzi, il compimento delle fasi di recupero o smaltimento dei medesimi)» (…) Il [ricorrente] pone l’interrogativo di come sia possibile qualificare un reato come istantaneo o permanente a seconda dell’atteggiamento soggettivo dell’autore della condotta prescindendo dall’interesse giuridico tutelato dalla norma e dalla cessazione della antigiuridicità del fatto e ribadisce, quanto a quest’ultimo aspetto, che il sequestro intervenuto nel 2004 aveva definitivamente fatto venir meno la antigiuridicità della condotta. Il rilievo non solo è infondato ma è anche mal posto. Secondo una risalente, ma mai superata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la nozione di reato permanente richiede che alla struttura tipica dell'illecito appartenga, secondo la descrizione contenuta nella norma incriminatrice, tanto la causazione del risultato proprio del reato che integra la fase consumativa primaria quanto il mantenimento volontario dello stato di antigiuridicità che ne è conseguito, attraverso cui si realizza una fase ulteriore della già avverata consumazione. Trattasi di ipotesi in cui il precetto penale presenta, alla analisi, un duplice contenuto: anzitutto il divieto o il comando di cagionare l'evento tipico descritto dalla norma; in secondo luogo il comando conseguenziale di rimuovere lo stato di antigiuridicità già prodottosi, sicché, ove l'autore della condotta non provveda immediatamente, pur potendolo, a farlo cessare, la fase consumativa della violazione permane fino a tanto che duri il predetto stato di antigiuridicità (Sez. U, n. 16 del 24/11/1956, Salomone, Rv. 097641 - 01; nel senso che la condotta che realizza il fatto tipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanente compressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quando si protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere di rimuovere provocando la riespansione del bene compresso, Sez. 5, n. 1787 del 05/10/2023, dep. 2024, Silvestri, Rv. 285842 - 01). E’ stato invece definito “eventualmente permanente” il reato nel quale il fatto previsto dalla legge può esaurirsi nel momento in cui si concretano gli elementi costitutivi della ipotesi tipica di reato, ma può anche protrarsi con una ininterrotta attività che in ogni momento riproduce l'ipotesi stessa (Sez. 1, n. 714 del 17/12/1992, dep. 1993, Daprea, Rv. 192800 - 01). L’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, punisce allo stesso modo l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti. Pur equivalenti ai fini della pena, le due condotte sono però diversissime e alternative tra loro: l’una, l’abbandono, si esaurisce in un gesto isolato che produce “res derelictae”; l’altra, il deposito, evoca comunque il persistente dominio sulle cose e ne esclude l’abbandono (che è cosa diversa dallo “stato di abbandono” che costituisce una delle possibili manifestazioni esteriori del deposito incontrollato). Entrambe le condotte costituiscono forme di smaltimento del rifiuto: l’abbandono comporta l’uscita definitiva della cosa dal dominio finalistico dell’autore della condotta; il deposito, invece, comunque lo si definisca (temporaneo, irregolare, controllato, incontrollato), reca in sé i segni dell’altrui dominio sulla cosa tant’è vero che il legislatore ne coglie il tratto finalistico quando lo considera legittimo solo se (e perché) finalizzato alla raccolta (purché nella costanza delle condizioni di cui all’art. 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006). Secondo l’italiano corrente, il verbo “depositare” significa “affidare, lasciare in deposito”, laddove il sostantivo “deposito” indica l’atto con cui si “depone un oggetto in un luogo o lo si affida a una persona, perché venga custodito e riconsegnato a un’eventuale richiesta o allo scadere di un termine prefisso”, o “il luogo dove vengono custodite le cose depositate o comunque di proprietà altrui o quello nel quale sono raccolte cose omogenee, e le cose stesse che vi sono raccolte”. Abbandonare, invece, significa “lasciare definitivamente e per sempre” un luogo, una cosa, una persona, oppure “smettere di fare o di occuparsi di una cosa, ritirarsi da un’impresa o dal luogo della competizione”. Il deposito può essere effettuato con un solo atto o con più condotte (nel senso che il deposito può avere natura eventualmente abituale, Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024, Halili, non mass. sul punto) ma quel che rileva è che il “deposito” reca in sé i segni del persistente dominio sulla cosa che manca del tutto nell’abbandono (significativamente, Sez. 3, Paglia, e Sez. 3, Cusini, qualificano il deposito come “controllabile”). La questione relativa all’atteggiamento soggettivo dell’autore del reato è dunque, come detto, mal posta perché il ricorrente non considera che l’interesse tutelato dall’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può essere leso o messo in pericolo con modalità diverse ognuna delle quali qualifica il reato come istantaneo o permanente a seconda che l’autore della condotta continui o meno a esercitare il dominio sul rifiuto; non si tratta di valorizzare, ai fini della prescrizione, l’elemento soggettivo del reato quanto piuttosto di attribuire al fatto la sua corretta qualificazione giuridica, operazione che non può prescindere, per le ragioni lessicali già spiegate, dall’accertamento della intenzione dell’autore della condotta, evocando, come detto, l’abbandono una volontà dismissiva del bene dalla signoria dell’agente che il deposito esclude. E’ un accertamento che compete al giudice di merito e che è insindacabile in sede di legittimità se argomentato in modo non manifestamente illogico e senza travisamenti di sorta. Il dominio, che costituisce elemento strutturale del deposito incontrollato, può certamente essere spezzato da un atto autoritativo che sottrae all’autore della condotta la disponibilità di fatto e di diritto dei rifiuti; sicché, come giustamente postula il ricorrente, il sequestro penale è idoneo a produrre un simile effetto che comporta la interruzione della permanenza del reato, non essendo più in grado l’autore di rimuovere lo stato di antigiuridicità già prodottosi».
9.51. Che nel caso di specie si tratti di deposito “controllabile” è incontestato e incontestabile come risulta chiaro anche dalla ragione del proscioglimento di Silvia Caputo, assolta per non aver commesso il fatto, non perché il fatto non sussiste. Il Consorzio, infatti, ha sempre mantenuto il dominio sui cumuli di rifiuti che ancora nell’aprile del 2020 ponevano l’irrisolto problema del loro definitivo smaltimento, problema alla cui soluzione si era (inutilmente) dedicata la Palumbo.
9.52. Qualificandosi, pertanto, la condotta come deposito "controllabile", la permanenza del reato cessa con lo smaltimento, il recupero, l'eventuale sequestro oppure con la sentenza di primo grado, se la contestazione è di natura aperta (nel caso di specie, con il sequestro dell’8 febbraio 2022).
9.53. La frazione di condotta attribuita a ciascuno degli imputati non ne vale a limitare, nel tempo, le rispettive responsabilità se tale condotta ha concorso a cagionare l’evento attuale. Il ricorrente confonde la condotta che ha dato causa all’evento antigiuridico (o comunque il momento nel quale la condotta ha assunto caratteri di antigiuridicità) con la cessazione della permanenza del reato, che è questione ben diversa.
9.54. Ne consegue che al fatto-reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, poiché consumato dopo il 1° gennaio 2020 si applica il nuovo regime di cui agli artt. 161-bis cod. pen. e 344-bis cod. proc. pen. con la conseguenza che: a) il corso della prescrizione, iniziato a decorrere l’8 febbraio 2022, è definitivamente cessato con la sentenza di condanna di primo grado (17 luglio 2024); b) il termine di durata massima del giudizio di legittimità (provvisoriamente fissato in un anno e sei mesi dall’art. 2, comma 5, legge n. 131 del 2021 per i ricorsi per cassazione proposti, come nel caso di specie, prima del 31 dicembre 2024) non è ancora decorso.
9.55. Le stesse considerazioni riguardano il reato di cui all’art. 1161 cod. nav., la cui natura permanente non è mai stata messa in discussione (per tutte, da ultimo, Sez. 3, n. 13576 del 13/02/2025, Magni, Rv. 287949 - 01).
9.56. Il reato di cui all’art. 734 cod. pen. (contestato, nella presente fattispecie, sotto il profilo della alterazione delle bellezze naturali) ha invece natura di reato istantaneo, ancorché con effetti permanenti (Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019, Schettino, Rv. 276359 - 01; Sez. 3, n. 36605 del 15/02/2017, Adinolfi, Rv. 270731 - 01; Sez. 2, n. 11226 del 04/07/1985, Bertani, Rv. 171199 - 01). Sicché, il Giudice rescissorio dovrà non solo accertare l’effettiva sussistenza del reato, ma anche la data della sua definitiva consumazione e ciò anche ai fini della individuazione del regime prescrizionale applicabile.
10. Il ricorso di Giuseppe Corti
10.1. Il primo motivo propone una diversa ricostruzione dei fatti basata su una (altrettanto diversa) lettura delle prove che non è ammessa in questa sede se non negli stretti limiti consentiti in caso di travisamento della prova (§§ 8.1-8.5), vizio nemmeno espressamente dedotto e comunque non supportato (sul piano formale-procedurale) dalla allegazione dei verbali delle relative prove.
10.2. Anche il secondo motivo sollecita una diversa valutazione delle prove. In ogni caso, valgano, al riguardo, le considerazioni già svolte in sede di esame del ricorso di Vito Caputo. Va ribadito che non rileva, al fine di escludere la “arbitrarietà” della occupazione, la “somma urgenza” del singolo intervento di disostruzione della foce ma la natura sistematica del ricorso ad una “prassi assolutamente condivisa” (così testualmente nel ricorso) che ha condotto alla realizzazione pluriennale di depositi di rifiuti nei termini illustrati dal Tribunale. La consapevolezza di agire in conformità alla legge non è argomento persuasivo sia perché si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti, sia perché l’intima convinzione di agire secondo legge non scusa (art. 5 cod. pen.) non venendo in rilievo nemmeno la cd. buona fede nelle contravvenzioni che costituisce argomento (fattuale, prima ancora che giuridico) nemmeno portato all’attenzione del Giudice di merito ed ormai precluso.
10.3. Per le stesse ragioni indicate in sede di esame del ricorso di Vito Caputo è fondato il terzo motivo, in esso assorbito il quarto (limitatamente al reato di cui all’art. 734 cod. pen.
10.4. Il quarto motivo è infondato.
10.5. Vero è che il Tribunale non si pronuncia in maniera espressa sulla richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., ciò nondimeno l’applicazione della pena pecuniaria (euro 6.000) in misura sensibilmente superiore al minimo edittale del reato considerato più grave di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs.n. 152 del 2006 (fissato in euro 2.600), il richiamo alla natura ingente dei cumuli di rifiuti, la pluriennale durata delle condotte, porta ragionevolmente a escludere che il Tribunale avesse ritenuto la minima offensività dei fatti.
10.6. Ed invero, l’assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 4, n. 27595 dell’11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01).
10.7. E’ fondato l’ultimo motivo.
10.8. A fronte della richiesta di applicazione dei doppi benefici, il Tribunale ha omesso qualsiasi spiegazione sulle ragioni del diniego, non evincibili nemmeno implicitamente dalla lettura della motivazione. L’omessa pronuncia sul punto non consente a questa Corte di sostituirsi al Giudice di merito non possedendo gli strumenti di valutazione nel merito sulla meritevolezza di entrambi i benefici che, come detto, non è desumibile nemmeno dalla lettura della sentenza. Anche l’orientamento più “possibilista”, pure invocato a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, esclude che la Corte di cassazione possa decidere direttamente ed immediatamente a favore dell’applicazione dei benefici quando nella motivazione non vi siano elementi utili di giudizio (così, da ultimo, Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114 - 01).
10.9. Anche per questa ragione si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
11. Il ricorso di Edoardo Lannocca.
11.1. Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente lamenta l’ingiusto diniego della ammissione all’istituto della messa alla prova perché motivato con la mancata prospettazione di effettive e concrete condotte riparatorie e per la persistenza degli effetti dannosi dei reati. Sostiene, al riguardo, l’impossibilità di rimuovere le conseguenze del reato sia perché in pensione dal mese di maggio 2021, sia perché si tratta di operazione complessa che spetta al Consorzio «secondo un iter articolato che vede l'interazione di più Enti e Autorità ed il rilascio di pareri e autorizzazioni da parte di questi. Iter che è in corso dal marzo 2020, allorquando fu presentato un Progetto per l'uso del materiale di ripascimento di alcune zone del litorale, per il quale il Consorzio è ancora in attesa dell'autorizzazione della Capitaneria di Porto, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della Navigazione, nonostante i numerosi solleciti inviati».
11.2. Il rilievo non coglie nel segno. Quando l’imputato abbia concorso a cagionare l’evento non può addurre l’impossibilità di eliminarne le conseguenze dannose o pericolose, costituendo tale eliminazione requisito imprescindibile dell’istituto laddove solo il risarcimento del danno è subordinato alla effettiva possibilità del risarcimento stesso. Il tenore letterale dell’art. 168-bis cod. pen. è chiaro nella parte in cui afferma in maniera perentoria che la messa alla prova «comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato». Sicché l’impossibilità di eliminare le conseguenze del reato, peraltro dovuta proprio alla condotta dell’imputato, non costituisce argomento di per sé valido.
11.3. Il secondo motivo è infondato per le ragioni ampiamente esposte in sede di esame del ricorso di Vito Caputo. Le ragioni della affermazione della penale responsabilità dell’imputato sono state illustrate dal Tribunale (supra §§ 7.21-7.23) con argomenti che non sono manifestamente illogici e che non possono essere soverchiati mediante inammissibili allegazioni fattuali ed in assenza di travisamenti di sorta nemmeno dedotti (supra §§ 8 e segg.). Quanto alla natura di rifiuto del materiale accumulato negli anni all’esito di operazioni di disostruzione della foce del canale si rimanda pure a quanto già ampiamente illustrato in sede di esame del ricorso di Vito Caputo.
11.4. Il terzo motivo è fondato limitatamente al reato di cui all’art. 734 cod. pen. per le stesse ragioni indicate in sede di esame dell’analogo motivo del ricorso di Vito Caputo; non lo è quanto al reato di cui all’art. 1161 cod. nav.
11.5. Il quarto motivo è inammissibilmente generico.
Non v’è dubbio che il termine di cui all’art. 501, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen. ha natura ordinatoria non essendo espressamente prevista, come conseguenza della sua violazione, la decadenza dalla prova richiesta (art. 173, comma 1, cod. proc. pen.).
Il termine libero di sette giorni prima dell’udienza fissato per l’esame del consulente (o del perito) è stato introdotto dal legislatore della riforma Cartabia (art. 30, comma 1, lett. b, nn. 1 e 2, d.lgs. n. 150 del 2022) per «consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato, e dunque, consapevole ed efficace, sulla prova scientifica» (così la Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo delegato che ha altresì spiegato le ragioni della scelta «di non introdurre alcuna sanzione per il tardivo od omesso deposito della relazione tecnica, ritenendo che lo stesso non possa pregiudicare la validità dell’esame orale del perito o del consulente tecnico»).
La violazione del termine, dunque, non giustifica la revoca della prova ammessa ma può, semmai, pregiudicare l’effettività (e la pienezza) del contraddittorio in caso di deposito tardivo della relazione scritta del consulente poi esaminato.
In ogni caso: a) la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignogna, Rv. 269050 - 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 - 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257892 - 01); b) il ricorrente non afferma (né risulta dalla lettura del verbale) di aver immediatamente dedotto la nullità dell’ordinanza; c) il ricorrente non spiega nemmeno quale incidenza avrebbe avuto la prova omessa sul tessuto motivazionale della sentenza impugnata, in che termini, cioè, avrebbe potuto anche solo astrattamente comportare una possibile determinazione diversa sulla sussistenza dei fatti e/o sulla propria responsabilità.
11.6. Il quinto motivo è infondato per le ragioni già indicate in sede di esame dell’analogo motivo dedotto da Giuseppe Corti.
11.7. E’ invece fondato l’ultimo motivo avendo il Tribunale letteralmente omesso di spiegare le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena ritualmente richiesto dal ricorrente.
12. Il ricorso di Alfredo Borzillo.
12.1. I primi due motivi sono manifestamente infondati.
12.2. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 516, 518, 521 e 522 cod. proc. pen., deve essere ribadito il principio secondo il quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619).
12.3. Si è così ritenuto che non contrasta con il principio in questione la condanna per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti a fronte di un'imputazione di discarica non autorizzata (Sez. 3, n. 12443 del 11/02/2010, Coculo, Rv. 246458; Sez. 7, n. 9562 del 17/02/2023, Fanciullacci, non mass.; Sez. 7, n. 16569 del 16/11/2017, dep. 2018, Rocco, non mass.; Sez. 3, n. 47386 del 30/09/2014, Firinu, non mass.; Sez. 3, n. 37843 del 20/05/2014, Laccetti, non mass.; Sez. 3, n. 7606 del 24/10/2012, Agrosì, non mass.; per un caso analogo, cfr. anche Sez. 3 n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871, in tema di discarica abusiva in cui è stata ritenuto irrilevante l'intervento modificativo in senso favorevole all'imputato consistente nella riduzione quantitativa dei rifiuti oggetto dell’imputazione).
12.4. Sotto altro profilo, deve essere ribadito l’indirizzo assolutamente consolidato della Corte di cassazione secondo il quale la possibilità per l’imputato di esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione esclude qualsiasi violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204 - 01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135; Sez. 6, n. 24631 del 15/05/2012, Cusumano, Rv. 253109).
12.5. Va altresì ricordato che l'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01).
12.6. Il ricorrente, che pure ha tratto beneficio dalla qualificazione del fatto in termini per lui più favorevoli, non spiega quali conseguenze concretamente pregiudizievoli siano derivate dalla dedotta lesione del suo diritto di interloquire su tale diversa qualificazione, se ed in che modo essa apparisse totalmente imprevedibile e avulsa dal regolare sviluppo del processo e dalla descrizione dei fatti con esso accertati.
12.7. Il terzo e il quarto motivo, al netto delle inammissibili deduzioni fattuali (e relative allegazioni probatorie delle quali non viene dedotto il travisamento), sono infondati per le stesse ragioni già illustrate in sede di esame del ricorso di Vito Caputo.
12.8. Il quinto motivo è anch’esso infondato.
12.9. Il ricorrente, all’epoca Commissario del Consorzio, sostiene che: a) la responsabilità dell’abusiva gestione dei rifiuti era esclusivamente delle ditte appaltatrici incaricate di effettuare i lavori di disostruzione e pulizia del canale; b) non è possibile estendere tale responsabilità nei suoi confronti in virtù del solo ruolo apicale ricoperto ed in assenza di profili di colpa trattandosi di interventi di somma urgenza eseguiti ai sensi dell’art. 163 d.lgs. n. 50 del 2016; c) la contravvenzione di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav. ha natura dolosa.
12.10. Si tratta di rilievi infondati alla luce di quanto già affermato in sede di esame dei precedenti ricorsi. Va qui solo ribadito che l’argomento legato all’urgenza degli interventi di disostruzione e pulizia del canale non regge di fronte alla natura sistematica e pluriennale di tali interventi proseguiti anche dopo la scadenza della convenzione con il Comune di Ugento. La natura sistematica di tale modus operandi riconduce le condotte al pieno, consapevole e volontario dominio del Consorzio e di chi all’epoca lo rappresentava il quale non può, oggi, allegare l’esclusiva responsabilità delle ditte di volta in volta incaricate di eseguire gli interventi quasi, oltretutto, a sminuire l’importanza del ruolo di garante della legalità del procedimento che gli competeva in sede di ratifica ex post dell’altrui agire. Ché anzi, proprio perché l’intervento del Commissario era postumo, egli aveva la possibilità di verificare che, come annotato dal Tribunale, in nessuno dei verbali di accertamento di somma urgenza e relative delibere si affrontava la questione della modalità del deposito e dello smaltimento dei rifiuti. Come si è già detto in sede di esame del ricorso di Vito Caputo, le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici, incluse mareggiate e piene, non costituiscono attività di gestione dei rifiuti solo se effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario alla successiva raccolta e gestione del rifiuto e presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati (art. 183, comma 1, lett. n, seconda parte, d.lgs. n. 152 del 2006).
12.11. Il sesto motivo è infondato per le stesse ragioni indicate in sede di esame del ricorso di Vito Caputo.
12.12. Premesso che nei confronti del ricorrente è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 734 cod. pen. perché estinto a seguito di oblazione (ordinaria), il settimo motivo è infondato.
12.13. Ribadita la possibilità di impugnare l’ordinanza che rigetta la domanda di oblazione esclusivamente con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 35550 del 26/04/2017, Lucciola, Rv. 271137 - 01; Sez. 4, n. 34667 del 22/06/2010, Canova, Rv. 248081 - 01) il ricorrente, all’epoca di adozione dell’ordinanza di rigetto, non aveva oggettivamente eliminato le conseguenze dei residui reati a lui ascritti. Peraltro non risulta, né il ricorrente lo deduce, che la domanda di oblazione sia stata riproposta prima dell’inizio della discussione (art. 162-bis, quinto comma, cod. pen.; Sez. 3, n. 43770 dell’11/10/2012, Bua, Rv. 253608 - 01). La dedotta contraddittorietà della motivazione che il ricorrente imputa alla sentenza (nemmeno all’ordinanza) si avvale, nel suo argomentare, del richiamo ad elementi tratti dall’istruttoria, sicché gli elementi oggi indicati a sostegno dell’impegno del ricorrente a eliminare le conseguenze dannose o pericolose dei residui reati avrebbero dovuto (e potuto) essere fatte valere prima della discussione alla luce, appunto, dell’istruttoria svolta. Peraltro, il motivo di doglianza sembra riguardare la sentenza e non l’ordinanza di rigetto della domanda di oblazione, rendendo oltremodo confuso e contraddittorio il motivo stesso. Ed invero, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza (insieme con la sentenza) deducendo vizi propri dell’ordinanza stessa, la cui contraddittorietà non può essere fatta valere attingendo ad elementi dell’istruttoria dibattimentale quali risultano dalla sentenza, elementi che, semmai, potevano giustificare la reiterazione della domanda prima dell’inizio della discussione.
12.14. L’ultimo motivo è invece fondato per le stesse ragioni già indicate in sede di esame dei ricorsi di Edoardo Lannocca e Giuseppe Corti.
13. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Caputo Vito, Corti Giuseppe e lannocca Edoardo limitatamente al reato di cui all'art. 734 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica. Deve essere altresì annullata nei confronti di lannocca Edoardo, Corti Giuseppe e Borzillo Alfredo limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione dei doppi benefici con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica. I ricorsi devono essere rigettati nel resto, con declaratoria di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati diversi da quello di cui all’art. 734 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Caputo Vito, Corti Giuseppe e lannocca Edoardo limitatamente al reato di cui all'art. 734 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di lannocca Edoardo, Corti Giuseppe e Borzillo Alfredo limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione dei doppi benefici con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per i residui reati.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.



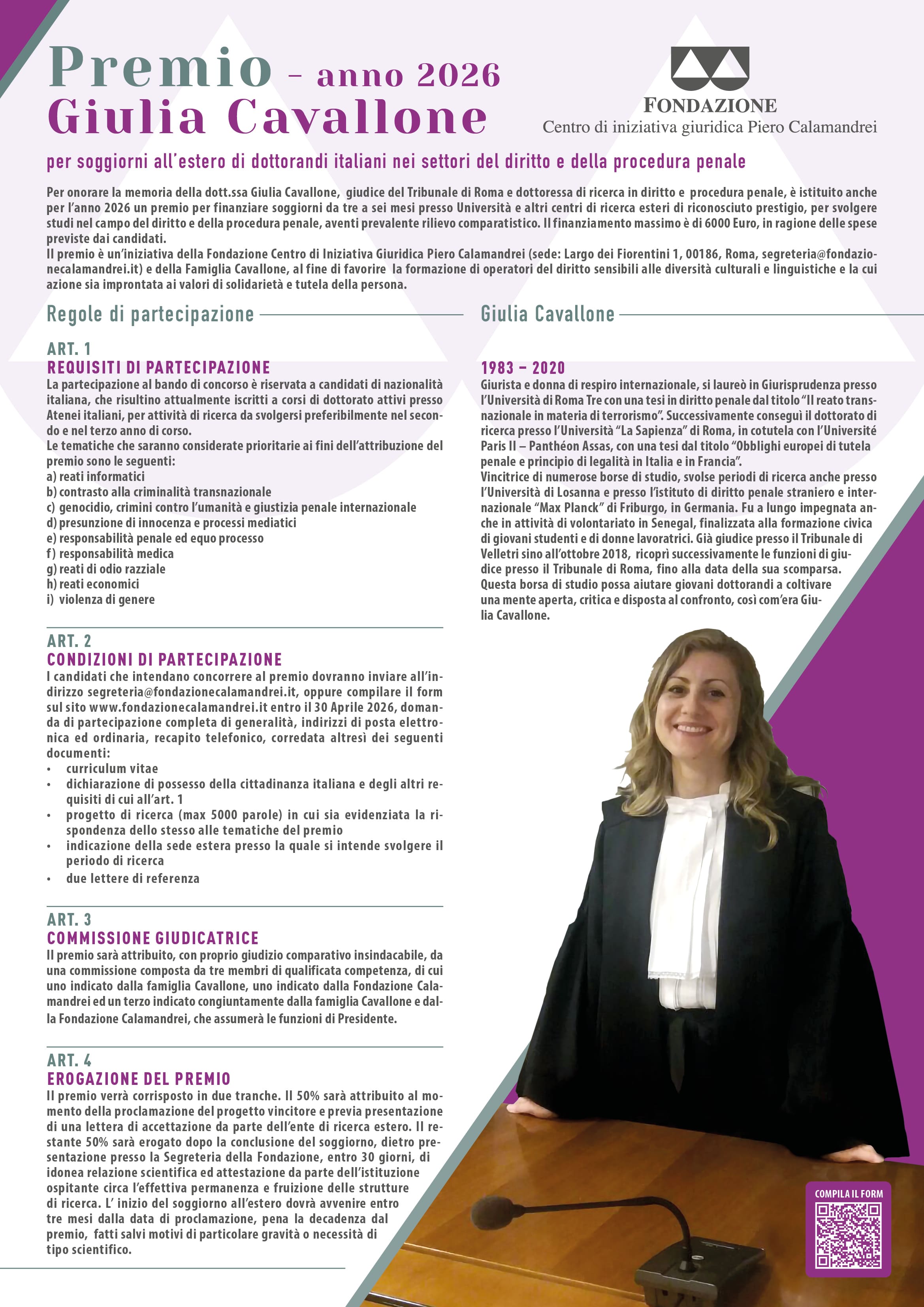 Scarica la locandina
Scarica la locandina

